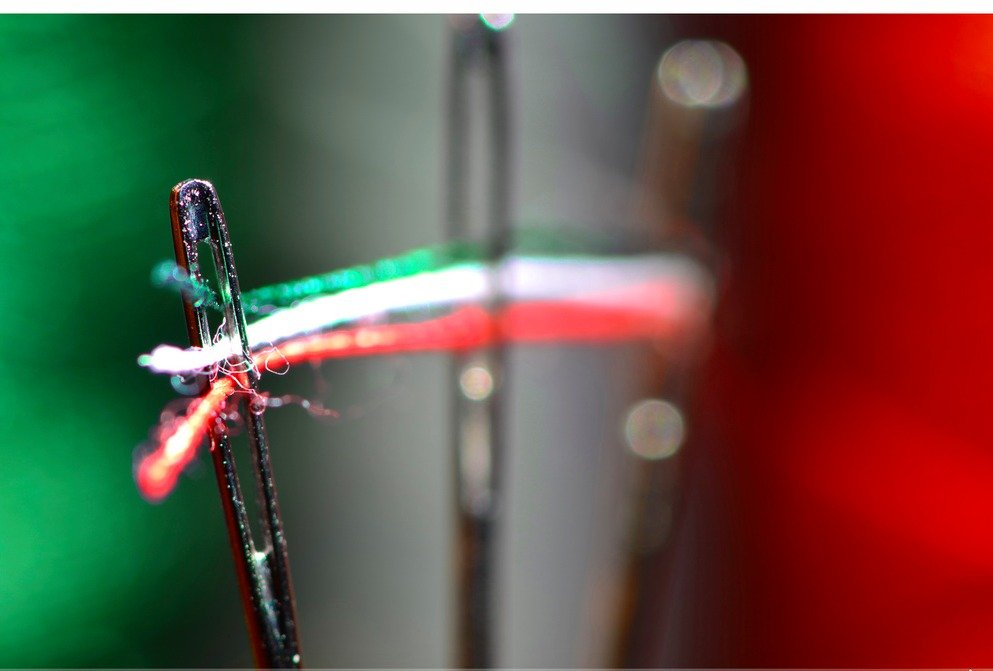È nella ricerca di un nuovo gioco di forze tra pubblico e privato che l’Italia potrebbe mettersi in corsa sui mercati internazionali. Serve però essere onesti e guardare ad alcuni conflitti culturali interni, invisibili agli occhi della politica e dell’informazione.
L’Italia è un paese che non parla inglese, basterebbe già solo questo per comprendere a fondo le posizioni di Fernando Napolitano, Presidente di Italian Business & Investment Initiative e autore insieme a Mark Gerencser, Reginald Van Lee e Christopher Kelly di “Megacommunities”, un libro che contiene proposte per identificare le priorità e gli interessi delle Comunità, identificare i soggetti coinvolti e trovare soluzioni condivise per lo sviluppo.
Partiamo dalla madre dei problemi a livello internazionale: l’Italia non parla inglese e la sua politica non comunica con il mondo.
“Nel 2003, il business praticava l’off-shoring per massimizzare i profitti sfruttando le opportunità della globalizzazione e, in particolare della Cina. La politica, non comprendendo il senso del business e prigioniera del consenso elettorale, ha perso il potere di attrazione di talenti e la capacità di intermediare tra interessi contrastanti. Questo vuoto è stato colmato dalle ONG che però rispondono altrettanto a interessi di parte. L’avvento di Internet, infine, ha messo sul tavolo un’informazione “à la carte” senza che questa venga validata, creando spesso dogmi errati. Questa alterazione delle sfere di competenze e’ un tratto comune a tutti i Paesi occidentali, non appartiene solo all’Italia. Basta guardare, su tutto, agli aspiranti candidati alla Casa Bianca o a Francia e Inghilterra che non esprimono nessun fuoriclasse.
L’Italia, inoltre, ha un problema in più: non parla l’inglese.
Nel 2016, come nel 2003, non ha un mezzo di comunicazione autorevole in inglese. Ieri come oggi, i suoi araldi sono il Financial Times, The Economist, il New York Times e il Wall Street Journal. Ieri come oggi, l’Italia non partecipa al dibattito su se stessa. Delega, ieri come oggi. Il dramma è che questo non è ancora riconosciuto dalle élite come il problema principale da risolvere se si vuole competere nel mondo. Molti sono rimasti sorpresi che la Spagna abbia superato l’Italia nel turismo. Lo spagnolo è però la prima lingua parlata nelle Americhe.
L’Italia non partecipa al dibattito su se stessa perché non ha un mezzo di prestigio multipiattaforma in inglese dall’Italia, poco importa se video o web. Questo è il vero vuoto strategico che ancora non viene considerato come problema”.
Quali sono le verità taciute su come l’Italia non muove affari?
“La mancanza di informazione crea una retorica che offusca la realtà delle reali dinamiche tra Italia e Stati Uniti. L’interscambio, per fare un esempio, è marginale: solo il 7% del nostro export va nella loro direzione, poco più di 40 miliardi di dollari l’anno contro i 135 miliardi di dollari della Germania. Gli investimenti diretti esteri sono al lumicino, la gravitas italiana nei luoghi che contano di New York, con l’eccezione dell’ENI, è un ossimoro. Ma non bisogna dimenticare che New York è la capitale del mondo della finanza, dei fondi che comprano il debito italiano e le azioni delle aziende quotate. È lì che sono presenti i maggiori think-tank e le ONG che influenzano il Congresso il quale, a sua volta, incide sullo scenario geopolitico internazionale. Si parla impropriamente di crisi o di declino dell’Italia, non è affatto così.
L’Italia è in una fase di assestamento, sta pagando il conto degli abusi sul debito pubblico che ha illuso generazioni a suon di debito non sostenibile. Quindi quello che oggi vien chiamato declino e’ un alibi per non ammettere che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi e oggi non è più possibile, non dimentichiamo che lo abbiamo fatto anche prima dell’euro con la svalutazione competitiva della lira. Se un Paese ha un debito come quello italiano, tipicamente è il risultato di una guerra e di un programma di investimenti straordinario, ma i nostro non deriva da nessuno di questi due motivi. Ce l’ha perché ha favorito un modello di sviluppo economico senza selezione e senza qualità”.
Per governare i processi di globalizzazione lei propone il concetto di Megacommunities: in cosa consiste?
“Assieme ad un gruppo di professionisti anni fa ci ponemmo il problema della gestione della società post-globalizzata che a breve si sarebbe materializzata. Oggi, nelle società, assistiamo a situazioni reali e quotidiane dove convivono conflitto e mancanza di visione, dove le tradizionali sfere di influenza e di competenza – politica, business, società civile—sono del tutto alterate. E questo anche perché come dicevo assistiamo al primato sulla politica delle aziende, globali o regionali, che concentrano il capitale umano, i talenti, le risorse.
Il privato è forte, il pubblico è debole. Il gruppo di lavoro al quale ho partecipato ha lanciato nel 2008 un nuovo modello di gestione coerente con lo scenario: la Megacommunity. Una sfera pubblica in cui le organizzazioni e le persone, insomma i portatori di interessi, dopo aver analizzato tutti i dati a disposizione di un problema concreto (pensiamo ai big data), che sia di reciproco interesse e sistemico, convergono per risolverlo. Occorre sempre avere un cosiddetto leader initiator, una figura che dia il ” la” e convinca le parti proponendo un piano di azione”.
In una società globalizzata chi deve prendere le decisioni: i cittadini, la politica o i movimenti globali?
“Partiamo da un presupposto: la politica si è involuta. Dopo aver legiferato all’interno dell‘Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per favorire il commercio globale, la politica è diventata una spettatrice distante e sembra che recepisca in maniera passiva i processi della globalizzazione, non li comprende e li indirizza senza cognizione. Questi fenomeni non si riferiscono solo all’Italia ma sono comuni a tutto il mondo occidentale.
Il vero punto da evidenziare è che per la prima volta nella storia di tutte le globalizzazioni, negli ultimi 20 anni i grandi processi sono stati guidati non dagli eserciti ma dalle Corporation che hanno attratto il meglio del capitale umano, cosa che la politica non è stata in grado di fare”.
Le imprese italiane si sentono spesso disorientate senza una credibilità internazionale dell’Italia. Cosa potrebbe cambiare per loro con la logica della Megacommunity, che hanno nella scalabilità del progetto uno dei veri punti di forza?
“È necessario riposizionare l’Italia nel business che conta per favorire investimenti nelle due direzioni e per dare all’Italia lo standing che merita accreditandola anche come un Paese high-tech. Per far questo è nato nel 2011, a New York, l‘Italian Business & Investment Iniviative (IB&II).
A fare la differenza sono certamente la scalabilità dei programmi proposti, grazie a cui si crea il link tra giovani brillanti e aziende così da attivare un motore di reale cambiamento attraverso il business, e la presenza di grandi aziende italiane e banche internazionali che condividono lo spirito del progetto.
Si tratta di una piano articolato in tre punti: borse di studio (BEST), un programma di accelerazioni per startup italiane e un summit annuale dedicato all’Italia, ovviamente a New York. Nel dettaglio: BEST consente a giovani italiani di trascorrere 8 mesi in California studiando imprenditorialità e lavorando per una startup di Silicon Valley. Finora i 77 vincitori hanno creato 37 startup in Italia e attratto 45 milioni di dollari da fondi USA: i futuri talenti italiani in partenza saranno tra i 100 e i 150.
Il secondo programma consente invece alle startup italiane di conoscere il sistema del Venture Capital di New York, il capitale per imprese innovative: questo, ad esempio, consente loro di aprire una filiale negli Stati Uniti. Dal 2011 sono state ben 300 le startup italiane ospitate.
Il summit annuale consente infine a decisori e leader italiani – grande industria, PMI e governo – di avere un dialogo diretto e senza intermediazioni con la comunità di business di New York. Il summit, arrivato alla sua IV edizione (il 18 novembre partirà anche la prima edizione italiana), conta sponsor prestigiosi tra le aziende italiane, è moderato da un importante giornalista americano e mira ad informare i media americani sul perché investire nel nostro paese senza nasconderne i problemi e le sfide. Solo con questa logica, trasparente per chi ci conosce dall’estero, è possibile al tempo stesso evidenziare tutte le opportunità e il percorso di cambiamento che è in atto”.