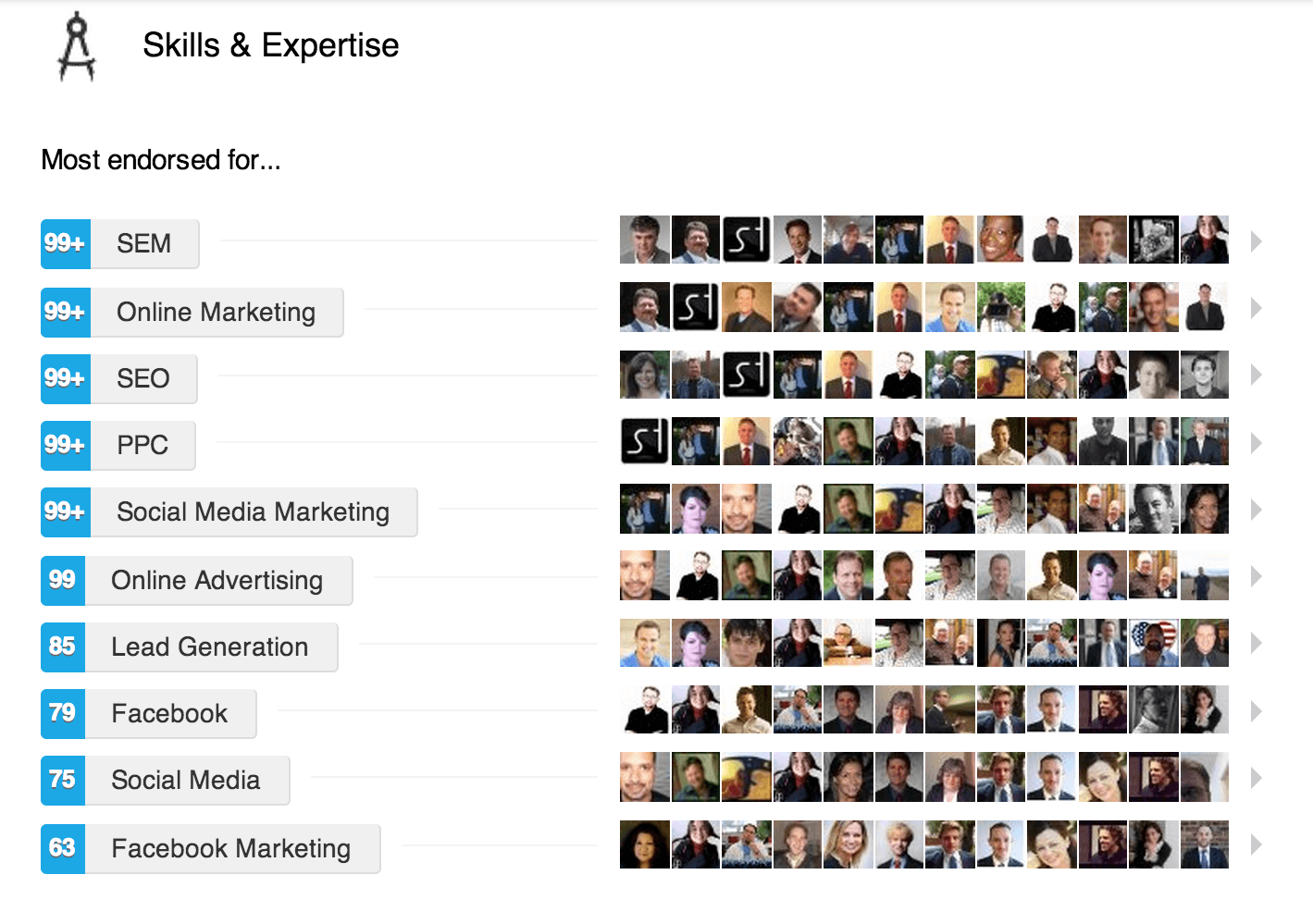Non è mai facile un ritorno non è impresa da niente – inizia così una canzone di Renato Zero – ma finalmente arriva il giorno in cui fai pace con te. Tornare sui propri passi non è una sconfitta: esistono situazioni in cui il ritorno è la migliore soluzione possibile. Non l’unica. Prendiamo un esempio che viene dal Basket NBA. Lui si chiama LeBron James, The King, probabilmente il giocatore più decisivo della Conference, sicuramente uno dei tre più forti al mondo. Most valuable player, li chiamano. LeBron viene da Cleveland e lì cresce, sportivamente parlando, portando la sua squadra a traguardi mai raggiunti prima. Ad un certo punto della carriera deve scegliere dove diventare grande. C’è tutta l’NBA che lo aspetta e lui, in diretta televisiva mondiale, comunica la sua scelta: andrà a Miami, ad affiancare altri campioni e a vincere tutto quello che c’è da vincere.
Chi conosce gli Stati Uniti sa che tra Miami e Cleveland c’è un abisso, anche in termini di stili di vita e mi sembra abbastanza scontato che se hai i soldi, e Le Bron se la passa discretamente bene, vivere a Miami non è affatto male. Estate tutto l’anno, party esclusivi, villa da nababbo, e auto sportive da far sfrecciare su Ocean Drive. Qualche delusione il primo anno con un titolo perso in finale. Ma poi i campioni sono campioni e LeBron inizia a vincere, a collezionare anelli e premi. A questo punto della storia scatta qualcosa in lui e, a sorpresa, James decide di tornare dove è cresciuto. I suoi vecchi tifosi, che avevano bruciato la sua maglia all’epoca perché si erano sentiti traditi, lo accolgono come un figliol prodigo. Gli sponsor anche, la Nike ci fa quella che a mio parere è la pubblicità del secolo affidando la colonna sonora ad Hozier: Take me to the Church è una della canzoni più ascoltate del 2014/2015 grazie anche (soprattutto) alla scelta di LeBron.
Lui, nato ad Akron, a 60 miglia da Cleveland, sceglie il suo popolo per realizzare l’impresa: diventare profeta in patria. Va detto, ad onor del vero, che Cleveland non ha badato a spese per mettere in piedi una squadra competitiva in grado di vincere il titolo. Il trasferimento ha permesso a diversi brand, tra i quali Sprite, Beats Electronics e la stessa Nike, di fare storytelling e realizzare spot pubblicitari dove il ritorno ha qualcosa di epico, quasi di biblico. Non sorprende che le visualizzazioni premino le aziende in questione. Gli spot sono emotivamente meravigliosi, il canovaccio si presta, soprattutto se pensiamo alla distanza culturale e sociale tra Miami e Cleveland. Il campione torna a casa sua per vincere insieme agli anziani che non hanno più speranze, ai bambini che non hanno futuro (ma in compenso hanno ancora il sorriso e l’ottimismo, siamo in America, of course), ai giovani che non hanno lavoro. Together, insieme, dice il racconto realizzato da Nike. E si vede LeBron prendere per mano tutta la città, motivarla, perché in fondo Miami non è così lontana.
Cosa rende magnifici e virali questi spot? Sicuramente il campione, il testimonial, l’uomo James. Ma non solo. C’è il sogno americano, la speranza, il ritorno, la pace con se stessi. C’è il sacrificio, perché senza allenamento e sudore non si va da nessuna parte, c’è la comunità. Lo spot fa il giro del mondo sebbene la protagonista principale sia la piccola città di Cleveland, quella che accoglie di nuovo il figliol prodigo, quella che si stringe attorno al campione che però, in questo caso, non è una star ma il figlio, l’amico, il vicino di casa. Per capire come va finire questa storia mancano tre settimane, ma Cleveland in finale di Conference NBA c’è, con il suo campione sempre più leader e padrone della sua squadra.
Tornare sui propri passi è un atto di grande coraggio e di responsabilità. È una storia di cambiamenti e di conferme, di idee e di risultati. Quando l’anno scorso José Mourinho è tornato a Londra, al Chelsea, aveva intenzione di completare il lavoro cominciato nel 2004 – 2005. Ha costruito una squadra fortissima intorno a Fàbregas, Diego Costa e Hazard, ma ha pensato a qualcosa di profondamente diverso rispetto a dieci anni fa: “Siamo più artistici, abbiamo un miglior controllo del gioco. Ci meritiamo ammirazione per i buoni risultati e per un certo stile“. Al secondo incarico con il Chelsea, Mourinho è chiaramente a suo agio, rilassato, in buoni rapporti con i suoi datori di lavoro. Ha il controllo della squadra e dei giocatori.
In una intervista a Gary Neville, per Rivista 11, dichiara “Avevo un progetto per la mia carriera. Non sempre puoi realizzarlo. Volevo lasciare il Portogallo e andare in Inghilterra, chiaro. Quando ho lasciato l’Inghilterra volevo l’Italia dove la gente parla della mentalità italiana e degli aspetti tattici del gioco. E dopo volevo il Real Madrid. La Spagna, certo, ma io volevo il Real. Questo percorso l’ho voluto moltissimo e ce l’ho fatta. Così mi sono chiesto: qual è il posto che ti piace di più? Dove sei più felice? Qual è la tua sfida più grande? Ho fatto la mia scelta. Lo dico sempre, in ogni club lavoravo e pensavo in funzione di quel club, però tenendo sempre a mente la mia prossima mossa. Questa è la prima volta che non ho una prossima mossa in testa“.
Nel frattempo il Chelsea (e il suo padrone) è cambiato, e tanto. Continua a comprare, ma ha anche cominciato a vendere. I conti sono una priorità del club: così il Chelsea ha il bilancio migliore della sua storia e contemporaneamente è una squadra costruita per vincere campionato, Fa Cup e chissà, in futuro, la Champions League. Quello che era il capriccio di un multimiliardario (Abramovich), ora è un’azienda con un utile di 23 milioni di euro. Il Chelsea vende il suo calcio e vende il suo prodotto. Riempie lo Stamford Bridge ogni volta che gioca in casa, il 99% dei posti allo stadio è sempre occupato e, rispetto a Manchester United e Liverpool, è la squadra che riesce ad incassare più soldi da ogni singolo spettatore del suo stadio. Eppure, fino agli anni ’90 si trattava di un club marginale. Il costruttore Ken Bates lo comprò alla cifra simbolica di 1 sterlina. Fu lui a cominciare a renderlo glamour come il quartiere che lo ospita.
Abramovich comprò il Chelsea perché costava poco e perché aveva prospettive. Ci ha messo dieci anni a costruire qualcosa che sembrasse più di un gioco personale, uno sfoggio di ricchezza. Prima comprava e basta. ora compra e vende. Spende, ma incassa: dai giocatori, dai diritti TV, dalle sponsorizzazioni. Vuole vincere ancora, per questo ha ripreso Mourinho, con una nuova consapevolezza: qui non serve più lo Special One con la lista della spesa, quello che si fa comprare dal Presidente tutti i giocatori che vuole senza badare al bilancio. Stavolta serve un manager che sappia costruire un progetto a medio-lungo termine con giocatori di prospettiva e un modello sostenibile. Scommettiamo che Mou è l’uomo giusto?