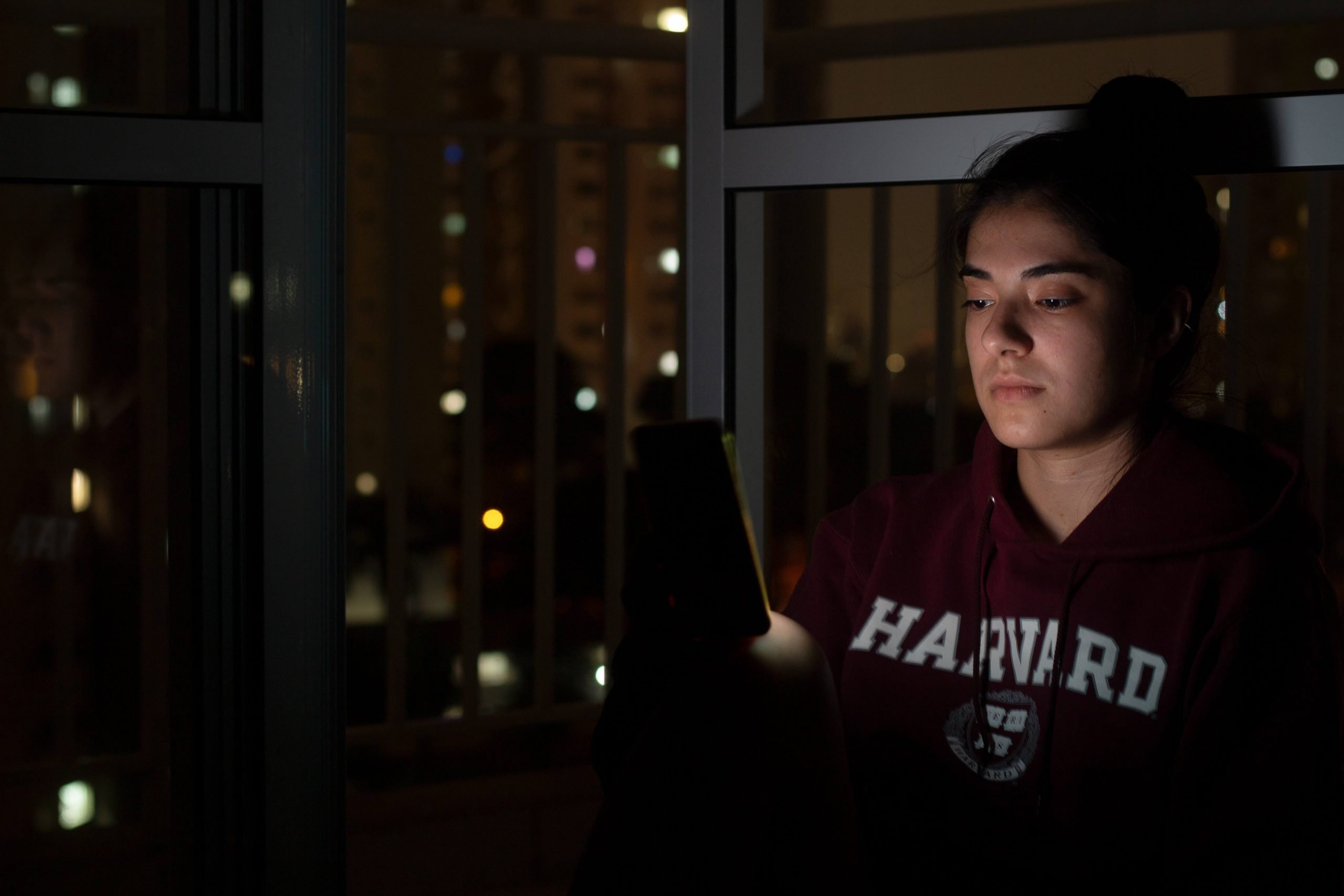Quello del corpo docente è uno dei punti deboli strutturali di tutto il sistema delle telematiche, su diversi fronti. Innanzitutto, il suo sottodimensionamento rispetto alle esigenze della didattica.
ANVUR, nel suo rapporto 2023, sottolinea che – al di là dei requisiti minimi – nelle università telematiche c’è un rapporto tra studenti e docenti di ruolo non adeguato. Se negli atenei tradizionali si parla di 28,5 studenti per docente nel 2022, con un miglioramento di due unità rispetto al 2012, nelle telematiche questo rapporto schizza a 384,8, in crescita rispetto ai 152,2 di dieci anni prima. Si tratta di un indicatore fondamentale della qualità dell’istruzione, centrale nella valutazione di qualunque università.
Ma la criticità non si limita ai numeri, e coinvolge anche l’inquadramento degli insegnanti. Secondo un rilevazione FLC CGIL su dati USTAT e CINECA, i professori ordinari (che sono assunti a tempo indeterminato) nell’università italiana al 2023 erano 16.086, il 25.23% del totale, mentre nelle telematiche si fermano al 14.07% (il 44% in meno delle tradizionali). Viceversa, nelle telematiche il personale a tempo determinato, ossia professori straordinari (inquadrati come ordinari, ma assunti con fondi esterni su contratti triennali) e RtdA (figure destinate alla ricerca, ma con obblighi didattici che sono circa la metà di quelli di un professore), è il 29.51%; in pratica, il doppio rispetto alle tradizionali. Come rileva ANVUR, la forte incidenza di insegnanti straordinari si deve al fatto che negli anni passati molti atenei li hanno usati per formare gli organici necessari a soddisfare i requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio.
L’alta percentuale di docenti precari incide sulla qualità dell’insegnamento, così come l’adozione di procedure di valutazione a distanza, che non garantisce un’adeguata verifica dell’apprendimento, imposta invece dai criteri di accreditamento dei corsi di studio e degli atenei a distanza: sarebbe previsto che avvenisse sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione. Tuttavia, molti atenei telematici ancora oggi permettono di fare esami di profitto online, sostenendo la prova da casa o da altro luogo privato, tramite l’uso del pc o di altre piattaforme. Una pratica che, a quanto risulta da un’indagine FLC CGIL, interessa anche le discussioni delle tesi di laurea.
Si è estesa quindi in modo illegittimo quella possibilità di erogare a distanza sia le lezioni che le prove d’esame, stabilita dalla legge per fare fronte alla pandemia da COVID-19, ma cessata il 31 marzo 2022 con la fine dello Stato di emergenza.
Eppure tutte queste criticità non sono sufficienti a impedire che il ministero versi ogni anno milioni di euro alle università telematiche, cioè a istituzioni private a scopo di lucro. Finanziamenti leciti, per carità, perché previsti dalla legge 243/1991, ma che nel 2023 hanno portato nelle casse degli undici atenei ben 2.592.491 euro di finanziamenti pubblici, e quasi 23 milioni di euro in dieci anni.
L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.
Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.
Sottoscrivi SenzaFiltro
Photo credits: millionaire.it