
Al Nord aumenta la povertà tra gli stranieri, come testimonia un rapporto Caritas. L’Italia è sempre meno appetibile per chi emigra, ma anche per gli italiani: in 980.000 hanno lasciato il Paese nell’ultimo decennio. Un’analisi dei dati più recenti
Le testimonianze di due madri che si sono confrontate con insegnanti che chiedevano diagnosi per bambini privi di problematiche.
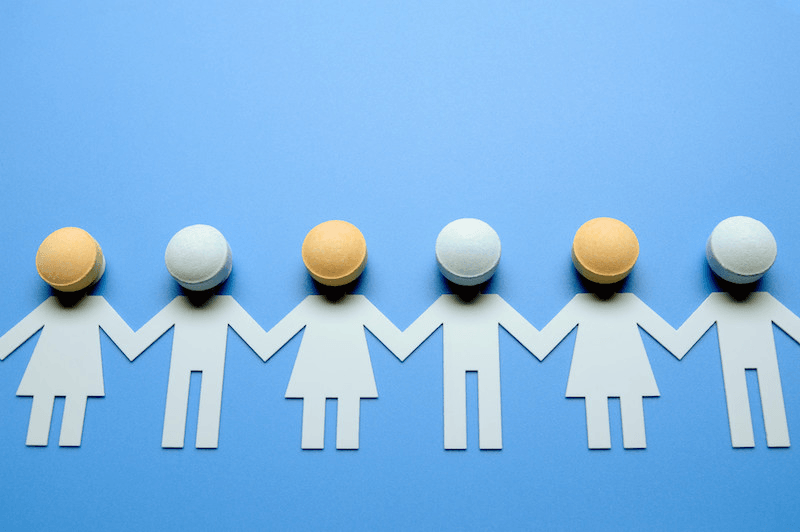
Anche lo scorso febbraio numerose scuole hanno celebrato la giornata simbolica dei calzini spaiati, dedicata alla diversità. Pur rispettando la buona fede di chi ha lanciato l’iniziativa, risulta evidente il diffuso scollamento – con una certa dose di ipocrisia – tra i proclami e la realtà dei fatti: diversità e inclusione andrebbero valorizzate all’interno di un processo quotidiano, con autenticità e coerenza; sono invece ancora troppe le testimonianze sul fatto che anche queste iniziative vengano usate come coccarda per definirsi inclusivi, quando in realtà si è tutt’altro.
La scuola è un’esperienza e un ambiente sociale, fisico e relazionale che dovrebbe più che mai valorizzare la diversità, e non banalmente “tollerarla”. Gli insegnanti che concretizzano al meglio questa valorizzazione sono tanti, ma non dimentichiamo anche quelli che un giorno all’anno ricordano alle famiglie di far indossare calzini spaiati ai loro figli, e allo stesso tempo, nella quotidianità scolastica, la diversità la temono, imbrigliano, e persino medicalizzano. Ed è proprio sul tema della medicalizzazione selvaggia da parte degli insegnanti che ipotizzano diagnosi sugli alunni, definendoli “problematici”, che realizziamo il nostro servizio.
Premettiamo che si tratta di un fenomeno appannato da forte omertà, e che al contrario di altri non è studiato da indagini dedicate attraverso un monitoraggio di dati, eppure è diffuso, come confermato da diverse testimonianze, sia delle famiglie sia di chi lavora all’interno dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile. Un conto infatti è la corretta segnalazione da parte di un insegnante riguardo eventuali disagi e manifestazioni dell’alunno in questione, aspetto utile e importante; un altro è la perseverazione con diagnosi improvvisate (che ricordiamo, non sono appannaggio della scuola e dei docenti) anche dopo che le visite hanno confermato l’assenza di problematiche.
Tra le varie segnalazioni di chi ha vissuto queste esperienze in prima persona, ne raccontiamo due.
La prima testimonianza è quella di Tiziana (nome di fantasia), dalla Lombardia.
Tiziana è stata messa subito alla prova sul fronte scolastico attraverso una situazione che ha creato stress a tutta la famiglia, come accade spesso in questi casi. Fin dalla scuola dell’infanzia suo figlio Luca (altro nome di fantasia) è infatti giudicato dalle maestre troppo irrequieto, “strano”, oltre al fatto di essere definito un bambino che disturba, termine che non dovrebbe mai essere utilizzato.
“Non sono cose belle da sentirsi dire sul proprio figlio”, racconta Tiziana. Quelle che riceve non sono infatti segnalazioni su situazioni di disagio per aiutare il bambino a esprimersi meglio, ma veri e propri giudizi che sanno di sentenze. Tiziana e suo marito non perdono tempo e si attivano subito con l’UONPIA territoriale per rilevare eventuali problematiche, affrontando anche test, colloqui e lunghe attese, oltre a risposte non sempre educate da parte di chi lavora nella struttura. In ogni caso, a Luca non viene rilevato nessun problema particolare.
Gli anni passano e Luca inizia le elementari, e anche nella nuova scuola si ripete un copione simile, ma dai toni più accesi e disarmanti, che coinvolgono anche dinamiche di bullismo prese sottogamba dalle insegnanti. La situazione peggiora nel 2020, con la pandemia.
“All’inizio del nuovo anno scolastico i bambini non potevano muoversi né giocare insieme, dovevano tenere la mascherina e anche durante la merenda dovevano stare seduti”, spiega Tiziana. “Mio figlio ha comprensibilmente provato come tanti altri un disagio, ma non per questo è giustificabile quello che hanno detto di lui le maestre”. In occasione di uno dei colloqui a distanza le tre maestre di Luca sono infatti compatte e ferme nell’esplicitare il loro responso sul bambino; un riscontro che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria diagnosi. Tiziana ricorda quel momento come se fosse ieri: “Testuali parole, mi hanno detto: ‘Molto probabilmente suo figlio ha la dislessia, la discalculia e l’iperattività, associate a dei problemi cognitivi’. Io ero allibita e ho chiesto perché ritenessero questo. Loro mi hanno risposto che il motivo era il suo essere disordinato nella scrittura”.
Tiziana si confronta direttamente con Luca, che le racconta come a scuola le maestre ripetano spesso che non c’è tempo, che bisogna essere più svelti e che le sue frequenti domande disturbano. “Io stessa ho colto che Luca manifestasse a scuola delle difficoltà a scrivere non perché non riuscisse, ma a causa della fretta. Era già in quinta, ho cercato quindi di capire bene se accadesse anche a casa e ho visto che non era così”. E precisa: “In pratica gli ho dovuto insegnare io l’impaginazione, ma questo non ha cambiato il giudizio delle insegnanti, che mi hanno detto di farlo vedere a qualcuno della neuropsichiatria: peccato che fossi già stata seguita e che ancora una volta mi avessero escluso le loro ipotetiche diagnosi. Piuttosto la psicologa mi aveva parlato di ansia sociale”.
In situazione di bullismo e con un giudizio scagliato addosso ogni giorno da chi insegna a chi non verrebbe l’ansia? Delusa, Tiziana, in accordo con il marito, decide di ricorrere all’istruzione parentale a metà anno. “Luca ora sta benissimo, socializza con i suoi coetanei, è appassionato di varie materie e non presenta alcun tipo di problema nello scrivere, perché può farlo senza andare di corsa, con una serenità che non intravedeva da tempo. È davvero un peccato che le maestre l’abbiano trattato così”.
È un connubio di stanchezza e voglia di voltare pagina quello che si legge negli occhi di Alessia (nome di fantasia), mamma di Mattia (altro nome di fantasia), un bambino di cinque anni e mezzo, che da quando ha iniziato la scuola dell’infanzia si scontra con le asprezze della medicalizzazione selvaggia da parte delle insegnanti. Anche questa testimonianza proviene dalla Lombardia.
“Sin dai primi mesi di frequenza non c’è mai stata una parola positiva o di incoraggiamento nei confronti di Mattia, e tutto questo ha determinato delle conseguenze su noi genitori e sul bambino”, premette.
Alessia ripercorre per filo e per segno l’intera vicenda anche se non è facile. “Mattia ha iniziato la scuola dell’infanzia nel 2020, in piena pandemia. Il primo colloquio, come tutti, è stato fatto a distanza, e dopo solo un mese e mezzo di frequenza le maestre mi hanno detto che il bambino non sapeva né interagire con gli altri né esprimersi bene e quindi di portarlo dalla logopedista: per noi è stata una doccia fredda”.
Alessia spiega però che dalla logopedista Mattia c’era già stato, avendo come gli altri bambini partecipato allo screening del linguaggio. La visita logopedica, quella effettuata dalla neuropsichiatra e dallo psicologo dell’UONPIA di riferimento non avevano riscontrato problemi. “L’ho fatto presente, ma per le maestre non faceva alcuna differenza. Quello che mi aveva colpito era l’assenza di empatia e soprattutto il loro tono freddo, di giudizio; nel caso in cui Mattia avesse avuto problemi non sarebbe stata comunque una colpa. Continuavano a ribadire che, nonostante mostrassero al bambino come fare alcune cose, lui non era capace di farle”.
Quel “non” diventa per la famiglia di Alessia un loop costante in occasione dei colloqui per tutti e tre gli anni di scuola, e fagocita ogni possibile iniziativa. “Noi genitori abbiamo spiegato più volte che a casa Mattia non mostrava le difficoltà segnalate a scuola ma non venivamo creduti. È come se il nostro riscontro non contasse nulla: le maestre ci hanno fatto sentire in colpa e anche inadeguati, dicendo che eravamo noi a sostituirci al bambino in alcune cose”.
Il tempo trascorre, ma la situazione non migliora. “Non convinte del responso del servizio pubblico di neuropsichiatria, le maestre ci hanno detto di andare dalla psicomotricista”, spiega Alessia. “Dopo tanto insistere, hanno instillato in noi il dubbio che qualcosa non andasse per davvero”.
Stavolta Alessia e suo marito si rivolgono al privato, pagando di tasca loro sia valutazioni che intervento di psicomotricità. Al colloquio successivo è la stessa psicomotricista a dire alle maestre che Mattia non presentava problemi, al massimo un po’ di timidezza, che di sicuro non è qualcosa da medicalizzare. “Ipotizzando di intervenire sull’ambiente scolastico per dare più agio al bambino, le maestre si sono messe subito sulla difensiva ribadendo che Mattia non riusciva a concentrarsi né a rispettare le tempistiche, e che non era al passo con il resto della classe”, sottolinea Alessia con amarezza. “Hanno di nuovo messo in discussione il riscontro dell’UONPIA, perché nel frattempo abbiamo rifatto altre valutazioni”.
Ma intanto Mattia con che stato d’animo andava a scuola, che cosa provava? “Non era felice come non lo è tutt’ora di andarci; lui dice che è ‘stufosa’”, racconta Alessia, “mentre con noi, i nonni e in altri contesti è sereno e curioso. A scuola sente una forte pressione su di lui”.
La musica non cambia neanche nei colloqui successivi. Le segnalazioni negative e le ipotesi di diagnosi proseguono, diventando uno stillicidio per i genitori di Mattia, che comincia a manifestare i segni di questa pressione data dalle insegnanti, come se la scuola fosse una richiesta continua di performance. La dinamica incide anche sulla coppia genitoriale, creando stress e disaccordi, tra dubbi e nuovi percorsi valutativi da intraprendere o meno, com’è naturale che sia.
A creare ancora più disagio è il fatto che le insegnanti della classe di Mattia, durante i mesi autunnali e invernali, nonostante le belle giornate, non portino mai fuori i bambini a giocare in giardino nonostante la presenza di un grande spazio verde dotato di giochi. I bambini perlopiù trascorrono il tempo seduti a disegnare o a fare i lavoretti, e proprio il disegno diventa la nuova spada di Damocle di Mattia.
“Il non saper disegnare bene è stata la prova per le maestre che Mattia avesse delle problematiche. A lui disegnare non piace, ma ognuno di noi ha le sue preferenze. Anche in questo caso abbiamo fatto una valutazione grafomotoria dalla neuropsichiatra dell’UONPIA, che ha confermato l’assenza di problemi, ma per le maestre resta un problema rilevante.”
Quando mesi fa i genitori di Mattia hanno comunicato alle maestre che non avrebbero più fatto valutazioni, loro hanno messo le mani avanti dicendo che erano preoccupate pensando al futuro.
Chiedo ad Alessia che cosa l’abbia più delusa: “Tante cose. L’autoreferenzialità delle insegnanti e il loro continuo mettere in dubbio responsi medici, medicalizzando loro per prime, e il non aver riconosciuto il nostro impegno nel fare le valutazioni. Una neuropsichiatra del servizio pubblico mi ha proprio detto che era stufa dell’assurdità della situazione, di dover gestire una marea di visite di bambini che continuano a essere segnalati dalle maestre per ipotetiche diagnosi, ma che in realtà non hanno nulla”.
E aggiunge, con amarezza: “Un’altra cosa che non mi è piaciuta è la dinamica da due pesi e due misure utilizzata dalle maestre confrontando Mattia con gli altri bambini. Ma la cosa più grave sono gli effetti su Mattia stesso. Lui non si è mai sentito gratificato a scuola, tanto che ora capita che si arrenda a priori prima di fare una cosa perché dice ‘non ci riesco o non sono bravo a farlo’. Vogliamo supportarlo nel fargli recuperare fiducia”.
Che cosa spera per il futuro scolastico di Mattia? “Spero di trovare, alle elementari, delle insegnanti che non lo giudichino, ma che lo valorizzino e sappiano vedere i suoi tanti punti di forza, senza soffermarsi solo su ciò che manca come se fosse una colpa. Penso che i futuri insegnanti dovranno però fare il doppio del lavoro, cercando di scardinare questa visione negativa inculcata nel bambino dopo tre anni di esperienza scolastica mentre si sarebbe meritato ben altro”.
Le conseguenze dei tentativi di medicalizzazione selvaggia da parte degli insegnanti infieriscono su più fronti: l’autostima dei bambini, il rapporto dei genitori con la scuola, la stessa inclusione. Pensiamo anche all’esito di ingolfare ancora di più i tempi di attesa dei servizi territoriali di neuropsichiatria, a danno degli utenti.
Se una situazione del genere accadesse con altri settori medici si sarebbe già gridato allo scandalo, ma qui tutto tace. Eppure la situazione ha tutti i connotati per richiedere di alzare la guardia, cercando magari di scoprire che cosa ci sia alla base di questi casi che riguardano gli insegnanti: paura, ansia, ricerca di supporto dai servizi, pregiudizi, o appunto difficoltà a ragionare al di fuori delle etichette?
Tornando all’incipit: facile dire agli altri di indossare calzini di un colore diverso, ma non vale nulla se intanto si punta il dito contro chi la pensa in modo differente, se i bambini vengono definiti “problemi” o “casi” perché giocano più o meno, perché non sono al pari della classe o “non sono come…”. Tutto questo mentre ci sono ancora bambini e ragazzi con disabilità che passano la maggior parte delle ore a scuola (se non tutta la mattinata), in aulette dedicate, a debita distanza dal resto della classe. Tutto questo mentre ancora, nella scuola, si attribuisce questa disarmante diversità – qualunque essa sia – a chiunque non siamo noi.
Photo credits: farmacianews.it

Al Nord aumenta la povertà tra gli stranieri, come testimonia un rapporto Caritas. L’Italia è sempre meno appetibile per chi emigra, ma anche per gli italiani: in 980.000 hanno lasciato il Paese nell’ultimo decennio. Un’analisi dei dati più recenti

«Sappiamo che si tratta di sfruttamento, ma non possiamo stare ad aspettare, è meglio sacrificare qualche diritto»: come vengono percepiti lavoro e diritti dai migranti? Nel CAS di via Fanelli, a Milano, c’è chi lavora 20 ore al giorno e chi percepisce 3 euro all’ora

Lottano per avere un mutuo o un finanziamento e potersi ricostruire una vita. E spesso per diventare genitori. Le storie e i diritti di chi è guarito dal cancro, da adulto o da bambino: ne parliamo con Giordano Beretta di AIOM, Elisabetta Iannelli di FAVO, Giulia, lungo sopravvivente, e Nicol, compagna di un malato oncologico.