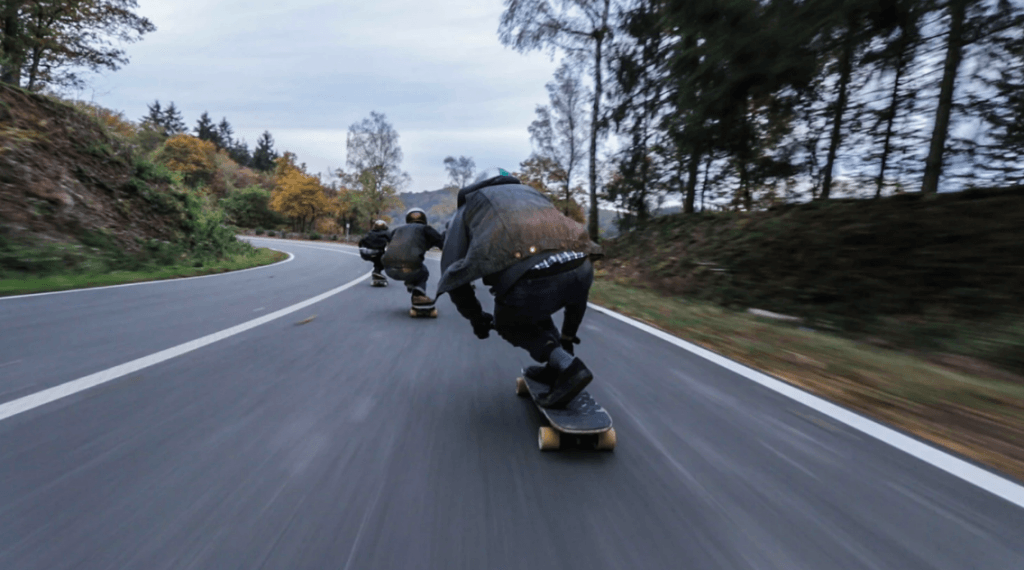“Viviamo in una grande ‘società signorile di massa’”, ha ricordato Paolo Storari, PM della procura di Milano, “in cui una scarpa pagata 18 euro al fornitore cinese viene poi venduta a 700 euro in via Montenapoleone, mettendo in evidenza come il modello d’impresa debba essere cambiato alla radice. Molte aziende della moda oggi si appoggiano a opifici gestiti da imprenditori cinesi sparsi in tutta Italia, inclusa la periferia di Milano, dove i lavoratori operano in condizioni di semi-povertà. In alcuni casi, vengono sorvegliati da cani lupo, i bambini girano liberamente tra i macchinari e i salari sono di appena 2,70 euro l’ora. Preferibilmente si lavora di notte per evitare controlli, senza giorni di festa o riposo. Questi fenomeni hanno in comune lo sfruttamento del lavoro e un’ampia impunità. Uno degli stratagemmi più usati è il continuo cambio di cooperativa, che fa risultare i lavoratori come assunti da pochi mesi, quando in realtà lavorano nello stesso posto da anni. Si tratta di pratiche largamente accettate perché convenienti per tutti”.
Storari ha ricordato come in questo ci sia anche una responsabilità dei sindacati, che gestiscono “conciliazioni vergognose”.
“Tutto ciò non è frutto di un singolo amministratore delegato ‘cattivo’, ma di vere e proprie politiche aziendali che, come tali, vengono affrontate. Per questo motivo, sono poco interessato alla responsabilità individuale: il contesto è più importante delle singole persone. Se non si cambia il sistema, qualcun altro continuerà a sfruttarlo nello stesso modo”.
Tra le parole pronunciate dal PM c’è anche il decoupling organizzativo, la pratica con cui le aziende creano codici di condotta, protocolli e modelli di compliance (come il D.lgs. 231/2001), ma spesso si tratta di “aspetti cosmetici, è solo carta”. Una sorta di disaccoppiamento che vede da un lato una struttura formale dell’organizzazione volta al rispetto delle regole istituzionali, e dall’altro una sorta di struttura informale che persegue le regole dell’efficienza e del risultato.
Grazie al lavoro della procura di Milano sono state portate avanti importanti azioni legali, “con l’internalizzazione di 25.000 lavoratori e il recupero di 600 milioni di euro”. Anche se, ha precisato il PM, “al di fuori della Lombardia, in molte altre Regioni d’Italia, il silenzio resta regnante. Questo è dovuto probabilmente alla capacità delle grandi imprese di influenzare il ruolo dei sindacati e delle istituzioni”.
L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.
Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.
Sottoscrivi SenzaFiltro
Photo credits: lifeandpeople.it