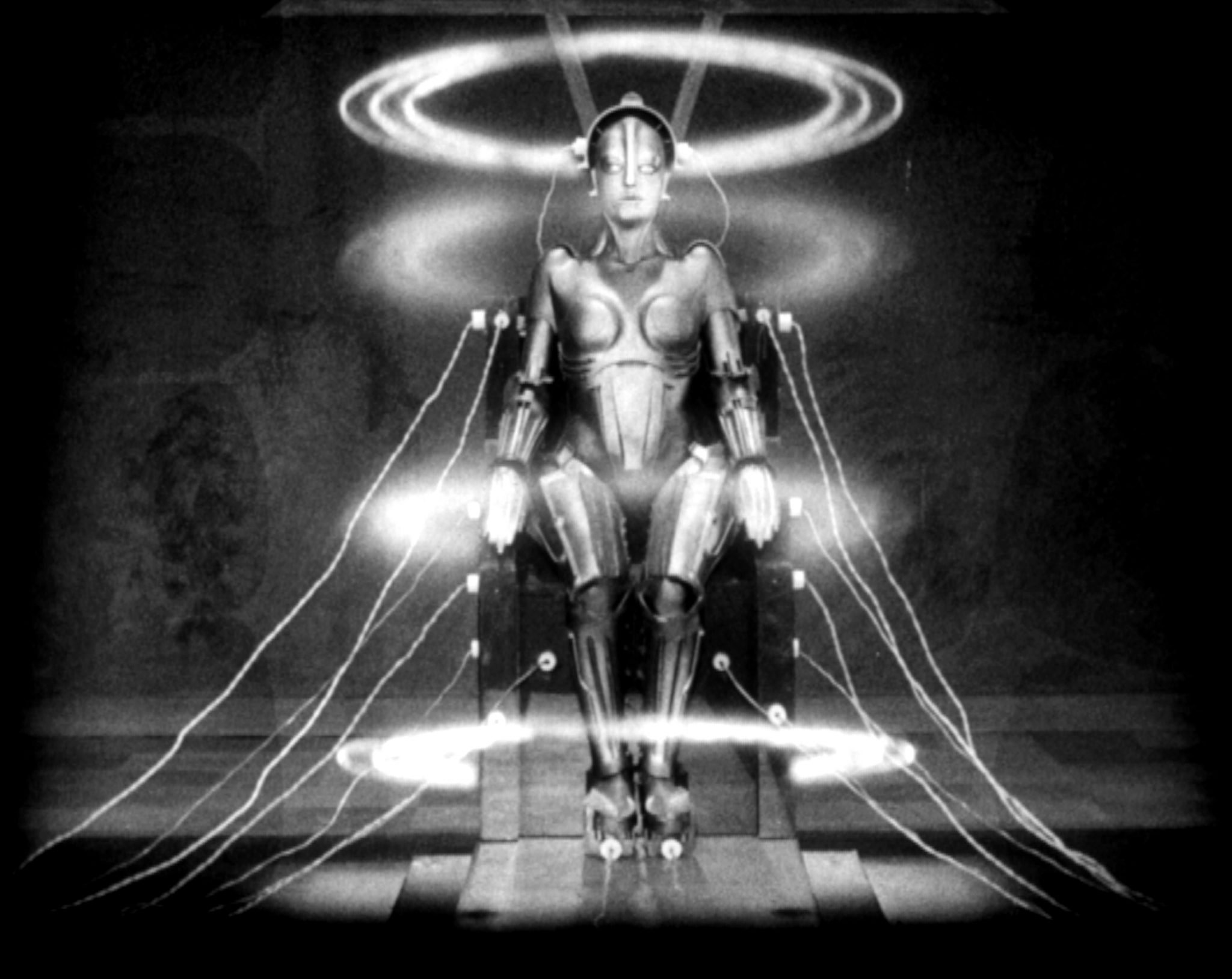Il nome di Rowan Atkinson è uno dei casi in cui la fama del personaggio interpretato supera quella dell’interprete, il ruolo a volte si mangia la persona. In una recente intervista rilasciata al Daily Star, l’attore non ha lesinato speranze nell’immaginare il possibile ritorno, con qualche anno in più, dell’alter ego da cui fatica a separarsi. “Sarebbe molto divertente vedere fin dove è possibile spingersi con un Mr. Bean invecchiato e che tipo di comicità ne potrebbe venir fuori. Recitare una persona anziana può essere davvero spassoso”. Una dichiarazione d’amore alla comicità e una presa di coscienza che il tempo trasforma tutto ma non distrugge niente se l’obiettivo di un buon lavoro è anche quello di restare un po’ immortali.
Comici, sportivi, attori e cantanti sono da sempre in cima alle classifiche dei mestieri più invidiati e non si capisce mai abbastanza bene se ci stiano per il fatto che la gente li associa al piacere che generano o al guadagno che fruttano. Per ritagliarci un po’ di gusto in mezzo alla fatica c’è da sgomitare parecchio. Il divertimento ha un moto a luogo preciso che va da dentro a fuori e solo in quel verso sposta i luoghi comuni e raggiunge lo scopo; chi se lo aspetta in direzione opposta, non di rado anche come fosse un qualcosa di dovuto, incontra noia e malumore e lamentele senza fine. Divertirsi al lavoro non è mai un diritto, semmai una conquista. Lo sportivo deve rompere fiato e sudore, il comico dimenticare se stesso per far vivere un altro, il cantante provare ogni volta una volta in più: niente di tutto questo, visto da vicino, rima ancora con lo spasso. I piedi delle ballerine sorridenti sono una via crucis di cerotti nascosti con sapienza dentro scarpe color cipria.
Se nemmeno i più invidiati ci riescono, chi si diverte allora? A portarci fuori strada è il retaggio che ci siamo impressi addosso. Divertirsi non è roba da grandi, non sta bene, non c’è più l’età; al lavoro, poi, figuriamoci, genera quasi vergogna. Farsi pagare non solo per la prestazione ma pure per le risate e la soddisfazione? Immorale. Il dovere da un lato e il piacere dall’altro, non sia mai che si tocchino, letti separati sempre: è la fede diffusa di una cultura italiana votata al finto moralismo e al modello del perbene. Le big company oltre oceano, che utilizzano da tempo modelli organizzativi antropici e tolleranti, ci stanno aiutando a ricostruirci un’infanzia: godere del proprio lavoro non è un peccato ma quel piacere devi prima volerlo e poi andartelo a prendere. Queste aziende proiettate al futuro se ne inventano una al giorno per trovare i collaboratori migliori e poi per farli restare; la sfida è farli appassionare a se stessi, al contesto, ai servizi esclusivi, al progetto comune che senza di loro non farebbe un passo. Credere in un risultato personale è una forma naturale di divertimento con cui dovremmo prender confidenza. Le aziende italiane, quelle che si sentono grandi ma che in realtà non son mai cresciute, per strizzare l’occhio si attaccano ancora a cilindrate e buste paga e, così facendo, tirano il freno a tutto il sistema. Sarà anche per questo che molti distributori di caffè vengono temporizzati con scaltrezza per accelerare le pause da ufficio e rispedire i dipenderti in stanza; e pensare che il tempo non deve mai essere un nemico del lavoro né tanto meno la sua unità di misura assoluta. Alle rivoluzioni quotidiane servono poche cose: buone idee, la fermezza di molti, la luce giusta per brillare.
A che gioco giochiamo è una scelta personale, non sempre libera e democratica – la vita non lo è mai, figuriamoci il lavoro – ma pur sempre possibile. L’impressione è che l’illusionismo sia quello più diffuso: manager, dipendenti, colleghi, capi. Illusionisti però da quattro soldi, concentrati su se stessi più che sullo spettacolo o sul pubblico. Quante volte abbiamo la sensazione che qualcosa non vada come dovrebbe ma l’intuito non ci basta per capirne il perché? Harry Houdini è stato un maestro assoluto, il pubblico lo cercava e lo adorava, per lui perdeva il fiato ed era disposto a sudare di apprensione, a pagare e come per vederlo dal vivo. Tutte le celle e le manette da cui si è liberato lo hanno consegnato per sempre alla storia. Gli illusionisti di professione meritano il rispetto della professione. La verità è che non conta tanto ciò che l’illusionista fa ma come lo spettatore vive l’effetto. Quanti manager ne sono fino in fondo capaci?
Il mestiere del croupier forse calza meglio come esempio di certi stili di impresa: chi ce l’ha come sogno nel cassetto, sa bene che in Italia non c’è gran giro e che il requisito essenziale per provare a farsi strada è andarsene all’estero, imparare l’inglese, rivendersi esperienza e dimestichezza in qualche nave da crociera o nella Svizzera sempre più ricca di noi. Il croupier è l’addetto al casinò che serve al tavolo verde, riceve le giocate, garantisce le regole, paga le vincite sul velluto. Sarà che in giro per le aziende si vedono sempre più croupier improvvisati illusionisti, sarà che Mr.Bean non è ancora abbastanza vecchio per parlare, sarà che di Houdini ne nasce uno ogni millennio.
A che lavoro giochiamo? Si accettano scommesse.