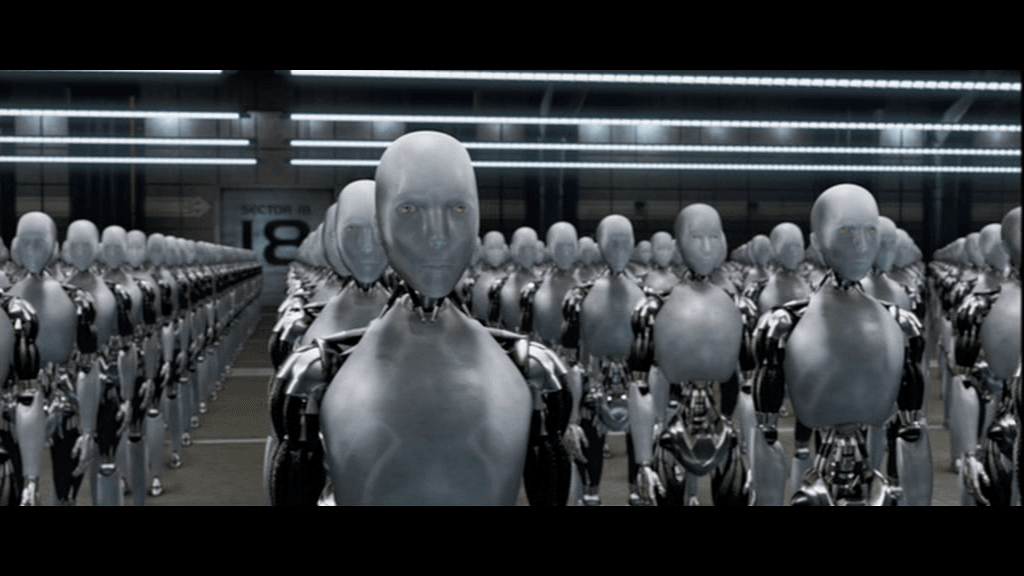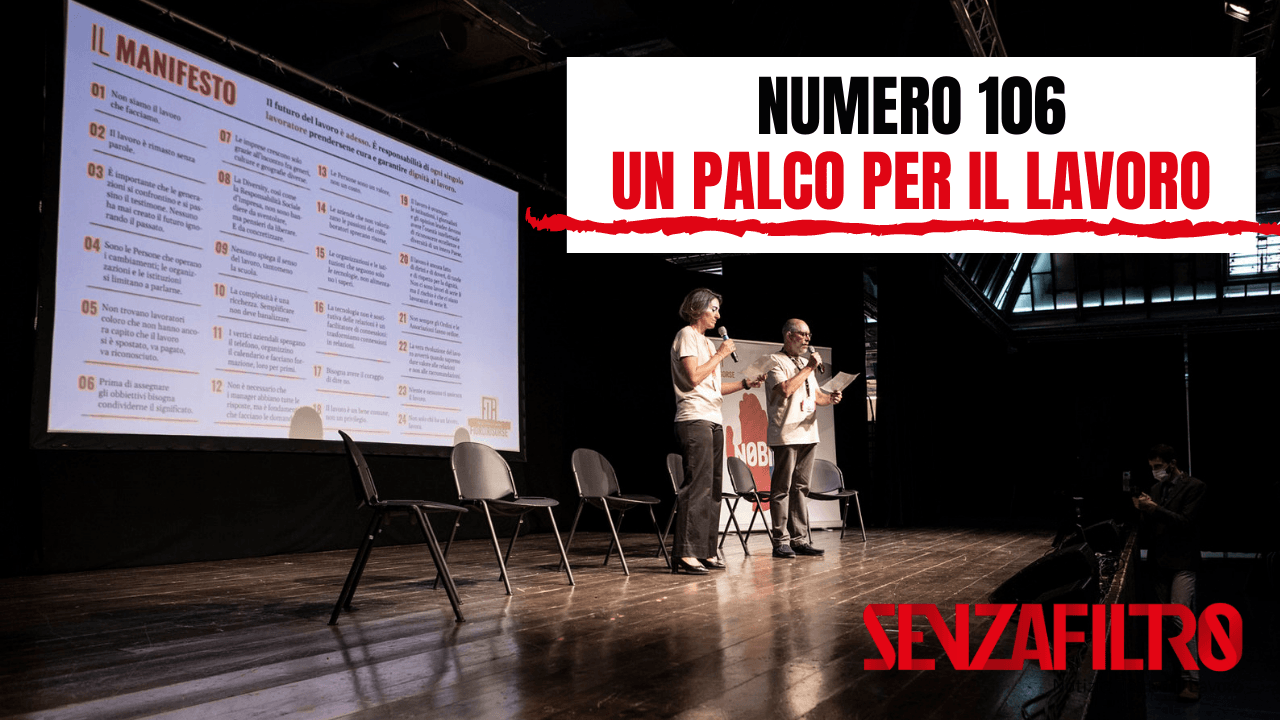Non sono più nati i George Orwell e gli Isaac Asimov o forse sono in mezzo a noi e nemmeno ce ne accorgiamo. Vivere di distrazione è una delle connotazioni più forti con cui ci lasciamo alle spalle i primi vent’anni del millennio: andiamo, facciamo, parliamo, ascoltiamo, programmiamo come se le azioni fossero sorelle mentre non sono neppure vicine di casa.
Quando a fine Ottocento la fantascienza fece il suo primo passo dentro il mondo della letteratura, lo fece grazie ad Hugo Gernsback che nel 1926 usò il termine Scientific fiction per mettere sotto l’ombrello tutti i racconti generati da fatti scientifici; fu Giorgio Monicelli, fratello di Mario e fondatore della storica collana Urania, a portare per primo gli italiani degli anni ’50 a guardare il futuro col naso all’insù o, comunque, a portarli altrove. Erano gli italiani del dopoguerra, erano gli italiani che avevano voglia di sostituire i tozzi di pane con la melassa dei sogni. Era il culto crescente dell’inverosimile unito alla fortuna di essere ancora smaliziati su un futuro che peggio del presente non sarebbe potuto essere. Quando l’uomo nobilita il pensiero e l’istinto, poggiandosi su dati scientifici, la realtà è lì a due passi anche se il tempo deve ancora metterla a libro paga.
Basti pensare a Jules Verne, il quale aveva previsto come la conquista della Luna sarebbe cominciata con una capsula lanciata nello spazio dalla Florida con dentro tre astronauti che avrebbero perso peso nello spazio (la forza di gravità era già nota, ma gli effetti mai dimostrati) e che al termine del viaggio sarebbero stati recuperati nell’Oceano Pacifico. Nel suo romanzo approssimò con bassissimo errore anche la distanza tra la terra e la luna. Qualcuno può anche pensare che sia stato il futuro a copiare lui, punti di vista.
Provare a immaginare l’Italia che saremo nei prossimi decenni è un’altra cosa, ben più complessa, perché siamo diventati arroganti persino col futuro: proprio perché ci pare di toccarlo ogni giorno – e di avere ognuno di noi i superpoteri dalla tecnologia – tutto ciò che potremmo essere un domani ci sembra già di viverlo oggi e ne bruciamo l’essenza.
Vent’anni di digitale spiccio – e spesso ignorante nell’uso quotidiano – ci hanno dato l’illusione di un mondo a nostro piacimento, relazioni e persone comprese.
Nel suo ultimo libro, Stati nervosi (Einaudi, 2019), un formidabile William Davies spiega come l’emotività abbia conquistato il mondo e come il nostro tempo sia in preda ad una serie di nevrosi, motiva perché i cittadini non si fidino più degli esperti e, di fondo, come mai rifiutino l’esistenza dei dati oggettivi, salta da Napoleone a Facebook in maniera talmente pulita che il cervello ne riconosce l’eleganza di pensiero durante ogni pagina del libro. Stiamo entrando nel nuovo ventennio carichi di frustrazione e di rabbia e accorgercene potrebbe essere la prima terapia verso la guarigione.
Davies, da esperto di sociologia ed economia politica, è capace di spiegarci la politica di mezzo mondo partendo dalle stesse leve umane – da leggere come voglia di potere, bisogno di piazze, spinta al conflitto verbale, scarsa cultura dell’argomentazione, sfruttamento della folla – arrivando a concludere che la mente razionalistica ci ha spinto nell’ultimo secolo solo ad avere di più e ad averlo male. Abbiamo spinto per vivere più a lungo, avere più prosperità e potenziare il senso di piacere ma al tempo stesso abbiamo trascurato il senso del dolore e del risentimento e abbiamo umiliato ogni sacrosanta ancestrale paura: ora che da est a ovest e da nord a sud del mondo la politica si sta impossessando dei livelli più profondi dell’umano per saltare i passaggi più impegnativi del suo mestiere, l’occasione è propizia per metterci una lente sopra e ingrandire da vicino. Chi ha la sensazione che il Duemila ci abbia un po’ traditi, è ancora in tempo per battere cassa.
Non c’è dubbio che nei prossimi decenni cambierà la storia perché muteranno le persone e cambierà la geografia perché abbiamo fatto piangere la terra. La gente scapperà sempre più da un clima comprensibilmente feroce oltre che da politiche incomprensibilmente violente.
Una recente ricerca condotta dall’Università ETH di Zurigo si allinea all’allarme mondiale lanciato dai climatologi fino al 2050: l’Italia inizierà a bollire insieme a moltissime altre città europee che potrebbero raggiungere temperature altissime; entro il 2100 si ipotizza addirittura che verremo sommersi. Un’Europa descritta chiaramente come l’Africa che conosciamo adesso e un’Italia immaginata molto simile all’Equatore che abbiamo finora preso in considerazione solo perché spartiacque di certi viaggi intercontinentali.
Nemmeno a dirlo, il problema sarà la mancanza d’acqua più che il caldo: abbiamo la sensazione di governare il mondo a nostro piacere ma l’acqua stampata in 3D non si è ancora vista. Di tutto questo si preoccupano pochi cervelli, se non dentro gli ambienti scientifici; lo spazio in cui certe prese di coscienza dovrebbero iniziare a vibrare dovrebbe essere ogni luogo di lavoro a prescindere da cosa dice o produce perché nelle aziende si continua pericolosamente a percepire il rispetto di norme ambientali come un peso senza incarnarne realmente l’urgenza e davvero in pochi tirano fuori un modo nobile con cui riavvicinarci all’essenza.
Per un’Italia 2030 varrebbe la pena puntare fin da subito su tre aspetti: più fisicità, meno rabbia, più educazione. Se davvero stiamo nutrendo i robot con le nostre informazioni da umani, il rischio è di educare macchine coi nostri peggiori difetti e con le nostre delusioni più amare. Mi auguro anche che nel 2030 smetteremo di trattarci tra persone come computer e che la frase “ci aggiorniamo presto” sparisca dal nostro vocabolario.
Non dobbiamo aggiornarci ma ascoltarci, parlarci, provare a capirci.
Poche settimane fa ho rinnovato la carta d’identità datata 2009 e mi hanno consegnato quella elettronica. Mi hanno chiesto se volessi tenermi la vecchia o ritagliare la foto perché tanto l’avrebbero data al macero. L’ho presa con me, ho firmato i moduli, ho ritirato i pin e i puk, ho pagato la quota e sono uscita; solo nel mettermi alla guida mi è venuto in mente che allo sportello nessuno mi aveva chiesto che lavoro facessi, né il colore dei capelli, né gli occhi. Non sono più ritenuti essenziali ai fini dell’identificazione.
Il nuovo Ventennio appena nato dovrà avere grande cura di sé perché potrebbe portarci tutto e il contrario di tutto: la tecnologia continuerà a piantonarci dentro casa subaffittandoci la vita e sempre più la pelle mentre noi rischieremo di fraintenderla ancora, sovrastimarla, sottostimarla, guardarla a bocca aperta, tradirla nella sua natura. Sarà utile capire presto attraverso cosa vorremo riconoscerci e che Italia saremo nel 2030 lo dobbiamo decidere adesso.
Se c’è qualche nuovo Orwell o Asimov in ascolto, si faccia vivo.