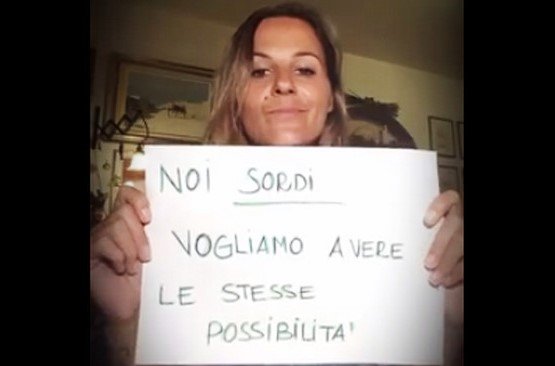Fateci caso. Pochi giorni fa è accaduto forse l’evento più importante della politica economica italiana di quest’anno: il salvataggio dell’Ilva (attraverso la vendita dell’attuale società in amministrazione straordinaria alla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal), la più grande fabbrica d’acciaio d’Europa. Fate caso a come l’Italia ha vissuto l’avvenimento. Tutto è stato giocato su due grandi versanti: da una parte grandi manovre politiche infarcite di retorica e veleni, e dall’altra giornali e televisioni concentrati solo sul salvataggio dei posti di lavoro.
Ilva, un salvataggio senza amore
Già, ma dov’è finita la fabbrica? È sparita. Forni giganteschi, decine di ciminiere fumanti, colline che raccolgono milioni di metri cubi di materie prime, duecento chilometri di ferrovie interne e cinquanta chilometri di strade distribuite su qualcosa come quindici milioni di metri quadri; sono tutti rimasti invisibili. Nessuno che abbia descritto il ruolo strategico di questo universo produttivo, che pure consente all’Italia di produrre un bene di grande valore come l’acciaio e di mantenere una posizione cruciale nell’industria di base che, come vedremo, America e Germania stanno riscoprendo; e che consente, tra le altre cose, di fermare un declino nella produzione di valore aggiunto che sembra inarrestabile. Nessuno che abbia detto una verità semplice semplice: se l’Italia produce oltre un milione di automobili l’anno fatte soprattutto d’acciaio, perché dovremmo importare l’acciaio dalla Germania?
Sia come sia, quello dell’Ilva è stato un salvataggio senza amore. Eppure l’acciaio non è e non è mai stato solo acciaio. Quando fu inaugurato, all’inizio degli anni Sessanta, il polo siderurgico di Taranto fu rivestito di una missione catartica: portare il Mezzogiorno nell’età moderna, fermare l’immigrazione e contemporaneamente proiettare l’Italia in un ruolo di potenza industriale adeguata alle ambizioni di un Paese che stava uscendo dalla millenaria povertà contadina. A distanza di un sessantennio e nonostante il suo salvataggio, la memoria collettiva di quella fabbrica pare conservarne solo gli aspetti negativi: l’inquinamento e le pesanti ricadute sulla salute.
Fabbrica e disamore, un problema di racconto
Il caso Ilva è l’emblema di ciò che più oggi manca alla fabbrica italiana: l’amore o, meglio, la considerazione.
“Il nostro Paese ha vissuto una lunga fase felice di industrialismo”, spiega il professor Beppe Berta, storico, docente della Bocconi, grande appassionato di industria cui tra l’altro ha dedicato il libro Produzione Intelligente edito dal Mulino. “Un movimento che appare tramontato in Italia, che pure resta un paese a manifattura diffusa. Si tratta di un fenomeno di negazione assai problematico anche perché la fabbrica è tornata di moda in altre parti del mondo, a partire dagli Stati Uniti”.
Le riflessioni di Berta hanno radici profonde. Secondo lo storico bocconiano negli ultimi decenni la società industriale italiana ha perso densità e compattezza sia per la fine del fordismo, e dunque delle grandi masse di operai che venivano trasformati da contadini marginali in cittadini nella pienezza dei loro diritti, sia per la sparizione del modello della grande impresa industriale. Di conseguenza è tramontato anche l’industrialismo, ovvero quello strumento di mobilitazione e di consenso che per alcuni decenni ha fatto pensare agli italiani che la nascita di una fabbrica portasse automaticamente benessere sociale all’intero territorio interessato.
Perché tutto questo è sparito? Perché in Italia la fabbrica è sopportata come un peso e non più investita della sua missione di progresso sociale della comunità che coinvolge?
“Oggi abbiamo un problema di racconto”. È la tesi del sociologo Aldo Bonomi, autore qualche anno fa de Il capitalismo molecolare, Einaudi. “Le varie fasi dell’industrialismo italiano sono state raccontate e interpretate da figure culturalmente distanti e talvolta opposte fra loro, e invece oggi questo non c’è”. Bonomi in un recente intervento ha raccontato del passaggio dal latifondo all’industria, che fu letto e interpretato da figure assai diverse tra loro come Danilo Dolci o Adriano Olivetti, mentre le migliori interpretazioni del fordismo made in Italy furono sviluppate da Paolo Volponi (che parlò di “mosche del capitale”) e dall’operaismo dei Quaderni Rossi; quelle dello sviluppo dei distretti industriali e poi della diffusione delle multinazionali tascabili (ultimo sviluppo significativo dei format della manifattura italiana) da Giacomo Beccatini o Giuseppe De Rita, con il suo mai dimenticato inno alla flessibilità Piccolo è bello.
La fabbrica all’estero: Stati Uniti e Germania
Ma se oggi nessuno racconta più la vitalità della fabbrica italiana, all’estero accade esattamente l’inverso. È ancora fresco il ricordo del salvataggio pubblico dell’industria dell’auto americana da parte dell’amministrazione Obama: cinquanta miliardi prestati alla GM e una decina a Fiat Chrysler per consentire agli Usa di restare fra i principali produttori di vetture al mondo. Si disse allora che il democratico Obama aveva fatto un favore alla sua constituency, composta anche dal sindacato dei metalmeccanici americani UAW. Ma la resurrezione della love story fra la fabbrica e la politica yankee ha trovato un nuovo acme con il repubblicano atipico Donald Trump. È di poche settimane fa la foto scattata alla Casa Bianca della firma presidenziale dell’atto che impone nuovi dazi sull’alluminio e sull’acciaio. Ebbene, Trump ha voluto che assieme a lui fossero immortalati una dozzina di lavoratori dei due settori, con tanto di tute blu stile Cipputi.
La reindustrializzazione è una delle leve del racconto trumpiano. Così come la fabbrica resta un tempio sacro dello sviluppo per la società tedesca, che ha fatto dell’export e della qualità dei prodotti industriali il suo totem; ne sanno qualcosa le multinazionali che hanno provato a chiudere stabilimenti e centri di ricerca industriali ad alto costo in Germania. La Opel della GM, che prima della cessione ai francesi di PSA riusciva a perdere un miliardo di euro ogni anno, è riuscita a ridurre la sua capacità produttiva chiudendo la fabbrica di Bochum solo dopo tre anni di trattative, e dopo aver accettato di pagare oltre 100.000 euro di buonuscita per ognuno dei suoi 3.000 dipendenti. Un messaggio chiaro: in Germania la fabbrica non si tocca.
La fabbrica in Italia: fondamentale, ma poco considerata
In Italia questo slogan – almeno nella maggior parte dei casi – è collegato alle proteste per la perdita di posti di lavoro, ma non più al ruolo della fabbrica come leva di progresso e di coesione sociale. Eppure la ripresa del peso specifico dell’industria per la nostra economia è sotto gli occhi di tutti.
L’anno scorso l’Italia ha toccato il record delle sue esportazioni con oltre 450 miliardi di euro, quasi tutti derivanti dalla manifattura industriale. E all’interno della manifattura il 52% dell’export è raggruppato sotto la voce “prodotti metalmeccanici”. Interi comparti stanno conoscendo uno sviluppo imprevedibile fino a pochi anni fa, come il farmaceutico oppure quello dell’automotive, che tutti giudicavano maturo e ormai destinato a un ruolo ancillare nei confronti dello strapotere dell’industria teutonica. Invece nel 2017 dai porti italiani sono partite per gli Stati Uniti la bellezza di 150.000 vetture, comprese 100.000 Jeep assemblate a Melfi, in Lucania. A due passi da Taranto. Qui una recente ricerca del Censis sul “popolo della fabbrica di Melfi” ha fatto emergere alcuni dati sociali interessanti sui riflessi della presenza di una fabbrica efficiente in un determinato spicchio di territorio: fra gli operai Fiat dell’area melfitana il tasso di divorzio è inferiore rispetto a quello della media territoriale.
Proprio lo stabilimento Fiat di Melfi qualche tempo fa ha dato vita a un’iniziativa che può essere utile per chi intende provare a ricostruire una relazione empatica fra gli italiani e l’industria. Per alcune settimane la Fiat ha fatto girare per le città e i paesi lucani e pugliesi una mostra itinerante montata su un grosso tir, con l’obiettivo di far conoscere alla popolazione come si lavora in una grande fabbrica moderna che spesso viene descritta come un lager tutto robot e schiavismo. Titolo della mostra: La nostra fabbrica, ovvero un bene collettivo del territorio, destinato ad arricchirlo per generazioni.
Foto by Pixabay.com