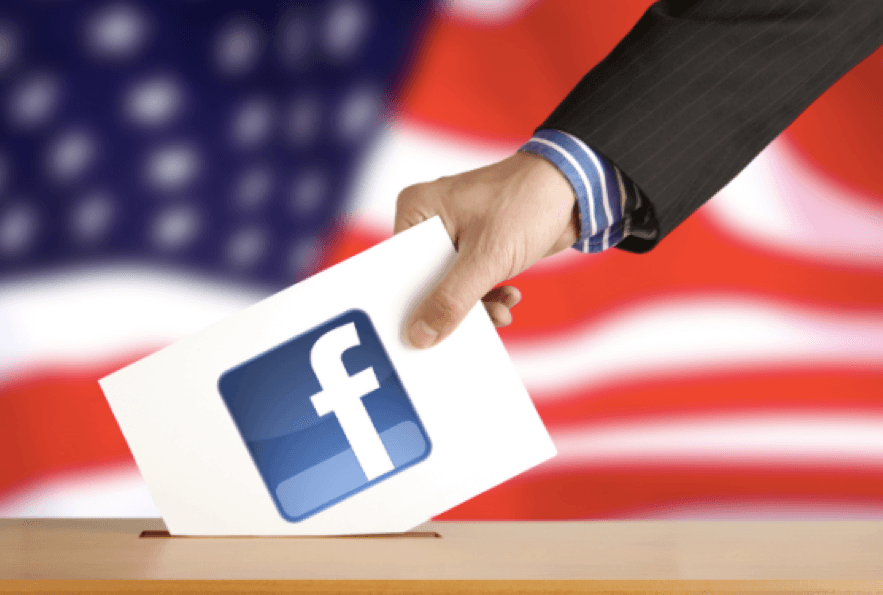Due giorni fa il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei riders addetti alle consegne per conto di Foodora, azienda tedesca leader del mercato italiano dei pasti a domicilio. Nel 2016 – insieme a molti altri colleghi, addetti alle consegne anche per altre società del settore – avevano preso parte alle proteste per il riconoscimento di un migliore trattamento economico e per l’inquadramento normativo della loro attività.
A fronte della decisione di Foodora di interrompere la collaborazione con molti dei manifestanti di allora, i sei hanno presentato ricorso per chiedere di essere reintegrati al lavoro, sostenendo quindi di dovere essere qualificati come lavoratori dipendenti. A supporto della loro tesi: il controllo dei loro spostamenti e dei tempi di esecuzione delle consegne da parte della società, il potere di quest’ultima di modificare a piacimento i loro orari di servizio e di quantificare il prezzo delle consegne a carico dei clienti.
I giudici di Torino non la pensano come quelli di Londra. Il caso Uber
Il ricorso dei sei è stato respinto dai giudici torinesi, sposando gli argomenti con cui Foodora si è difesa: i riders sono lavoratori autonomi, liberi di decidere se e quando dare la propria disponibilità, senza obblighi minimi di presenza al lavoro. Come dimostra la decisione di tanti fattorini che si assentano in caso di maltempo senza preoccuparsi che altri li sostituiscano.
Il Tribunale del Lavoro di Londra, nel 2016 – con una pronuncia confermata dal Tribunale del Lavoro di Appello nel novembre dell’anno scorso – è giunto a conclusioni opposte con riferimento ai drivers che prestano la loro attività per Uber: pur non essendo qualificabili come “employees”, non possono nemmeno essere considerati quali “self-employed” o “independent contractors”, ma rientrano nella categoria intermedia dei “workers”. Lavoratori semi-dipendenti, quindi: per giungere a questa conclusione non è necessario, secondo i giudici londinesi, dimostrare un vincolo di subordinazione, ma è considerato decisivo il fatto che la prestazione del driver non sia l’oggetto di una attività professionale o imprenditoriale libera.
Problema non nuovo per Uber che nei primi mesi del 2016, per chiudere in via transattiva due class action in California e Massachussets intentate dai drivers statunitensi per domandare l’assunzione in massa, ha pagato 100 milioni di dollari e garantito attenuazioni dei sistemi di controllo sull’operato degli autisti in cambio della loro promessa di non rivolgersi più i giudici.
Le app sono i nuovi datori di lavoro?
Sono gli effetti, con esiti alterni, della tanto decantata disintermediazione. Nello schema tradizionale, tra il cliente e il servizio che egli cerca c’è un soggetto intermedio che lo esegue in cambio di un compenso. Nel mondo di Uber e di Foodora il cliente si convince di accedere direttamente al servizio: in realtà, c’è una app che agisce come intermediario tra il cliente e il soggetto (il rider, il driver) che eroga il servizio.
Piattaforma di mediazione o datore di lavoro? Questa è la domanda alla quale i giudici torinesi e quelli londinesi hanno risposto in modo opposto. La sensazione è che entrambi abbiano preso la loro decisione interpretando le vicende concrete in base alle regole formali a loro disposizione. E qui sta il problema: le regole formali sono necessariamente in ritardo rispetto all’evoluzione sociale dei rapporti, anche dei rapporti giuridici.
Nell’attesa che le regole formali si evolvano, occorre un approccio sostanziale in base al quale chiedersi se il controllo degli itinerari e dei tempi di spostamento tramite l’app sia un normale strumento di efficienza dell’organizzazione o al contrario sia un mezzo per vigilare sull’operato dei propri sottoposti; oppure domandarsi se il rapporto che collega azienda e lavoratore tramite l’accesso all’app faccia di loro due soggetti autonomi che scelgono di collaborare o li renda semplicemente un datore di lavoro e un dipendente.
Le domande giuste da porsi sulle prestazioni di lavoro. Il contratto.
Perché anche sposando il ragionamento dei giudici di Torino e qualificando Foodora come un mediatore e non come un datore di lavoro, la vera domanda sostanziale è se una prestazione resa per un prezzo irrisorio che viene deciso dal mediatore e non è oggetto di trattativa tra il cliente e il prestatore d’opera sia definibile come “lavorativa”.
I miei maestri mi ripetevano che se una norma formale non mi fosse bastata per risolvere un problema, avrei trovato il rimedio nel collegamento tra il caso concreto e i principi generali. Avevano ragione: questa è la strada per prevenire le patologie e evitare di intasare di cause mille altri Tribunali in giro per il mondo.
Uber coi suoi drivers, Foodora coi suoi riders (avete notato come il digitale abbia bisogno, per funzionare, di gambe che pedalano e ruote meccaniche che girano?) riscoprano la funzione preventiva della qualità e della correttezza nella stipula dei contratti.
C’è una parola greca che definisce l’essenza del contratto a prestazioni corrispettive: sinallagma, che unisce syn (insieme) e allàsso (prendere e dare in cambio). Se il sinallagma non funziona, perché è o diventa squilibrato, il contratto va in crisi: il codice civile italiano prevede la sua rescissione quando uno dei contraenti lo stipula in “stato di bisogno” e l’altro ne è consapevole.
Detto tra noi, Sinallagma sarebbe un bellissimo nome per una app.