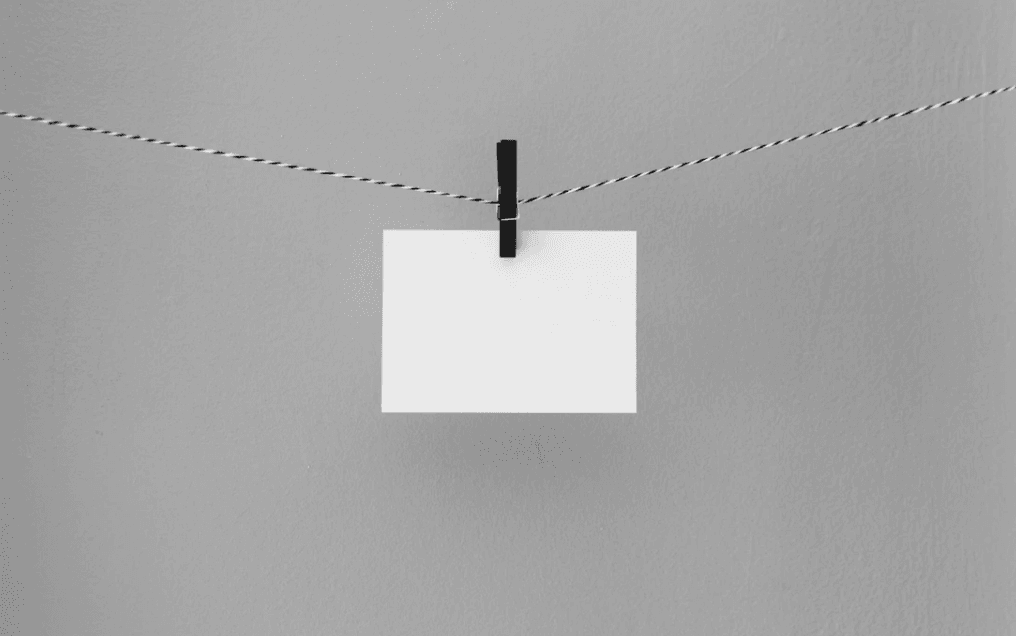Un nuovo modello americano di sanità pubblica che punta a potenziare il rapporto tra costi e qualità delle cure. Un progetto pilota da circa 6 milioni e mezzo di euro, sperimentato negli ospedali delle maggiori città. Così la Svezia cerca di rientrare dagli esiti di un trauma storico-politico, che ha generato un lento ma inesorabile declino del welfare. Dopo quasi settant’anni di Socialdemocrazia stretta, infatti, la Svezia è stata guidata per due mandati consecutivi dai Conservatori Moderati, sconfitti per un soffio alle urne lo scorso settembre.
Intanto, però, si era proceduto alla privatizzazione del pubblico, in netta contrapposizione con il passato. Errore pagato a caro prezzo dalla sanità. Oggi mancano medici svedesi e perciò è continuo il reclutamento di competenze dall’estero. Secondo stime recenti, mancano circa 2.000 infermieri in 68 centri di primo soccorso. Soppressi circa 900 posti letto. Privatizzato anche il servizio equivalente al nostro 118: le ambulanze scarseggiano e quindi talvolta arrivano in soccorso con ritardo letale. Finanziata dal pubblico ma appaltata al privato, infine, anche la gestione delle case di riposo, con risultati che sono già storia. Da un lato manager super pagati, dall’altro operatori sanitari arrivati a pesare i pannoloni degli anziani, prima di cambiarli. Se non erano abbastanza pieni di escrementi, li rimettevano.
Quali possono essere le dinamiche relazionali in un ambiente professionale così lontano e così diverso dal comune immaginario collettivo?
La testimonianza
Evitare ogni scontro diretto. Sottrarsi a qualsiasi tipo di confronto, sterile o costruttivo: sono emotivamente faticosi e soprattutto rischiano di evidenziare falle professionali. Circostanza che non deve verificarsi, non quando il termine di paragone è un collega straniero preparato. Meglio attenersi ai “protocolli”. Colpire alle spalle, forti della coesione del “branco” locale, che mai permetterà un suo membro venga messo alla berlina.
Possiamo sintetizzare così il quadro antropologico che spesso accoglie quanti vogliono integrarsi nel mondo della clinica. Ritmi blandi. Pausa pranzo inviolabile. È infatti durate il pranzo che si dà sfogo alle tensioni relazionali represse. Pettegolezzi fendenti, ritagliati su misura per diffamare lo “straniero” con un’aggressività insospettabile.
Il nostro testimone racconta la sua esperienza all’Akademiska Sjukhuset di Uppsala, ospedale noto agli stessi svedesi come il più ostico proprio per le relazioni interpersonali. È un giovane anestesista-rianimatore italiano, C.D., che, dopo anni di esperienza nelle rianimazioni e nelle sale operatorie, si è visto contestare i cardini della letteratura scientifica e della pratica clinica, in nome della superiorità di quanti avevano già marcato il territorio: autoctoni e stranieri di lungo corso, protetti da piccoli potentati svedesi.
Il medico chiede l’anonimato, perché nei poco popolati circuiti medici svedesi, tutti si conoscono e l’emarginazione omertosa per quanti osano denunciare è certa. “Nel corso dei primi interventi cui ho assistito in quell’ospedale – racconta – ho visto fare tutto ciò che mi era stato insegnato di non fare mai. Mediamente il contributo individuale nel lavoro e nelle relazioni era minimo, soffocato dalla supremazia del protocollo. Assistevo alla sistematica violazione di tutti i precetti medici, frutto di evidenze scientifiche, cultura e buon senso comune. Compreso l’accanimento nell’errore.
Ho visto il caso di una bambina di cinque anni, sottoposta ad un intervento di chirurgia vertebrale (la paziente era in posizione prona), alla quale il tubo endotracheale che garantisce la respirazione si stava sfilando a causa di un errato fissaggio. La piccola è stata salvata da morte certa, esclusivamente grazie al fortunato e abile intervento di un anestesista. Quando ho fatto notare che usando il metodo di fissaggio del tubo utilizzato in Italia e dal resto della comunità scientifica, questo non sarebbe accaduto, sono stato estromesso dalla sala operatoria della chirurgia vertebrale. La giustificazione dell’ala svedese dell’equipe, partita dagli infermieri della vecchia guardia che accusavano il conflitto generazionale rivendicando un super-ruolo in sala, e rincarata dai medici per opportunità di branco, è stata: “Noi abbiamo sempre proceduto seguendo questa routine. Non è mai successo niente”.
Poco dopo, per vendetta, mi hanno assegnato alla sala di Otorino, con una buona componente pediatrica, e dove anche per questo vengono svolte procedure estremamente rischiose. Qui si sovrappongono i campi di azione di chirurgo e anestesista. L’armonia in squadra è cruciale per la qualità e l’esito del lavoro. E qui le relazioni si sono fatte ancora più insostenibili. Il clima di calcolata diffidenza nei miei confronti venne opportunamente alimentata”.
Infine, un’immagine choc. “Va premesso che eravamo in una situazione in cui l’anestesista seguiva due-tre sale operatorie parallelamente. In Svezia non c’è un rapporto anestesista-paziente uno a uno, come in Italia e in Francia. Fissi restavano solo gli infermieri di anestesia. Nel corso di un intervento di chirurgia addominale maggiore, sono entrato in una sala per controllare il paziente in anestesia generale. Era ad addome aperto. Intorno a lui, solo un infermiere. Nessun membro dello staff chirurgico. Quindi, intervento sospeso. Ho chiesto spiegazioni. Risposta: “È l’ora di pranzo”. Tutti in pausa, perché tutti hanno il diritto di pranzare. Stop. Nessuno aveva avuto neanche la prudenza di chiamarmi affinché intervenissi, come tra l’altro la legge impone”.