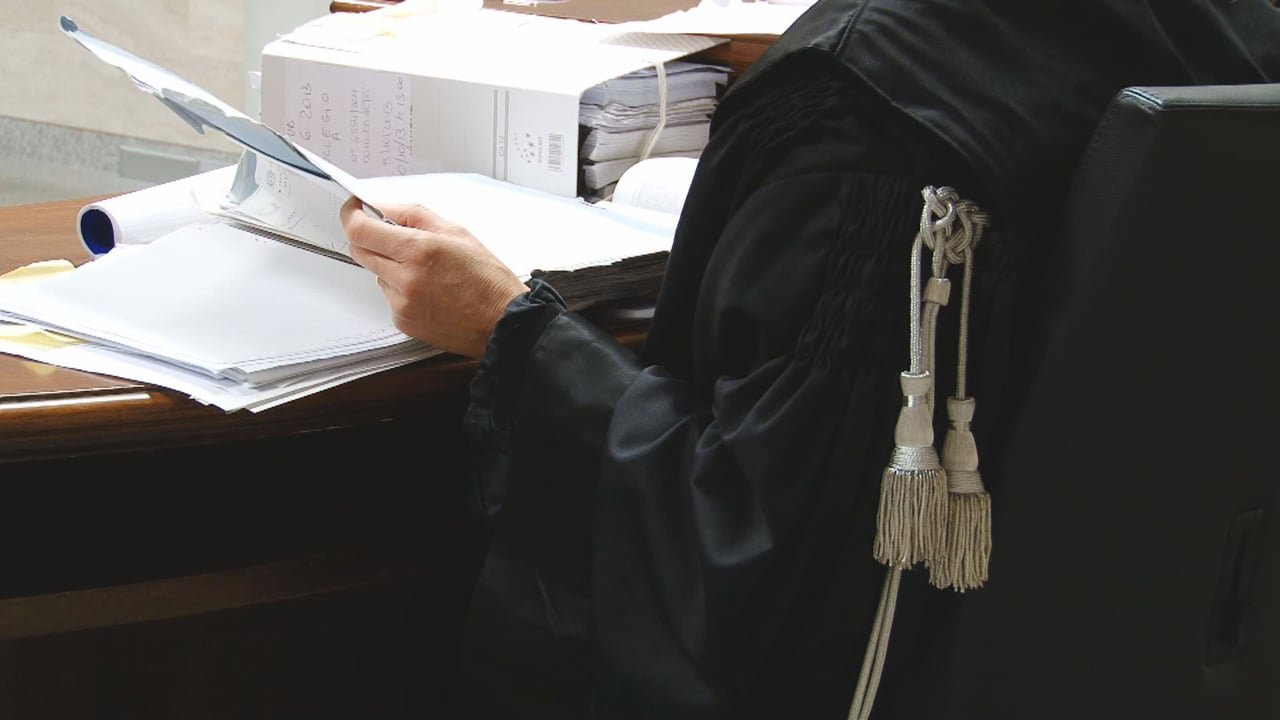Come il gatto di Schrödinger, che è allo stesso tempo vivo e morto finché non apriamo la scatola che lo contiene, l’IA aziendale esiste in uno stato di sovrapposizione: fallimento totale e successo straordinario coesistono nello stesso momento. Il report MIT ha aperto la scatola e ci ha mostrato entrambe le realtà.
La scissione schizofrenica delle organizzazioni
Viviamo una dissonanza cognitiva organizzativa profonda. Il 90% dei dipendenti usa ChatGPT in privato, producendo valore reale, mentre rifiuta gli strumenti enterprise ufficiali. Quali sono i motivi? Le aziende non sanno interpretare le esigenze dei singoli lavoratori? Oppure la fiducia dei lavoratori nelle soluzioni aziendali è al minimo storico? Michel de Certeau l’avrebbe chiamata “l’arte del fare”: tattiche quotidiane di appropriazione che sovvertono le strategie ufficiali. I dipendenti creano spazi di autonomia produttiva al di fuori del controllo manageriale. La Shadow AI Economy non è solo un fenomeno tecnologico: è l’emergere di economie parallele come forma di resistenza alla rigidità strutturale.
Il teatro organizzativo e le routine difensive
Lo schema del 95% di pilot che non scalano suggerisce quella che Chris Argyris definirebbe una “routine difensiva organizzativa”: le aziende mantengono l’apparenza di innovazione attraverso pilot continui senza reale intenzione trasformativa. Recitiamo l’innovazione per legittimarci agli occhi di investitori, clienti, dipendenti; forse anche di noi stessi. I pilot diventano rituali propiziatori, offerte agli dei della disruption digitale, senza vera fede nella trasformazione. È una forma di “learned helplessness” collettiva: continuiamo a investire nonostante il fallimento ripetuto, incapaci di modificare strategie nonostante feedback negativi costanti.
La tragedia dei common cognitivi
Le aziende medie implementano in 90 giorni, le grandi corporation in nove mesi o più. È il paradosso delle “diseconomie di scala cognitive”; maggiori risorse creano maggiore complessità decisionale, non accelerazione. Le grandi organizzazioni, con le loro risorse immense, dovrebbero dominare l’innovazione. Invece assistiamo a una tragedia dei common cognitivi: le strutture organizzative inibiscono capacità presenti a livello individuale. L’iper-agenzia del singolo (ancora una volta: il 90% usa l’IA a livello personale) coesiste con l’inerzia collettiva (il 95% dei progetti fallisce). Servono nuovi modelli organizzativi. Unità di cambiamento interno, ad alto potere decisionale. Aziende nelle aziende con un mandato preciso: far cambiare le cose.
L’illusione del controllo e la saggezza dell’incompletezza
Gli utenti preferiscono ChatGPT, “imperfetto ma controllabile”, a sistemi enterprise “ottimizzati ma rigidi”. Non è irrazionalità, ma saggezza inconscia: valorizzano l’agire sopra l’efficienza teorica. È una lezione profonda sulla natura umana: non vogliamo solo risultati, vogliamo partecipazione nel processo. L’illusione del controllo è più importante dell’ottimizzazione oggettiva. ChatGPT offre conversazione; i sistemi enterprise offrono dettatura.
L’IA come specchio di ciò che non va (e che non andava) nelle aziende
Il fallimento dell’IA enterprise non rivela limiti tecnologici, ma disfunzioni organizzative preesistenti. L’IA agisce come dispositivo diagnostico involontario, uno specchio che riflette rigidità strutturale, disconnessione tra livelli gerarchici, incapacità di apprendimento sistemico. Come il test di Rorschach rivela la psiche individuale, l’implementazione IA rivela la psiche organizzativa. Vediamo aziende che allocano il 50% del budget a sales e marketing (dove l’attribuzione è facile) ignorando il back-office (dove il valore è massimo). È il trionfo della visibilità sull’efficacia, del teatro sulla sostanza.
Il nuovo paradigma: disapprendere per evolvere
Il successo nell’era dell’IA richiede non apprendimento, ma “disapprendimento organizzativo”: abbandonare paradigmi consolidati, dismettere certezze, svuotarsi di saperi cristallizzati. Le organizzazioni devono disimparare il controllo per imparare la co-evoluzione, disimparare la pianificazione per imparare l’emergenza, disimparare la gerarchia per imparare la rete. Stiamo assistendo all’emergenza dell’Agentic Web: non solo agenti IA che si coordinano in autonomia, ma un nuovo paradigma organizzativo dove l’agency è distribuita, negoziata, emergente. Le strutture gerarchiche command-and-control diventano obsolete in un mondo dove l’intelligenza è liquida, accessibile, infiltrante.
Il paradosso temporale e la democratizzazione elitaria
Il MIT ha giudicato il successo in sei mesi, un tempo risibile per trasformazioni profonde. Le tecnologie trasformative richiedono quello che Bergson chiamava “durée”: non il tempo cronologico dell’orologio, ma il tempo vissuto della maturazione. Eppure, il report avverte: la finestra si sta chiudendo. È il paradosso temporale della trasformazione digitale: richiede pazienza strategica ma punisce chi aspetta troppo. L’IA promette democratizzazione delle capacità, ma produce una nuova élite: il 5% che realizza valore contro il 95% che fallisce. Mai così tanti hanno avuto accesso a così tanto potere computazionale, mai così pochi ne hanno estratto valore reale. La vera divisione non è tra chi ha accesso all’IA e chi no, ma tra chi sa trasformare l’accesso in valore e chi resta intrappolato nel teatro dell’innovazione.
La lezione nascosta: che cosa c’è dietro il 5% di successo?
Forse la vera domanda che il report solleva ma non esplora è: che cosa ha fatto di diverso quel 5% di organizzazioni che ce l’ha fatta? Quali caratteristiche organizzative, culturali, strategiche le distinguono? Hanno superato il learning gap con soluzioni tecniche o con approcci organizzativi innovativi? Hanno trovato il modo di far coesistere la Shadow AI Economy con l’innovazione formale? Le risposte a queste domande potrebbero essere più preziose di qualsiasi analisi dei fallimenti. Perché mentre è importante capire perché il 95% fallisce, è ancora più importante capire come il 5% riesce. Sono loro che stanno scrivendo il manuale per navigare la trasformazione IA – un manuale che ancora non abbiamo letto.
L’IA non è morta: sta mutando
Il report MIT pone questioni fondamentali sul nostro rapporto con l’intelligenza artificiale. Non è una questione di ROI o implementation rate, ma di come negoziamo la coesistenza con sistemi che sono allo stesso tempo strumenti e quasi-agenti, servitori e quasi-partner, estensioni e quasi-altri. La vera lezione del GenAI Divide non è che l’AI sta fallendo, ma che stiamo attraversando una fase liminale, un rito di passaggio collettivo verso forme di organizzazione e collaborazione che ancora non comprendiamo appieno. Il 95% di fallimento non è un verdetto, ma un sintomo: stiamo applicando logiche del ventesimo secolo a una tecnologia del ventunesimo.
L’IA non è morta. Come il gatto di Schrödinger, esiste in uno stato di sovrapposizione quantistica –rivoluzionaria e deludente, trasformativa e inefficace, presente e assente. Il report MIT ha fotografato questo momento di indeterminazione, scambiandolo per un verdetto definitivo. Ma finché la scatola resta aperta, entrambe le possibilità coesistono. E forse è proprio in questa coesistenza paradossale che risiede il futuro dell’IA aziendale.
L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.
Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.
Sottoscrivi SenzaFiltro
Photo credits: theaustralian.com