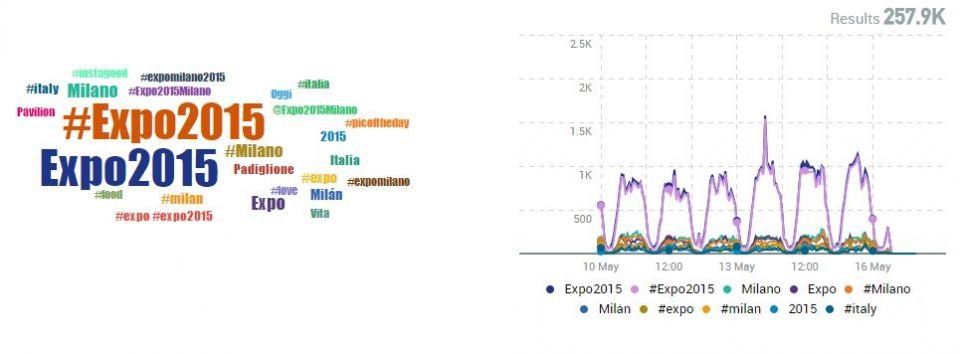C’è una strana malattia che si aggira pericolosa nei convegni e negli studi televisivi: la disruption. Da qualche mese politici, giornalisti, sindacalisti ed economisti nei loro interventi tendono infatti ad usare con una frequenza ormai invadente e fastidiosa la parola inglese disruption e l’aggettivo ad essa collegato, disruptive.
“Bisogna fare politiche disruptive”; per far crescere l’economia ci vogliono imprese e tecnologie disruptive; l’elezione di Trump è stata disruptive come la sua comunicazione; l’industria 4.0 è la disruption che farà crescere le aziende italiane. Anche a me di recente è capitato in un paio di trasmissioni di avere ospiti che la usavano e quando ho chiesto loro di tradurmi il concetto in italiano (se non altro per rispetto dei telespettatori che non conoscono l’inglese) ebbene, ciascuno attribuiva a disruptive un significato differente. Come spesso accade per le parole di moda e importate, questo nuovo termine viene usato per coprire significati molto ampi: dirompente, tecnologico, avanzato, innovativo, spiazzante, trasgressivo, cool, figo e molto spesso sbuca in connessione appunto con quel processo industriale di cui tanto si parla oggi e che ricade sotto l’ampissima definizione di Industria 4.0.
Ora, di per se stessa la parola disruptive in inglese ha una connotazione negativa. Disruptive è lo studente che in fondo alla classe fa confusione e disturba tutti, il passeggero ubriaco che in aereo sbraita e viene fatto scendere, è un qualcosa insomma che crea problemi. La fortuna di questa parola in economia inizia però 21 anni fa quando uno sconosciuto professore della Harvard Business School, Clay Christensen, pubblicò un articolo che più o meno diceva così: le grandi aziende devono stare attente perché i loro business consolidati possono essere messi in pericolo da outsider che arrivano sul mercato con prodotti magari di tecnologia inferiore o allo stadio iniziale ma che offrono alternative a basso costo a soluzioni già esistenti; il risultato sarà che queste ultime in poco tempo perderanno significative quote di mercato. Pian piano questi nuovi prodotti o tecnologie (che Christensen battezzò appunto disruptive) si evolveranno e faranno fallire le aziende tradizionali che producono prodotti e servizi noti e sperimentati.
Chiedo aiuto ad Alberto Di Minin, Docente di Management presso la Scuola Superiore Sant’Anna, esperto di innovazione che si divide tra Pisa, l’Università di Berkeley e quella cinese di Chongqing.
Come si fa a capire se una tecnologia o un prodotto è disruptive?
Il concetto chiave sta in una singola definizione: good enough, che si potrebbe tradurre come buono abbastanza, accettabile, va bene lo stesso! Nell’industria musicale, ad esempio, ciò che girava sui primi MP3 era di qualità nettamente inferiore rispetto ai CD che però costavano molto di più: ma per i giovani i file audio erano good enough. Pian piano l’MP3 ha acquistato quote di mercato, la qualità è migliorata e ha fatto fuori l’industria dei CD.
Interessante, faccia altri esempi.
Le compagnie Ryanair e Southwest hanno sviluppato modelli di business disruptive: nei primi low cost si viaggiava davvero in modo scomodo, i passeggeri venivano trattati con sgarbo se non vessati ma la contropartita era che si riusciva a volare con lo stesso prezzo di un treno regionale: andava bene cosi! Le grandi compagnie aeree, di fronte alla perdita di quote di mercato, hanno cercato di reagire togliendo gli snack, i gadget, ma alla fine senza riuscire a competere con Ryanair, che nel frattempo si è invece evoluta e ha migliorato il suo rapporto prezzo-qualità, strozzando sempre di più le possibilità di sviluppo dell’offerta un tempo dominante. La Dacia Duster, il fuoristrada franco rumeno col motore Renault, è un auto disruptive: non ha la qualità di un SUV Toyota o Mercedes ma costa meno della metà, è grande, grossa e 4×4: per molti va bene così e la gente la compra.
Uber, il servizio di taxi fatto da privati, è disruptive?
Qua il dibattito è aperto. Christensen sostiene che Uber non è disruptive perché offre subito un servizio migliore rispetto ai taxi tradizionali e non un servizio più economico ma inferiore, come vorrebbe la sua teoria. Ma non penso che i tassisti sarebbero d’accordo e gli utenti stessi lo percepiscono come un’innovazione di rottura. Qua veniamo al punto: oggi nei giornali e nei convegni qualsiasi cosa sia innovativa viene subito bollata come disruptive. Si parla a sproposito di disruptive innovation per parlare di innovazione pura e semplice. L’innovazione di successo è creazione distruttrice, lo diceva l’economista Schumpeter più di cento anni fa: una ricerca scientifica che porta sul mercato un farmaco di successo rende obsoleti i prodotti esistenti, ma non è necessariamente disruptive nel senso di cui si è discusso prima. Eataly, i food store di qualità di Oscar Farinetti, soprattutto all’estero sono un successo ma non sarebbe corretto per questo parlare di modello di business disruptive. L’originale modello di business di Netflix (basato sulla spedizione a domicilio dei DVD e poi sullo streaming video) era disruptive e provocò la fine di grandi leader di mercato come Blockbuster, offrendo soluzioni good enough che si sono evolute nel tempo fino a diventare standard di mercato.
Veniamo al punto fondamentale: l’industria 4.0 è disruptive?
L’industria 4.0 è l’applicazione alla manifattura di tecnologie superiori, digitali, innovative. E’ possibile che in certi casi verranno creati manufatti, prodotti disruptive, ma è probabile che nella maggior parte dei casi non lo saranno. Ci troveremo davanti a grandi applicazioni, a volte superiori sotto ogni punto di vista che renderanno obsoleti sistemi produttivi precedenti, ma che non dovrebbero essere definiti disruptive come intendeva Christensen. La realtà è che nessuno oggi come oggi è in grado di dirlo, ma è fondamentale monitorare lo sviluppo dei modelli di business degli operatori del settore.
Detto questo, appare ormai abbastanza chiaro come disruptive sia un contenitore che ciascuno può riempire come preferisce per tentare poi di piazzare la merce con più o meno onestà. Negli Stati Uniti ad esempio, soprattutto in Silicon Valley, cominciano ad esser di moda curriculum di candidati che includono una sezione dedicata alle loro disruptive skills. A giudicare dalle discussioni sui forum web sembra sia apertissimo il dibattito sull’utilità di una sezione del genere. Le reazioni oscillano tra gli entusiasti possibilisti e gli emuli di Fantozzi (“E’ una boiata pazzesca”). Vedremo come quest’ultima novità verrà accolta dalle nostre parti dove piazzare un curriculum è già di per se stesso un evento disruptive, figuriamoci trovare un lavoro.
(Nella foto: Clayton Christensen. Credits: newyorker.com)