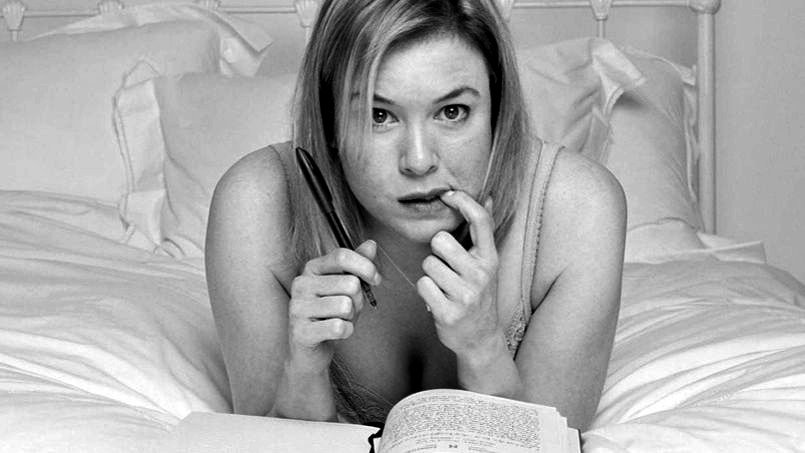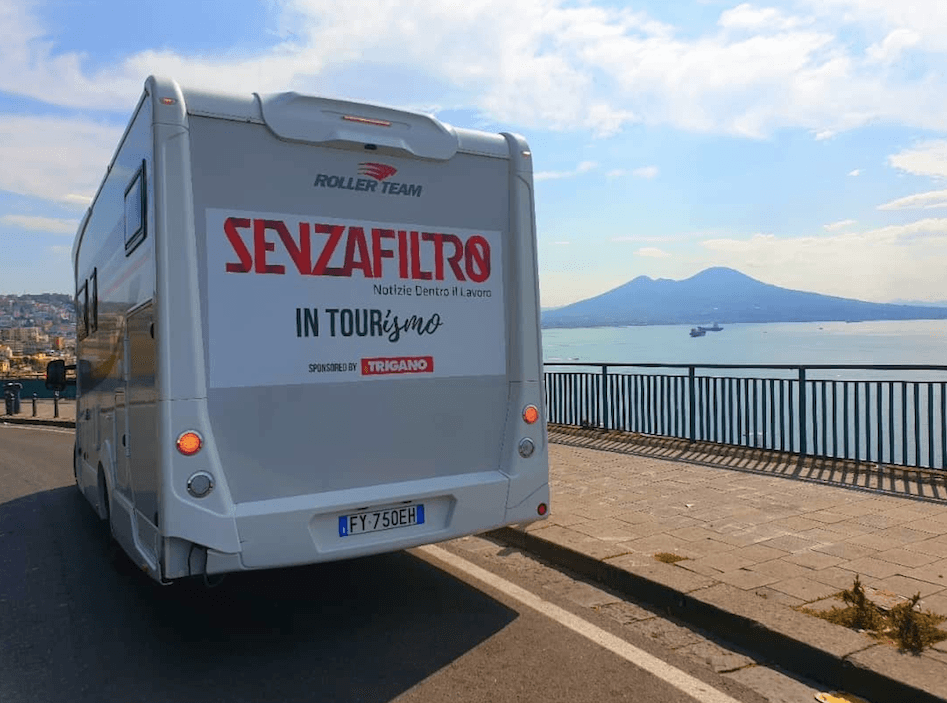Di tutto ciò che indossiamo per andare al lavoro, di rado ci sistemiamo per bene anche qualche sentimento. Portarli sgualciti non ci dà alcun pensiero, peggio le pieghe indecise sui pantaloni.
Lavorare è ad ogni istante un esercizio di sentimenti anche se nessuno prova mai ad indagarli quando ci chiedono di compilare un curriculum o durante un colloquio di selezione o nella ruota delle giornate, eppure sono cose serie. Le competenze non sono sentimenti, guai a confonderle.
“Lei ha alle spalle un ottimo percorso di formazione ed esperienze professionali di alto profilo ma se le chiedessi di parlarmi della fiducia cosa saprebbe dirmi? In alternativa vorrei che mi descrivesse a quali sentimenti si ispirerebbe per comunicare un licenziamento inevitabile”. Sarebbe bello.
Il solo pensiero di manifestare emozioni sul posto di lavoro fa ancora paura a troppa gente e non si tratta di innamoramenti o sbandate a cui imprese e giurisprudenza cercano dal dopoguerra in poi di trovare la quadra su impianti di varia natura, qui si sta parlando d’altro. Dentro il concetto di lavoro precipitano in caduta libera sottoinsiemi complementari e diversi: risultati, produttività, affari, contratti. Sembra impossibile cucirci intorno una qualsiasi dimensione valoriale perché l’economia degli ultimi secoli ha insistentemente messo i puntini sulle i mostrandoci come incolmabile la distanza tra il suo punto di osservazione e qualsiasi interrogativo morale. Eppure gli economisti più lungimiranti hanno iniziato da tempo a rimodellarsi, configurando il proprio ruolo persino come analisti del comportamento umano; al tempo stesso, nei medesimi ultimi decenni, le relazioni sociali hanno iniziato a riflettersi nelle relazioni di mercato. Di fondo c’è una verità tanto intima e inconfutabile quanto scomoda da ammettere: le persone decidono bilanciando sempre tra costi e benefici delle opzioni in ballo e scegliendo sempre la soluzione che credono li porti alla massima utilità o al maggior benessere. Allora vivere sembrerebbe voler dire calcolare, lavorare altrettanto.
Gary Becker, economista dell’Università di Chicago, già nel lontano 1976 teorizzava senza alcun pudore il suo pensiero dentro L’approccio economico del comportamento umano, offrendone una spiegazione concreta tramite l’esempio del matrimonio e del divorzio: per lui una prospettiva calcolatrice non toglieva alcun romanticismo alle relazioni umane. “Coloro che resistono all’approccio economico spiegano il comportamento umano come il risultato confuso e imprevedibile dell’ignoranza e dell’irrazionalità, dei valori e dei loro frequenti inspiegabili cambiamenti, della consuetudine e della tradizione, della conformità indotta in qualche modo dalle norme sociali”. A lui quella confusione proprio non piaceva.
Un’azienda non è una famiglia, i colleghi non sono fratelli, il capo non è nostro padre. Questi punti fermi, a dir poco sacrosanti, non escludono però una elasticità di cui il lavoro ha sempre più bisogno: una elasticità dei modelli e dei codici di relazione, una fessura aperta quel poco che basta a far passare l’aria.
Che male c’è ad abbassare ogni tanto le difese senza la paura di restare nudi dentro un recinto che abbiamo sempre creduto incapace di proteggerci? Magari ci sbagliamo o siamo proprio noi a spaventare gli altri. Il lavoro non sarà mai casa nostra ma è pur sempre la dimensione che più di ogni altra abitiamo. Mascherarci ogni giorno come fosse Carnevale fa sorridere impietoso anche Pierrot.
Due rette parallele, ecco come viviamo solitamente le nostre vite private e professionali. O due coinquiline perfette sotto lo stesso tetto, senza cedere mai alla tentazione di un subaffitto a terzi.
La soluzione potrebbe stare nel dosaggio. In pittura, ogni colore si compone di tre parti: tonalità, luminosità e saturazione. La purezza esclude ogni pigmento bianco o nero. La luminosità racconta di quanto bianco o nero c’è nel colore percepito. La saturazione è la sensazione visiva che rende pallido o ricco il colore, forte o debole la tonalità. Può valere anche per i sentimenti al lavoro: non è detto che debbano accecare tutti ma almeno un po’ di purezza garantiamola.
Il sentimento è una mancata indifferenza, un processo che guarda dall’alto in basso la ragione.
Il calcolo è impegnativo, così come la paura. La fiducia ha il cuore debole ma le mani grandi.