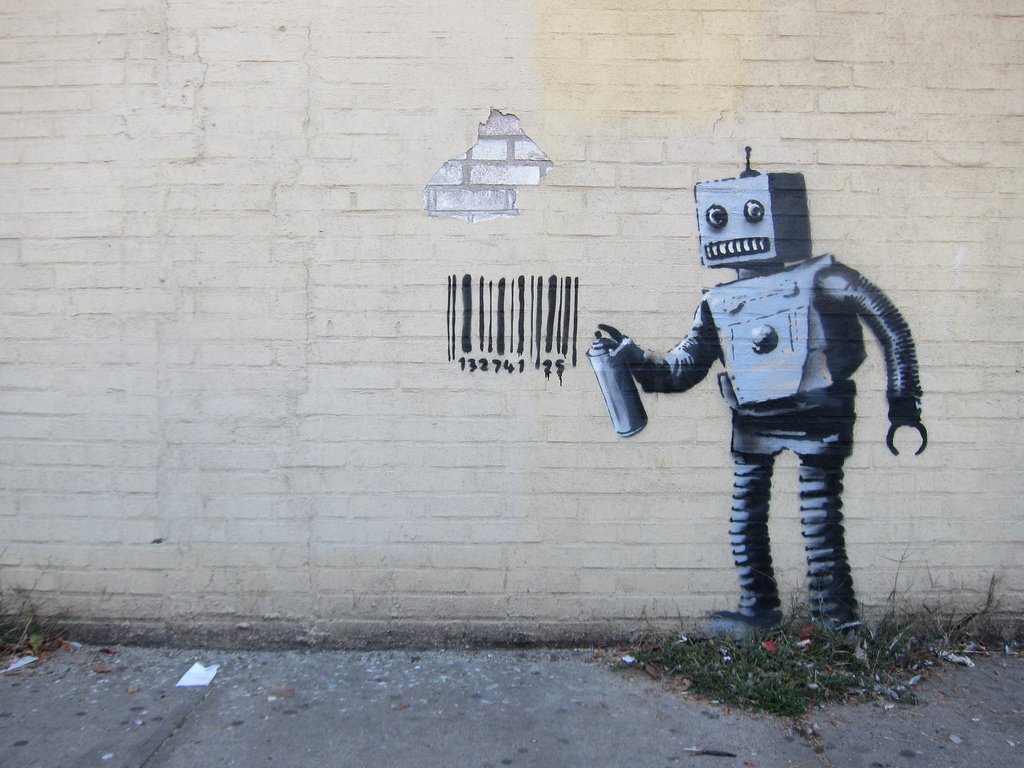Quando Leonardo da Vinci decise di cercare fortuna alla corte degli Sforza, compilando il più famoso dei curriculum vitae falsi documentati, con ogni probabilità non era consapevole di essere un cervello in fuga. Il concetto stesso di confine, in un’epoca in cui l’Italia era un patchwork di Stati e i rapporti erano soprattutto conflittuali, non era particolarmente chiaro, né – paradossalmente – invalicabile per chi intendesse cercar fortuna altrove.
La querelle attualmente in corso tra i governi italiano e francese sulle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio vinciano, volte a stabilire quale sia da considerarsi la sua vera patria, sono un ottimo pretesto per riflettere su come e quanto la Toscana sia un brand nel mondo. Ma anche per ricordare che, quando vi nacque Leonardo, l’Italia non esisteva ancora, mentre in Francia risiedette solo per tre anni.
La Toscana dell’export e della moda
Vocazione al commercio e alle arti, ma anche grande capacità di vedere il guadagno negli affari altrui (non a caso nasce a Siena nel 1472 la prima banca della storia) sono caratteri che portano naturalmente all’apertura verso lo “straniero”, andandolo a trovare a casa sua oppure aprendogli le porte – o i forzieri – per trarre vantaggio dalle sue capacità. E siccome di questi profitti occorre tenere traccia, a metà del Quattrocento, a Sansepolcro in provincia di Arezzo, nasce il frate matematico Luca Pacioli: colui che gettò le basi del metodo della partita doppia con cui, a tutt’oggi, si tiene nota dell’andamento della gestione d’impresa.
Dai tempi di Leonardo di geni del suo calibro non se ne sono visti più molti in giro, ma non per questo i toscani hanno smesso di ingegnarsi. Analogamente a quanto è avvenuto in altre regioni italiane, l’economia della Toscana si è sviluppata per distretti. Ancora oggi, nonostante la crisi del 2008 abbia modificato in maniera importante la composizione delle sue imprese, le più recenti analisi sull’export indicano nel distretto moda (guidato da pelletteria e calzature, prevalentemente a Firenze, e a monte dalla concia e calzature di Santa Croce) quello che oggi gioca il ruolo più importante, con due degli otto miliardi complessivi di valore.
I brand del lusso hanno nel tempo mostrato la capacità di consolidare un ruolo di traino dell’economia del territorio, costituendo una notevole anomalia rispetto alle dimensioni medie delle imprese toscane, sia in termini di fatturato che di addetti, dato che il 61% delle imprese toscane ha un solo addetto e il 95% che comunque non ne raggiunge dieci.
Un recente studio dell’Irpet, condotto insieme alla Banca d’Italia, aiuta a comprendere meglio il percorso di questa regione in rapporto a quello delle altre zone del Paese. Dietro a giganti economici come Piemonte e Lombardia compare proprio la Toscana, sia per incidenza relativa delle esportazioni verso altri paesi e regioni che per incidenza del valore aggiunto dei paesi esteri sul totale delle esportazioni.
Se la forte incidenza dell’export è dovuta in parte alla capacità delle poche grandi imprese che operano nel settore del lusso, molto è da riconoscere alle piccole imprese, che sono state in grado di giocare un ruolo positivo all’interno di filiere produttive che si sono disgregate a livello mondiale a causa della globalizzazione. Sistemi di creazione del valore che richiedono (e apprezzano) le specializzazioni quasi artigianali delle maestranze toscane.
In un mondo in cui il consumatore è in grado di comprare ovunque un prodotto che quasi mai è realizzato interamente in un solo Paese, la capacità di leggere le tendenze della domanda è però fondamentale. In questo senso, il ruolo che le regioni – intese come istituzioni – sono chiamate a giocare è molto diverso da quello che, in passato, era richiesto da distretti caratterizzati da produzioni omogenee, che contavano su domanda stabile nel tempo.
Molta testa, poco fiuto: la Toscana che non investe su se stessa
VUCA è un acronimo che ci racconta di quanto oggi sia difficile prevedere il domani, per chi fa impresa. Volatilità, incertezza, complessità e ambiguità caratterizzano gli scenari in cui chi vuole rischiare in proprio è chiamato a operare.
Scorrendo l’elenco delle dieci aree metropolitane del mondo con i maggiori investimenti in venture capital non troviamo neanche una città italiana. Ma è interessante apprendere come proprio San Francisco, che svetta su tutte le classifiche di questo genere, sia passata dal dare battesimo al 5,4% dei brevetti USA nel 1979 al 17% del 2015. La protezione della proprietà intellettuale è la certificazione della capacità di un imprenditore, ma anche ciò che gli consente di dargli valore.
Per quanto la Toscana ospiti sul suo territorio realtà di prim’ordine nella ricerca (solo per citarne alcuni, la Normale di Pisa e la Scuola superiore Sant’Anna) non dispone di “periscopi imprenditoriali” dello stesso livello. In un mondo sempre più interconnesso, dove il valore non si costruisce tutto in un solo posto, l’intraprendenza, che ancora anima i toscani, richiede di interfacciarsi con competenze e capacità senza intermediazione.

Marco Cappellini: vendere il bello, ma non in Italia
Se un gigante come General Electrics ha deciso di spostare il suo quartier generale a Boston, non ci stupirà scoprire che imprenditori brillanti come Marco Cappellini, che abbiamo incontrato all’interno del complesso delle Murate di Firenze, rimpiangono di non aver radicato il loro progetto in un’altra città. E non sarà di conforto scoprire che la scelta ricadrebbe, ancora oggi, su Londra, ma anche Berlino, e non Milano.
Marco Cappellini, CEO di Centrica e VirtuItaly, con la sua impresa ha voluto far viaggiare le meraviglie dell’arte, portando queste esperienze immersive a chi non ha la fortuna di poterle vedere di persona. Chi non vorrebbe letteralmente volare all’altezza dei mosaici del paradiso del Battistero di Firenze, scoprendo quello che il loro creatore ha voluto esprimere lavorando ad altezze inaccessibili ai più? Collaborazioni prestigiose costellano una storia ormai ventennale di costante sviluppo tecnologico.
Il luogo dove incontro Marco è letteralmente stipato di illuminatori, display e macchine da ripresa che, ci tiene a precisarlo, “sono solo una piccola parte dell’hardware e del software su cui dobbiamo continuamente investire per rimanere sempre un passo avanti alla concorrenza, su cui abbiamo ancora un vantaggio dato dal fatto che abbiamo iniziato prima di tutti, nel mondo. Il nostro tentativo adesso è uscire dall’Italia, perché qui rischiamo di perdere il tempo. Quando andiamo in banca a chiedere di farci finanziare un investimento ci chiedono quali sono i nostri asset. È difficile spiegare che miglioriamo la possibilità di vendere il bello, quando alla fine ciò che sono in grado di leggere è sempre e solo un budget delle vendite o un business plan”.
Marco non è sconsolato, ma pienamente consapevole del fatto che nel suo Paese i canali di accesso a scuole, musei e istituzioni sono molto complicati.

La Toscana e i finanziamenti male impiegati
Dal Quattrocento a oggi di acqua sotto i ponti dell’Arno ne è passata molta, e se Leonardo era capace di portare un genio così brillante agli occhi delle corti di un’Europa ancora solo geografica, oggi per viaggiare nel mondo è indispensabile poter contare, più che su una buona idea, su un sistema in grado di darle le chances di successo che merita in tempi rapidi.
Per quanto la Toscana sia tra le regioni d’Italia più brave e sfruttare i finanziamenti europei all’innovazione e per il supporto allo sviluppo d’impresa, il modo in cui questi denari sono spesi sembra ancora inadeguato rispetto alle esigenze globali. 217 giorni medi per l’erogazione degli aiuti è un tempo che ucciderebbe qualsiasi progetto rivoluzionario, se dovesse contare solo su quegli aiuti.
Di recente un amico ha deciso di trasferirsi in Olanda per continuare a lavorare sulla ricerca in campo biomedicale, “cogliendo le straordinarie opportunità che quel Paese è in grado di dare e che voglio dare a mio figlio”. La Toscana rimarrà, mi ha detto, il posto dove vorrà tornare per le ferie.
Curioso che il suo contributo all’economia toscana sarà, a quel punto, omologato a quello di un turista belga: al di là del campanilismo di chi si appassiona a questioni di bandiera, è la differenza tra l’esportazione di un patrimonio di competenze (che si è formato in una scuola italiana e toscana, a fronte del quale possiamo sperare in quindici giorni di ferie l’anno) e la vendita della tecnologia che da quelle competenze scaturisce (di cui beneficerà uno spin off dell’università belga) che si dovrebbe fondare una strategia in grado di rendere attraente la regione. Non solo per le sue scuole, ma anche per quello che verrà dopo.
Export Toscana supera 8 miliardi di euro. Abbigliamento Empoli e concerie in calo