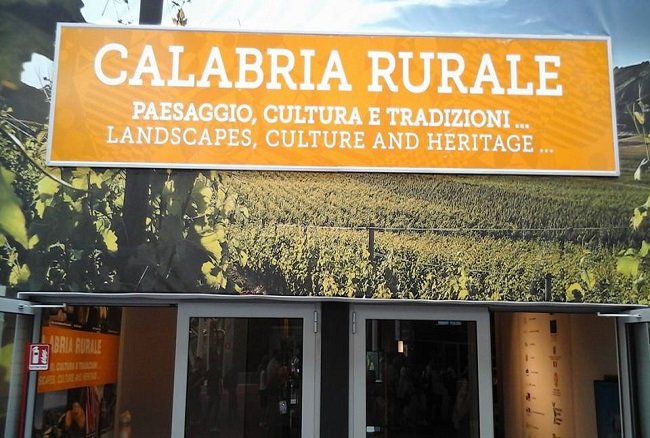“La vita è quello che capita mentre stai facendo altri progetti”, diceva John Lennon. C’è però chi i progetti li fa succedere, e anche coincidere, con la passione della sua vita, tassello dopo tassello, mantenendo intatta la motivazione anche di fronte agli ostacoli. Questa è la colonna portante – e anche un po’ sonora, visto che parleremo di emozioni – dell’avventura professionale dello storyteller, designer di esperienze e creatore digitale Mick Odelli. Cofondatore di DrawLight, impresa creativa made in Padova ma lanciata ben oltre i confini italiani, e insieme narratore dinamico; perché “la curiosità è la benzina della creatività”, afferma convinto.
Da tempo naviga attraverso diversi canali espressivi approdando anche su YouTube – il programma si chiama Just Mick TV e sta raccogliendo numerosi consensi – con la sfida di “divulgare contenuti dell’ambito delle neuroscienze, emozionando”. Immergere nelle emozioni è, infatti, non solo l’obiettivo del suo lavoro ma anche la miccia che l’ha portato a raggiungere gli attuali traguardi.
Tutto parte nel 2008, quando prende vita l’avventura imprenditoriale targata DrawLight, il cui fulcro è rappresentato dal creare installazioni sensoriali, emotive e audiovisive. “Abbiamo cominciato facendo immagini per cataloghi d’interni e le agenzie di comunicazione si sono interessate a noi”, racconta Mick Odelli ripercorrendo gli esordi. “Al tempo la grafica in 3D era innovativa e per questo ci veniva proposto di sperimentare. Incuriositi, abbiamo colto la sfida e l’obiettivo fin da subito è stato quello di emozionare.” Oggi la squadra è formata da circa dodici persone: “La nostra forza risiede soprattutto in due aspetti: la curiosità, per me al centro di tutto, e la flessibilità. Infatti non siamo legati a una tecnologia specifica, ma utilizziamo quello che serve per creare l’effetto desiderato.”

Il vostro portfolio rivela nomi importanti. Ora lavorate molto grazie al passaparola, ma all’inizio come vi siete fatti conoscere? Difficilmente qualcuno arriva a googlare “installazioni digitali immersive”.
Vero. Devo essere sincero: in origine c’è stato un investimento molto grosso da parte nostra e lo dico sentendo ancora una ferita addosso. È capitato anche che lavorassimo per un mese intero a livello totalmente gratuito, come nel caso di un evento che ha coinvolto circa mille persone e che ci ha fatto da cassa di risonanza. Poi c’è stato il rapporto con le agenzie di comunicazione che ci chiamavano per partecipare alle gare con grandi marchi: per loro eravamo la ciliegina sulla torta in fatto di originalità. Per il resto non ho mai pensato che se fai una cosa particolare hai vinto: tutt’altro. Soprattutto in Italia, dove i tempi sono lenti e la gavetta tanta. Dico una cosa forte: spesso la capacità di restare in piedi di un’azienda non è data dalla super idea, ma da quanto continui a provare in una certa direzione nonostante tutto. C’è chi si ferma o cambia strada; la nostra forza è stata quella di continuare a battere il ferro in un contesto di nicchia dove altrimenti non ci sarebbe lavoro per tutti. Servono sicuramente tanta energia oltre all’idea, alla squadra, ai soldi e al tempo. Bisogna poi proporre le cose al tempo giusto.
Nel senso di essere dei pionieri puntuali?
Ride. Esatto, anche se il vero pioniere è quello che rischia prima di te e magari non ce la fa. Occorre studiare e capire bene il mercato senza proporre le cose con troppo anticipo o quando gli altri l’hanno già fatto. Bisogna, insomma, trovare l’interlocutore giusto e sapere che quello che hai in mente necessita di tempo. Questo ti evita frustrazioni e ti insegna a essere paziente.
Flessibilità e dinamicità: sembra che l’obiettivo generale sia stato chiaro fin da subito per te e per i tuoi colleghi.
Sicuramente! Una squadra che crede in te permette non solo di creare un bellissimo contesto di lavoro, in cui ci si fa forza l’un l’altro, ma anche di alimentare costantemente la curiosità. In questo io sono come un bambino che spinge per fare sempre di più. La nostra particolarità è data dal fatto che il cliente si trova davanti a una squadra di creativi che inventa un’idea da zero utilizzando la tecnologia come strumento di espressione, ma senza renderla soverchiante. Lavoriamo su quattro tematiche: arte, tecnologia, storytelling e neuroscienze. La curiosità poi unisce tutto. Di solito se sei un’azienda piccola devi dimostrare cosa fai in modo chiaro per essere riconosciuto come brand. Dopo undici anni di attività posso dire che proprio la non identificazione è stata la nostra risorsa, precorrendo i tempi.
La squadra di DrawLight è composta da persone che provengono da ambiti di studio diversi. Qual è la sfida più complessa e allo stesso tempo l’aspetto più intrigante di coordinare e far dialogare un team così fortemente multidisciplinare?
All’inizio non è stato semplice. Ad esempio nel 2016 ho cominciato a coinvolgere la consulenza di una ricercatrice in neuroscienze. Se il nostro fine è, infatti, quello di provocare determinati effetti, è necessario capire come funzioniamo a livello cerebrale. Affiancare a un creativo che ha sempre fatto bene una consulente che dà delle linee guida può risultare difficile da metabolizzare, ma quando lavori non bisogna mai dimenticare l’importanza di correre insieme. Per questo cerchiamo sempre di portare avanti una cultura aziendale che permetta di far abbracciare a tutti la stessa visione attraverso una dinamica orizzontale, priva di gerarchie. La gerarchia viene adottata solo quando c’è da prendere una decisione veloce. Puntiamo molto alla condivisione, e se hai un gruppo ristretto di età giovane questo è secondo me più fattibile. Anche le decisioni più importanti vengono prese collettivamente. Anni fa per scegliere una figura abbiamo fatto una votazione sui tre “finalisti” rimasti permettendo a chi la pensava diversamente di rendersi conto di alcune dinamiche che in quel momento non considerava. Questo richiede tempo ma ne vale la pena, soprattutto in un contesto creativo, dove se ci sono dei disaccordi diventa un vero casino.
Restiamo in tema in maniera provocatoria. Chi fa arte – e non solo – dimostra che è possibile provocare emozioni senza bisogno di alcuna consulenza da parte di esperti in neuroscienze. Coinvolgerle non è quindi cercare una sorta di legittimazione al proprio lavoro creativo?
Può essere anche quello, sicuramente. Ma quando occorre dare conto a un cliente bisogna assicurarsi che quello che fai non provochi un effetto contrario all’obiettivo richiesto. L’artista spesso può fregarsene della reazione; nel mercato non è possibile. Non esiste la certezza assoluta: semplicemente seguiamo delle linee guida che migliorino il nostro lavoro ponendoci qualche domanda in più sul visitatore. Ragioniamo sulla maggioranza. Ad esempio, se un video ha un ritmo più veloce del battito cardiaco tende ad attivare la persona mentre se è più lento la rilassa. L’importante è non lavorare allo sbaraglio.
Voi lavorate soprattutto nell’ambito degli eventi. Avete progetti di immersione legati ad altri contesti più quotidiani, come ospedali, scuole, sale d’attesa?
Assolutamente sì. Abbiamo iniziato a fare digital wellness, e in questo caso l’apporto delle neuroscienze è essenziale per garantire l’effetto di benessere. Vedo molto potenziale nelle installazioni immersive permanenti, direzione da sviluppare. Spesso ci contattano studi dentistici, e sarebbe bellissimo fare qualcosa in ambito sanitario, ma occorre trovare il partner giusto disposto a rischiare con noi nel mercato.
Al termine di un’esperienza “immersiva” come riuscite a sapere se i partecipanti hanno avuto la reazione che vi aspettavate? Esiste una “customer satisfaction emozionale”?
Sì, per noi è fondamentale avere una restituzione. Abbiamo anche utilizzato questionari e realizzato valutazioni rigorose perché in quest’ambito non si possono fare passi falsi.
Hai fatto della narrazione il tuo lavoro. Che cosa significa per te essere uno storyteller nel 2020 e per di più di tematiche che intrecciano scienza ed emozione?
Fare storytelling per me significa prima di tutto portare una persona in un altro mondo, in uno stato emozionale che permetta di fare un viaggio. Questo richiede di orchestrare tutta una serie di elementi come musica, ritmo e immagini per rendere il messaggio chiaro e fruibile toccando la parte delle emozioni. Quello che facevo prima al bar con gli amici parlando di qualcosa che mi aveva colpito ora lo faccio digitalmente. Perché la bellezza va condivisa.