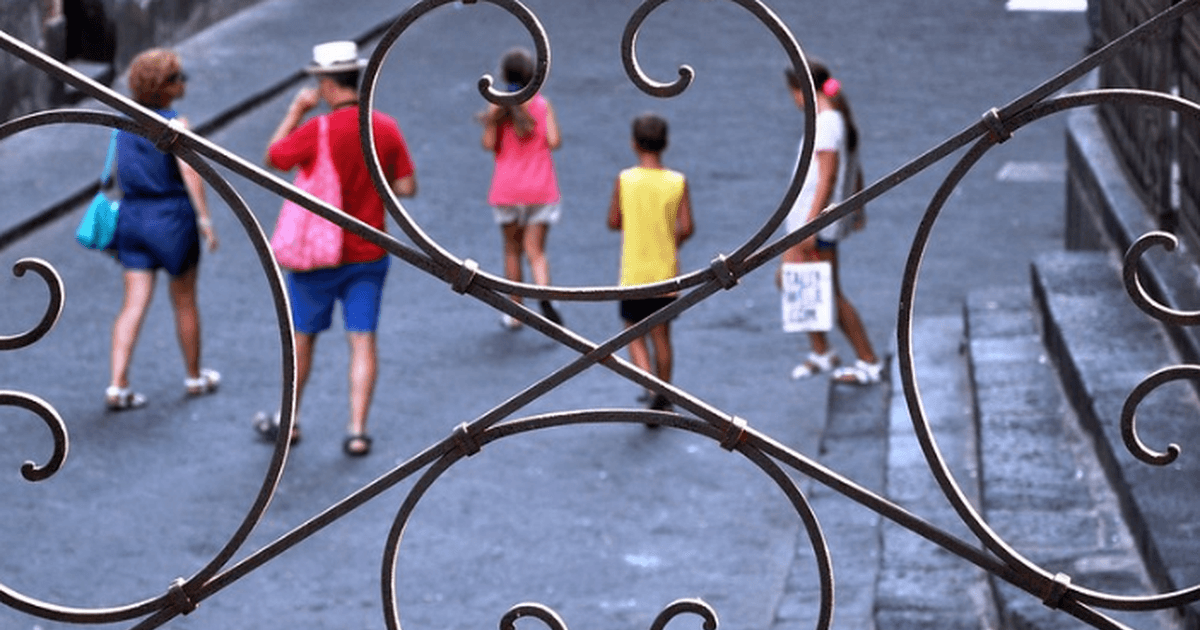È difficile non ricordare, quando si esamina lo stato attuale dell’industria tessile pugliese, quello che succedeva dieci anni fa, nel pieno di un cataclisma. La Gazzetta del Mezzogiorno, il principale quotidiano regionale, il 13 marzo 2009 proponeva un articolo piuttosto funereo ma realistico, con questo titolo: Crisi e “lavoro nero”: il tessile di Puglia boccheggia. Sotto, il sommario recitava: «I laboratori chiudono, uno dopo l’altro, spazzati dallo tsunami della crisi economica. Quattro anni fa il comparto contava su oltre 6.000 imprese e 28.000 addetti. Oggi le imprese attive tessili iscritte alle Camere di commercio sono 1.751 e danno lavoro a 6.985 persone».
Insomma, tra 2005 e 2009 erano spariti più di due terzi delle aziende e il 75% dei posti di lavoro, senza dimenticare gli occupati nell’indotto, che erano almeno il doppio di quelli assunti direttamente. Il quadro descritto era drammatico: «L’eutanasia dell’industria tessile e della moda pugliese sembra inarrestabile. (…) Una catastrofe, insomma. A cui hanno contribuito le grandi griffe: esternalizzazione, flessioni delle vendite, minor capacità di acquisto, addio soldi ai fasonisti».
Appena dieci anni fa, per fronteggiare la crisi, molte aziende adottavano il meccanismo della chiusura e della successiva riapertura per beccare qualche sgravio contributivo. La cassa integrazione dava un po’ di fiato, anche se le imprese – in gran parte sotto i 15 dipendenti – non potevano ottenere gli ammortizzatori sociali. Qualche imprenditore, nel tentativo di pagare un costo del lavoro sempre minore, aveva spostato tutto o quasi in Albania, sull’altra sponda dell’Adriatico, e anche in Romania, Polonia o Tunisia.
Puglia, industria tessile in ripresa. E poi arrivò il New York Times
E oggi, nel 2019? Per chi è riuscito a stare a galla – cioè un terzo scarso delle aziende di un tempo, nelle quattro aree pugliesi che hanno questa vocazione (Salento, Martina Franca con la Valle d’Itria, Putignano e dintorni, Nord Barese con la provincia di Barletta-Andria-Trani) – il vento è tornato a soffiare per il verso giusto. Le produzioni di bassa qualità sono scomparse o sono tuttora all’estero, per lo più in Albania. L’alta qualità invece ha ancora qui le sue radici, con produzioni commissionate dalle grandi firme della moda italiana e internazionale e con varie aziende che stanno riuscendo anche a proporre e vendere, parallelamente, un proprio marchio: sono sempre più numerosi i brand e gli stilisti pugliesi che conquistano il mercato. Il cuore del sistema moda pugliese va dai capi spalla all’intimo, dalla maglieria agli abiti da cerimonia e per bambini, passando per calzetteria e calzature.
Insomma, una boccata d’ossigeno c’è. Finché pochi mesi fa (il 20 settembre 2018, proprio durante la Milano Fashion Week organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana) sulla Puglia è piombata una tegola firmata New York Times. Nell’articolo si leggeva la storia di una donna di mezza età che avrebbe trascorso la scorsa estate al lavoro sul tavolo della sua cucina, in un appartamento di Santeramo in Colle. Secondo il NYT era intenta a cucire un cappotto di lana della collezione autunno-inverno di un noto marchio italiano, destinato a costare in negozio tra 800 e 2.000 euro. Rimasta anonima per non rischiare di perdere l’impiego, avrebbe ricevuto dalla ditta pugliese che aveva avuto la commessa soltanto 1 euro per ogni metro di tessuto completato.
Un’altra signora di Ginosa forniva una versione simile. Entrambe avevano riferito di conoscere altre donne con impieghi analoghi. E il New York Times garantiva di averne individuate almeno un’altra sessantina, parlando di un numero compreso tra 2.000 e 4.000 irregolari. «Il lavoro a domicilio è un pilastro della filiera di fornitura fast fashion. Si tratta di una tipologia di lavoro particolarmente diffusa in Paesi come India, Bangladesh, Vietnam e Cina. (…) A coloro che considerano l’etichetta “Made in Italy” un sinonimo di raffinata artigianalità può, tuttavia, risultare scioccante apprendere che esistono analoghe condizioni in Italia».
Era questo il verdetto del NYT. Il servizio lanciato dal quotidiano statunitense ha provocato non poco scompiglio nel mondo della moda nostrana, internazionale (in ballo ci sono anche griffe non italiane) e in particolare in quello del tessile pugliese, preso a sberle proprio in un momento di ripresa. Tutti, da Parigi a Bari, da Milano a Lecce, hanno negato che quello descritto fosse un quadro fondato. Per lo meno, non lo è nel XXI secolo.
Il presidente della Camera nazionale della moda Carlo Capasa – pugliese doc, anzi salentino, col fratello Ennio ex proprietario del marchio Costume National, ceduto nel 2016 al fondo nippo-cinese Sequedge – si era imbufalito: «Quello del New York Times è un attacco strumentale che nasce senza aver fatto una vera indagine. Io sono pugliese e la Puglia non è il Bangladesh. Le nostre sono aziende serie, se i subcontratti hanno fatto delle stupidaggini questo va perseguito, ma condividiamo tutti lo stesso contratto per la tutela dei lavoratori. Se poi volevano demonizzare il lavoro domestico trovo che sia sbagliato, ha un senso purché sia ben pagato». Secondo Capasa, è stata una frecciata gratuita lanciata perché «siamo bravi e questo dà fastidio».
Salvatore Toma, Confindustria: «Siamo qualificatissimi e in regola»
Gli aveva fatto eco, con toni analoghi, Salvatore Toma, presidente di Confindustria Tessile e Moda sia a Taranto sia a livello regionale. Un tipo tosto, che ha imparato il mestiere da ragazzino a Sava, cittadina del Salento tarantino: «I miei nonni erano sarti e durante la guerra cucivano le divise dei soldati americani. Poi mio padre e i suoi fratelli posero le basi dell’azienda», racconta a Senza Filtro durante la Milano Fashion Week. Guida da 25 anni col fratello Sergio il Gruppo Sviluppo Tessile; i figli lavorano in azienda, così sono alla quarta generazione e hanno unito la produzione in conto terzi con quella di loro marchi: Havana & co, Angelo Toma, Julian Keen e, in licenza, Alessandro Dell’Acqua. Fanno lavorare 50 persone direttamente e 300 nell’indotto. «Noi ci teniamo al Made in Italy. Anzi, al “made in Puglia”!», afferma Toma.
Confessi: quanto vi ha seccato leggere quell’articolo sul New York Times?
Assai. Però nella mia regione da molti anni non ci sono più quelle condizioni di lavoro. Semmai le più importanti case di moda vengono da noi perché siamo qualificatissimi e in regola. Per giunta sono loro a vigilare sulla regolarità dei contratti e sul rispetto delle norme di sicurezza, perché temono i contraccolpi per l’immagine di eventuali problemi.
Però quel servizio un’ombra l’ha gettata. O no?
Mi spiego: noi abbiamo chiesto alla Guardia di Finanza di indagare sui contenuti di quell’articolo, perché eventuali irregolarità vanno sanzionate. Non è emerso niente. Per quel che ne sappiamo, quelle persone sfruttate non esistono.
Il settore gode di buona salute?
Dopo il cataclisma degli anni scorsi, in Puglia sta crescendo molto. L’export è in forte aumento. Anzi, siccome molto personale qualificato nel giro di pochi anni andrà in pensione, per garantire il ricambio stiamo coinvolgendo i giovani fin dalla terza media, poi nelle scuole professionali e nelle università, puntando alla formazione con il supporto delle nuove tecnologie digitali.
Ci contate?
Dobbiamo contare sulle tre I: innovazione, istruzione, internazionalizzazione. Con queste chiavi si va verso il futuro. Come Confindustria vorremmo indurre le tantissime aziende a fare sistema, proprio per consentire ai committenti, soprattutto stranieri, di avere un unico interlocutore, perché sono ancora poche le realtà che fanno ciclo completo. Non è facile ma questa è un’altra importante sfida. Parola d’ordine: organizzare e consorziare.
Una piccola quota di sommerso c’è ancora?
L’aumento delle competenze professionali dei lavoratori, su cui puntiamo, è destinato a togliere ogni eventuale piccolo residuo di lavoro nero o sommerso.
Luigi D’Isabella, Cgil: «Il sommerso? Minoritario. Ma serve un sistema»
Anche Luigi D’Isabella, coordinatore regionale della Filctem Cgil, che organizza, tra gli altri, anche i lavoratori del tessile, dice a Senza Filtro che il lavoro sommerso non ha certo le dimensioni descritte dal New York Times: «Se la Guardia di finanza ha indagato, senza trovare riscontri, non ho elementi per dubitare del suo operato. Il lavoro a domicilio esiste, ma non come in altre epoche e comunque è in genere contrattualizzato. Semmai pesa altro».
Che cosa?
Il fatto che alcune grandi aziende della moda offrono prezzi così bassi che di conseguenza, in certe realtà, alcune sigle sindacali accettano contratti inferiori a quelli nazionali.
Come rimediare?
Ora che il settore, dopo la crisi, si è ripreso, con una crescita nella qualità e nell’export, occorre fare un patto per il lavoro, puntando su eticità, formazione e creazione di un sistema, che non esiste. Questo servirebbe per ovviare al fatto che molte aziende medie e piccole possano trovarsi sotto ricatto o coinvolte in periodiche crisi.
Che cosa intende quando afferma che non c’è ancora un sistema?
Non esiste un sistema all’interno del quale le aziende possono collaborare tra di loro, mentre è indispensabile fare squadra. Inoltre manca ancora manodopera specializzata, quindi serve formazione. Infine bisogna riportare qui tutta la produzione. Alcune aziende mettono l’etichetta Made in Italy su prodotti fatti quasi interamente all’estero. Per riuscire a realizzare tutte queste cose occorre anche una politica industriale degna di questo nome.
Ora non è degna?
Diciamo che non si vede granché.
Insomma, Confindustria e Cgil sono d’accordo su un dato di fatto: il “sistema moda” in Puglia sembra pronto a spiccare di nuovo il volo, per giunta con ali più affidabili rispetto al passato. Però c’è ancora qualcuno che forse ha paura di volare.