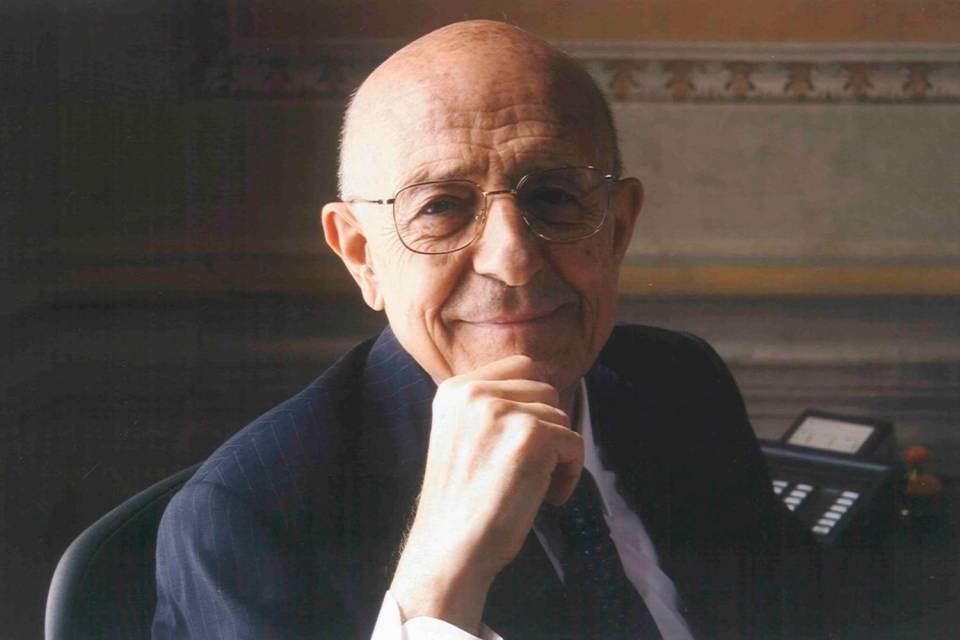
Il giurista Sabino Cassese, intervistato da SenzaFiltro, spiega il rapporto tra Pubblica Amministrazione, burocrazia e politica.
Il concetto di debito ha più di un volto, al di là delle sue implicazioni monetarie; politiche, sentimentali, umane. “Il debito di uno Stato va misurato sulle scelte politiche di lungo periodo, messe a carico di chi oggi è più giovane”: intervistiamo Massimo Ferro, magistrato in Corte di cassazione e organizzatore di Insolvenz Fest

Lo sforzo di rileggere certe parole è più che mai urgente. Volendo riconoscere un merito al fiorire di festival da Nord a Sud, la loro potenza rigenerante, quando c’è, sta nel togliere l’opacità a un parlare comune, ridargli un fondo.
“Come mai la struttura formale di un debito è sempre la stessa, per qualsiasi tipo di debito? Che si tratti di un debito economico, affettivo, degli Stati, il debito ha una sua concretezza già per come viene percepito collettivamente prima ancora che come individui. Non esiste un debito che possa dirsi corrispondente al disegno normativo se non si va a misurare, dal punto di vista storico, l’impatto che ha nella coscienza sociale e nell’opinione pubblica, e come viene vissuto in concreto.”
Massimo Ferro, magistrato in Corte di cassazione e quarant’anni di professione alle spalle, le ossa sui debiti se le è fatte anche grazie alle funzioni di giudice delegato ai fallimenti e delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Bologna. La cabina di regia dell’Insolvenz Fest – dal 18 al 21 settembre a Bologna, tema del 2025 Debiti e debiti – è lui, senza dubbio, al di là della modestia con cui ricorda che il progetto nasce da OCI, l’Osservatorio crisi di impresa, un’associazione no profit indipendente.
Al centro dei dialoghi pubblici della quattordicesima edizione c’è stavolta un impianto ontologico desideroso di chiedersi cosa sia il debito in sé. Sfidante come scelta, coraggiosa.
“Possono esserci debiti solennemente affermati, ma che vivono di scarsissimo rispetto, e accade in virtù di due fattori del tutto opposti: da un lato la resistenza a risponderne perché sentiti come ingiusti rispetto a un ordine sociale, dall’altro l’elusione del precetto per una impostazione egoistica, di pura convenienza, fino a scarnificarlo per ridurlo solo ad aspetti formali, senza farsene carico nella sostanza. Anche i debiti sanati fanno parte della società in cui viviamo; pur estinti dal punto di vista del diritto, si perpetuano nell’ambito della coscienza collettiva in virtù di una sopravvivenza non sempre meritevole. Intendo aspettative di prestazione, ‘crediti da parte di qualcuno’, fatte proprie e rivendicate di continuo.
“All’Insolvenz Fest, in passato, abbiamo persino provato a spiegare questo concetto prendendo a riferimento i reati di femminicidio riletti proprio in chiave di debito: donne alle quali viene continuamente chiesto di essere parte di una relazione anche se chiusa, anche se conclusa sul piano affettivo, di cura, sessuale, situazioni del tutto al di fuori del campo dei diritto, eppure vissute con la stessa logica. Tutto ciò non testimonia l’incapacità della nostra società di chiudere solennemente i rapporti, sia fuori che dentro un ambito giuridico? Bisognerebbe interrogarsi di più sul perché, laddove i debiti non vengano assolti e le responsabilità solo affermate, quegli stessi debiti non siano ancora entrati in un senso morale generale e non si siano incistati, con naturalezza, come ottemperanza di un precetto”.
Non basta la legge, stiamo dicendo questo?
Serve educazione sociale, basi diverse messe nella scuola e nelle famiglie, nei luoghi pubblici, per riconciliare le due anime, quella formale e quella sostanziale.
Perché le persone, inconsciamente, si sentono a credito? Di rado disposte a osservarsi, riconoscersi anche delle responsabilità.
L’osservazione è corretta, è un meccanismo di inerzia su noi stessi rispetto agli altri. Le persone usano meno sguardi di quelli che talvolta servirebbero per vedere la realtà, e difficilmente ciascuno di noi riesce a cogliere che è portatore di una duplice posizione all’interno di uno stesso rapporto, e non si tratta di ambiguità. Abbiamo diritti perché esercitiamo doveri: quando viene meno la reciprocità di base, la società e le relazioni che la intessono perdono forza.
C’è un fortissimo debito di voto in Italia, eppure gli italiani continuano a lamentarsi senza prender parte alla politica.
Ne parleremo, il programma dell’Insolvenz Fest 2025 gli dedicherà un’intera sessione. Nel 1945 l’Italia chiude un periodo in cui il voto era stato negato e rimette in circolo principi di democrazia. Un debito di voto che nasce prima della Repubblica, prima del referendum e prima della Costituzione. Attraverso una ricerca che abbiamo condotto con l’Ufficio archivistico del Comune di Bologna abbiamo scoperto che, in quegli anni di proto-Repubblica, la duplice lettura del voto come diritto e dovere era stata presa alla lettera, anche sul piano sociale: le persone che non andavano a votare erano tentate di andare a giustificare pubblicamente il perché. Interessante sarà paragonare quel sistema a ciò che vediamo oggi, nel pieno di una democrazia matura o post matura che convive con una evidente indifferenza al voto. Dopo ottant’anni dobbiamo chiederci se quel debito di voto è stato pagato una tantum, senza che la Repubblica abbia fatto altri sforzi per portare le persone a votare: il voto resta un diritto, non c’è dubbio, ma chiede di essere accompagnato anche come dovere. La nostra società non è più in grado di reggerlo? O è la politica che organizza elezioni e comizi restando del tutto indifferente al numero di persone che esercitano il voto, evitando di stimolare e farle crescere sul piano civico? Una democrazia che vive grazie a un voto inferiore al 50% dei voti – perché questo accade anche in Italia – è una democrazia che si regge, alla fine, su un consenso del 25% della popolazione avente diritto di voto.
Come vivono il concetto di debito le diverse generazioni? Il festival, negli anni, se ne è occupato.
All’inizio lo abbiamo trattato riferendoci anche alla riforma costituzionale con cui l’art.9 ha introdotto l’obbligo a tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche a tutela delle future generazioni. Ma c’è da andare oltre. Il debito di uno Stato non può più essere visto solo come una misurazione di carattere economico e della sua restituzione; va invece misurato sulle scelte politiche di lungo periodo che, per natura, non vengono pagate nell’oggi, ma messe a carico di chi oggi è più giovane. Intendo dire che quelle scelte, quelle prese di posizione, di fatto hanno escluso altre strade, e l’eventuale debito che va a caricare le future generazioni si inserisce lì dentro, al di là della parte economica. Ogni scelta che facciamo, pubblica o privata, è escludente rispetto ad altre. Già di per sé il debito è un concetto escludente, perché è una forma di impegno sul futuro – il concetto del farò, dirò, darò – ed è una promessa che accetta di sottoporsi a incertezze.
Anche le imprese imprimono un debito sui territori.
Sono tra i più gravi. Pensiamo al debito di suolo delle industrie, molto evidente in certe Regioni e province, che investono per qualche decennio su certe aree come una gittata antropologica di quindici o venti anni, drenando risorse di ogni genere e intaccando le comunità: se non creano i presupposti affinché se ne ricrei un’altra, lasciano il deserto quando l’attività finisce. Non è un debito enorme, difficilmente misurabile e non esigibile nel presente?
L’IA, in potenza, è una fonte di debito? Se sì, di che genere?
Il primo aspetto, rilevante sul mercato del lavoro, è il possibile debito sulle professioni, anche se un discorso simile va affrontato con sguardo vigile, senza cedere a facili semplificazioni. Da un lato di certo non abbatterà tutti i lavori, e dall’altro avrà anche un’efficacia liberatoria rispetto alla fatica, come è stato per ogni tecnologia. Il vero debito potrebbe iniziare a mettere le basi se lasciamo la IA libera, come di fatto sta accadendo, senza alcun processo di riflessione pubblica, col rischio evidente di creare crisi sociali e antropologiche. Il lavoro andrebbe sempre inteso come forma di partecipazione e costruzione della società; se guardiamo l’IA soltanto come apparente sottrazione di fatica allora siamo sulla strada sbagliata.
C’è un debito invisibile, non tangibile, che sfugge ai più?
D’istinto direi l’incertezza, che è l’essenza pura di un debito. Il debito in sé nasce come un atto di fiducia verso chi se ne fa carico; dall’altro lato c’è una componente sfidante per chi se lo assume, chiamiamola pure una sorta di fascinazione maledetta, perché le variabili esterne sono molteplici. Pensiamo solo ai rapporti affettivi e alle promesse d’amore: forse il massimo esempio di debito, credito e aspettativa di fiducia, soprattutto il massimo esempio di resa alla realtà e al futuro quando il sentimento finisce; i problemi nascono quando una delle due parti non accetta la dimensione naturale del debito e si chiude nella dimensione della pretesa, spesso infinita, pericolosa.
Massimo Ferro spazia sul concetto di debito con la sagacia di chi ha imparato a guardarlo dall’alto, unendo i puntini che solo da sopra si riescono a vedere, non se stai solo dentro le cose, non se gli passi solo accanto.
L’appuntamento con Insolvenz Fest e SenzaFiltro è a Bologna sabato 20 settembre, ore 17:40, con l’intervista di Stefania Zolotti, direttrice di SenzaFiltro, a Massimo Bressan, antropologo, dal titolo La monocoltura industriale e, dopo, il deserto.
Nell’occasione verrà presentato in anteprima l’Osservatorio sulle crisi di impresa 2025 curato da SenzaFiltro e FiordiRisorse: una pubblicazione dedicata al tema dei distretti italiani, non a caso intitolata Distretto vedute.
Link al programma del festival: https://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2601
L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.
Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.
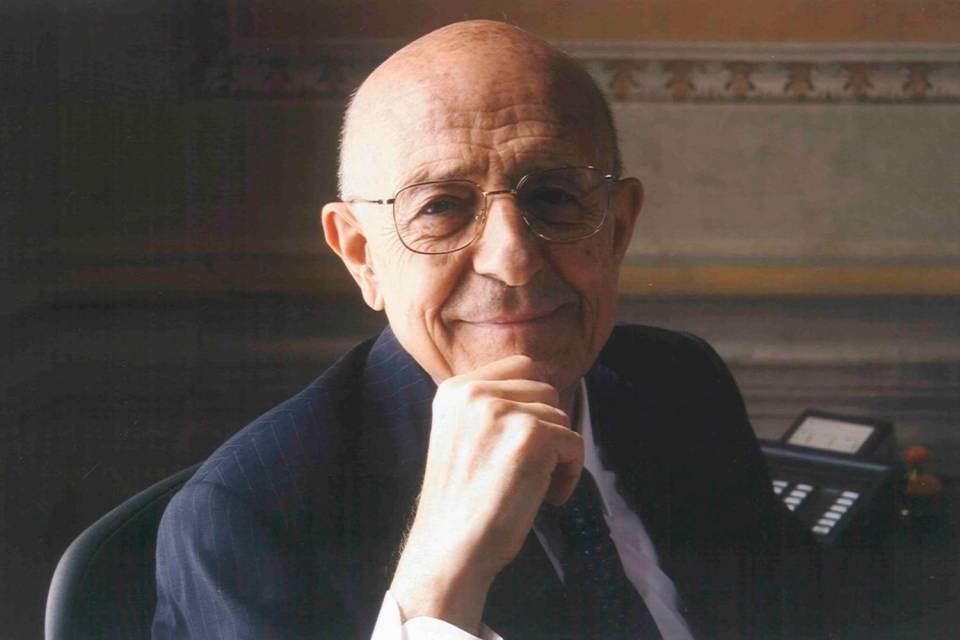
Il giurista Sabino Cassese, intervistato da SenzaFiltro, spiega il rapporto tra Pubblica Amministrazione, burocrazia e politica.

Il concetto di debito ha più di un volto, al di là delle sue implicazioni monetarie; politiche, sentimentali, umane. “Il debito di uno Stato va misurato sulle scelte politiche di lungo periodo, messe a carico di chi oggi è più giovane”: intervistiamo Massimo Ferro, magistrato in Corte di cassazione e organizzatore di Insolvenz Fest

Siamo invasi da norme giuridiche mal concepite che i cittadini tendono a non rispettare, soprattutto in emergenza. Eppure un modo per invertire la tendenza esiste.