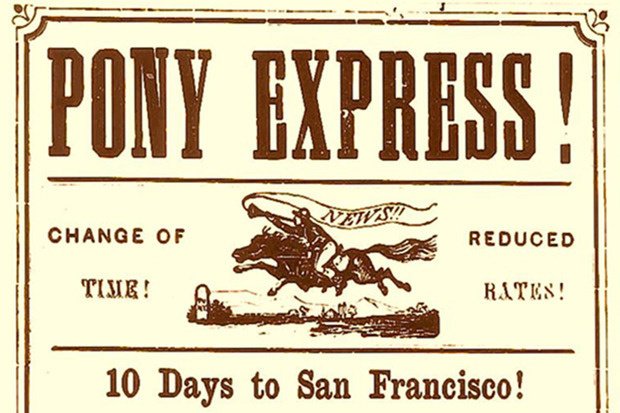Fatta seriamente, la pubblicità è uno dei mestieri più belli che si possano fare.
Definito in sintesi, è un mestiere che sulla base di ricerche sociali deve impostare strategie di marketing per le marche, i prodotti e i servizi, creando e producendo quella comunicazione distintiva adatta a farsi notare e a restare nella mente e nel cuore dei consumatori. Un mestiere che richiede una quantità di competenze interdisciplinari (marketing, sociologia, semiotica, letteratura, cinema, tv), oggi ancora più articolate dal bisogno di conoscere i social media e il mondo digitale nel suo complesso.
Carosello e gli esordi della pubblicità
Quando ho cominciato io a fine anni sessanta, non c’erano scuole o cicli di studi propedeutici al mestiere di pubblicitario: i creativi avevano studiato lettere, sociologia o filosofia, gli altri economia.
Qualunque fosse il corso di studi, si entrava come pulcini alla ricerca di una chioccia; se si poteva ci si sceglieva un maestro disponibile e si imparava il mestiere. In particolare per i creativi, le agenzie erano delle vere e proprie botteghe rinascimentali. Intorno a un direttore creativo di grande spessore c’era un gruppetto di allievi che collaboravano, sperimentavano e crescevano. Fino a metà degli anni Novanta c’era poi un corso molto ben fatto, finanziato dalla Regione Lombardia e gestito dall’associazione delle agenzie di pubblicità (che allora si chiamava AssAP). Dopo una severa selezione, sessanta candidati venivano affidati ad altrettanti tutor, e per un anno ogni mese passavano venti giorni in agenzia e tre in aula. Da quei corsi sono usciti tutti quelli che hanno poi fatto carriera e oggi sono ai vertici di agenzie italiane e multinazionali. Il corso fu però chiuso quando il mercato cominciò ad assorbirne meno della metà.
Lavorare in una multinazionale era particolarmente interessante, perché si entrava in contatto con clienti di grande cultura, e c’era magari occasione di andare ogni tanto a New York e a Londra. I creativi erano i più fortunati, perché erano spesso su spiagge esotiche in pieno inverno, a girare uno spot con diverse modelle.
Nel 1993, mentre ero alla guida di una multinazionale specializzata nella comunicazione per la salute mi fu richiesto di candidarmi alla presidenza dell’AssAP (oggi Assocom) in quanto non si trovava un accordo nella competizione tra due figure storiche della pubblicità, e pensarono a me come presidente di transizione. Non fu così: cercando di fare fronte alla prima grande frenata dei consumi puntai tutto sulla formazione, anche nel campo dei nuovi media che stavano nascendo, e così restai alla guida dell’associazione per ben cinque anni, partecipando anche – unico italiano che lo abbia mai fatto – al Board della Associazione Europea Agenzie di Pubblicità.
Occorre ammettere che fino agli anni Settanta la pubblicità ruotava tutta intorno a Carosello, spettacolino tv delle nove di sera, dopo il quale i bambini venivano messi a nanna. Nelle clip era rigorosamente proibito parlare di prodotti; solo alla fine si poteva inserire un codino con la promozione del detersivo o del dentifricio, il che obbligò gli autori, tra cui il mitico Marcello Marchesi, a inventarsi storie in qualche maniera coerenti con il prodotto da promuovere.
Oggi Carosello lo si studia anche per capire il sentiment di quel periodo, ma non si può negare che abbia avuto la sua bella responsabilità, a causa di quel peculiare format, nel ritardo della pubblicità italiana rispetto a quella internazionale. Con l’avvento degli anni Ottanta e la nascita dell’emittenza privata la pubblicità si sviluppò notevolmente, e a metà della decade successiva si sviluppò una scuola di pensiero che come presidente AssAP tentai di combattere in ogni modo, ma senza successo.
La pubblicità e i Centri Media
Fino ad allora l’associazione intendeva raccogliere e promuovere le “agenzie di pubblicità a servizio completo”, espressione che rimandava a un lavoro articolato fatto per i clienti a base di ricerche sociali, strategie di brand, strategie creative, produzione, strategie media, assistenza al cliente, presidio di attività above the line (tv, stampa, radio, affissioni) e below the line (promozioni, direct marketing, pr, design, eccetera). A un certo momento ci fu qualcuno che capì che il vero centro di profitto per le agenzie era l’acquisto degli spazi pubblicitari, perché a fine anno l’agenzia poteva lucrare su extra-sconti su una grande massa di acquisti. Extra-sconti che non venivano rigirati ai clienti.
Così nacquero i primi Centri Media, dediti all’acquisto e allo studio delle strategie media come società indipendenti, sia pure legate a questo o a quel gruppo. Va ricordato che negli anni Settanta l’agenzia veniva remunerata con il famoso 15% sull’investimento media, che nel tempo diventava una revenue molto ricca, dato che se andava bene il budget veniva raddoppiato, triplicato, decuplicato, con grande pacchia anche per il Centro media che vedeva aumentare in maniera esponenziale i propri profitti.
A un certo punto i clienti, soprattutto quelli internazionali, mangiarono la foglia e cominciarono a pretendere riduzioni della commissione d’agenzia, che via via si è ridotta fino al 2% e anche meno. Così è successo che, ritenendo l’acquisto mezzi il bocchettone di ingresso delle revenues, si sono poi create nel mondo enormi concentrazioni di società (immaginiamo il potere d’acquisto e gli extrasconti di questi colossi), al punto che oggi esistono solo tre grandi Gruppi di pubblicità nel mondo.
Naturalmente sto sintetizzando molto, ma in questo processo le agenzie di pubblicità, in molti casi ricorrendo a del vero e proprio dumping, hanno cominciato a sostenere con i clienti che, a fronte della remunerazione per la pianificazione e acquisto mezzi, tutto il resto del servizio costava poco o niente. Così facendo è avvenuto che la creatività è stata svalutata, anche perché ciò che è gratis – o quasi – alla fine vale poco. Dato che la crisi ha ridotto ulteriormente gli investimenti media, le agenzie di pubblicità si sono ritrovate con sempre meno risorse, ridimensionandosi, licenziando o assumendo stagisti con poca esperienza, senza che ci fossero però i vecchi maestri a insegnare il mestiere: ormai erano andati a godersi una ricca pensione maturata nei tempi in cui l’agenzia era una gallina dalle uova d’oro.
L’addio dei maestri
Così ora i clienti si lamentano nel vedersi seguire da giovanotti poco preparati, e di conseguenza puntano a ridurre ulteriormente i compensi: un meccanismo davvero perverso. Ma c’è poi stata una complicazione in più con la nascita della pubblicità digitale, che ha cominciato a richiedere una quantità di micro-competenze articolate e complesse, sulle quali si sono buttati molti giovani, dimenticando però che a monte ci deve sempre essere una strategia ben impostata che si impara a costruire nel tempo e con l’esperienza; quella che oggi nessuno ti insegna più.
La riprova sta nel fatto che alcuni grandi maestri della creatività, quelli che ancora avevano intorno a sé la bottega rinascimentale, si sono licenziati in blocco poco tempo fa. Interpellati, hanno risposto: “Un vero direttore creativo non si accontenta delle prime soluzioni, e spinge la sua squadra a cercare e sperimentare, il che richiede tempo. Ma se questo lavoro viene preso come una perdita di tempo da vertici che vogliono consegnare il pezzo quanto prima per passare all’incasso tramite il centro media, è ovvio che dopo un po’ ti senti considerato di troppo. E ti conviene cercare altre luoghi dove poter lavorare come si deve”.
Un’ulteriore complicazione è stata creata da Bank of America Merryl Linch, che in uno studio diffuso globalmente ha sostenuto che è finita l’era dello storytelling e della creatività perché è iniziata l’era del marketing data-driven; ma qualche settimana dopo è scoppiato il caso di Cambridge Analytica, mettendo in crisi il sol dell’avvenire pubblicitario basato sui big data. Perché, come ha detto un creativo di grande cultura come Andrea Concato: “Quando hai ben scovato Gino grazie ai dati, cosa di per sé utilissima, dovrai pur dirgli qualcosa”.
Se ne deduce che la soluzione è rimettersi a insegnare come si deve, a studiare e sperimentare a fianco dei maestri, altrimenti uno dei mestieri più belli scomparirà. E non potrà farlo un robot al nostro posto.
Photo credits: Teche Rai