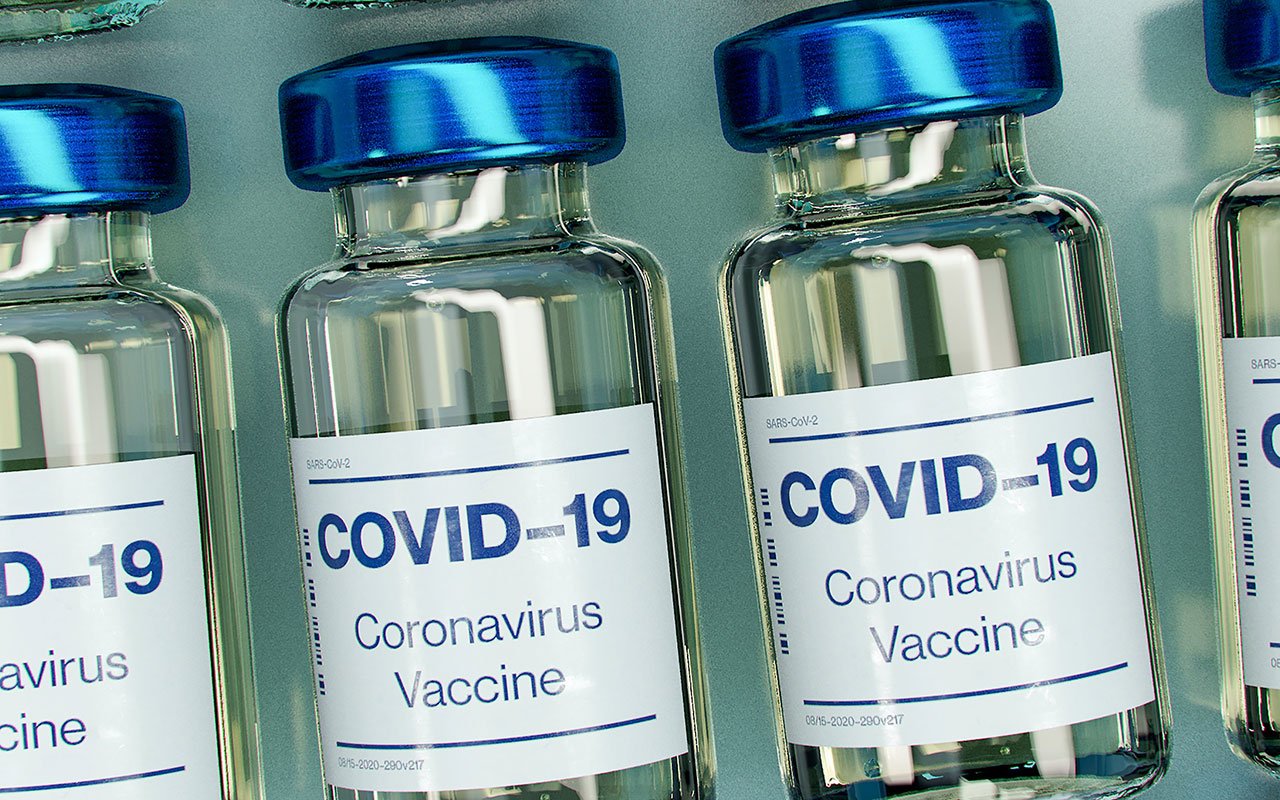Concedetemi un paragone ardito, iperbolico ma senza alcuna inclinazione irriguardosa. Vorrei sollevare l’attenzione su una nuova forma di “banalità del male”. Questa locuzione appartiene alla filosofa tedesca di religione ebraica Hannah Arendt, che più di cinquant’anni fa pubblicava il libro La banalità del male, dedicato alle analisi e alle deduzioni svolte come inviata del New Yorker, per seguire il processo al criminale nazista Adolf Eichmann.
In una estrema sintesi del suo imponente lavoro, possiamo dedurre che il “male” ha la capacità di conquistare le persone normali, anche prive di indole malvagia, grazie alla naturale propensione degli individui ad un atteggiamento semplicistico e superficiale, che possiamo distillare nella mentalità del “così fan tutti”. Un atteggiamento comodo, acritico, subdolo, silenzioso, autorassicurante, capace di costruire progressivamente una zona di comfort prima morale e poi addirittura fattiva.
Sottolineando l’ardito e sicuramente irriguardoso paragone, vorrei articolare la mia riflessione utilizzando le medesime dinamiche per discutere una nuova forma di questo “male”, ovvero la “banalizzazione del digitale“. Un rischio che in Italia, a mio modo di vedere, è molto più presente di quello che le aziende, i consulenti, le istituzioni e gli addetti ai lavori possono pensare e ammettere.
Nel mio intervento al Social Business Forum del luglio 2016 ho coniato una definizione di questo rischio ovvero il #DigitalKotiomkin. Recentemente, in occasione dell’evento annuale del DEVOLAB della SDA Bocconi, mi ha fatto molto piacere sentire il Prof. Gianluigi Castelli, direttore dell’iniziativa, dire che: «Anche nel Digitale è presente un grosso rischio, che ci porta a dire meglio una sciocchezza che una banalità». Penso che il #DigitalKotiomkin abbia tre cause d’origine: standardizzare gli obiettivi della digitalizzazione adottando modelli del passato, sottovalutare gli impatti del digitale sui modelli socio-comportamentali e ripetere come un mantra parole e strumenti del digitale senza analizzarne il contenuto e la corretta applicazione.
Su questi tre temi condivido con voi alcune evidenze partendo dall’obiettivo Industria 4.0 che, recentemente, ha sostituito lo slogan Digital Transformation nella community di business.
Siamo tutti concordi nel riconoscere che la nuova rivoluzione industriale porterà a una “produzione del tutto automatizzata e interconnessa”, ma se vogliamo provare a calare questa visione sulla realtà imprenditoriale italiana dobbiamo sforzarci di analizzare come questa possa impattare veramente su un Paese che presenta il 99% delle imprese con meno di 49 addetti (dati ISTAT 2011), percentuale che resta al 98% se depurata delle aziende uni-nominali. Non sarebbe più corretto se in Italia iniziassimo a riconoscere Artigianato 4.0 e Industria 4.0, se volessimo mantenere gli stessi obiettivi? Ricordiamo che il termine Industria 4.0 è stato coniato da un gruppo di lavoro tedesco, espressione di una famosa multinazionale con 303.00 dipendenti (dato del 2011)?
Occorre affrontare il tema, dunque, partendo dalle specificità dell’Italia.
Da sempre accusate di “nanismo” e di incapacità di industrializzazione della creatività, finalmente le nostre aziende hanno nel digitale uno strumento che trasforma questi limiti in punti di forza. Il digitale per sua natura travalica le economie di scala, impone nuove regole (dematerializzazione, democratizzazione e demonetizzazione), permette di rendere la soluzione specifica un modello generale (teoria della “coda lunga”) e di esaltare il problem solving, il pensiero critico e la creatività quali competenze più ricercate.
Per l’Italia sarà una magnifica opportunità, se saremo in grado finalmente di riconoscere le nostre specificità. Partendo dal Piano del Governo per l’Industria 4.0 che prevede sostegno a investimenti privati, spesa privata in R&D e innovazione, investimenti in early stage, incentivi fiscali per i venture capital, diffusione della banda ultra larga, formazione dalle scuole all’università, riconoscendo che in questo momento ciò in cui paradossalmente difettiamo sono le idee, la visione di voler sviluppare una via italiana all’Artigianato 4.0 e all’Industria 4.0. Obiettivo che possiamo perseguire se dedichiamo la corretta attenzione agli impatti che il digitale e i suoi strumenti hanno sui comportamenti e sulle dinamiche sociali dentro e fuori l’azienda in un contesto che, come visto, ha delle specificità uniche.
Non posso nascondere la delusione che ho provato scorrendo l’elenco delle posizioni aperte dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale per la costruzione del Team per la Trasformazione Digitale: esperti di informatica (Software Architecture, Mobile Application Development, Software Open Source, Information Security, API), di matematica e statistica (Modelli Predittivi, Machine Learning), e di Product Design, User Experience. Mi sarebbe piaciuto anche trovare, in linea con le ultime linee guida della Silicon Valley e con le fondamenta della nostra cultura, posizioni dedicate a sociologi, storici, antropologi, filosofi e anche psicologi, perché alla fine ciò che dobbiamo “trasformare” sono esseri umani con la loro propensione all’adozione delle tecnologie e al cambiamento delle abitudini socio comportamentali. Impatti che non si limitano solo all’introduzione di un processo, di un’interfaccia mobile o di un canale di e-commerce.
Mi piace ricordare cosa è successo nelle scorse settimane all’ufficio postale di Cassino dove i pensionati hanno aggredito un Millennial che aveva usato l’App per prenotare il posto in fila e mi piace citare un aneddoto che mi ha “confessato” un mio cliente con il sorriso sulle labbra: «Ho due figli adolescenti, un maschio ed una femmina. Ho sempre pensato che i miei nemici in questa fase della loro vita potessero essere le canne, il primo fidanzatino e le cattive compagnie. Invece mi sono accorto che le cuffie wireless e gli youtuber sono i miei veri nemici!».
Infine, se parliamo di nemici, io sto conducendo una battaglia contro gli slogan del digitale. Prendo ad esempio l’Open Innovation. Il 2016 è stato l’anno dell’Open Innovation. Non vorrei passare per pignolo ricordando che Chesbrough pubblico nel 2006 Open Innovation: Researching a New Paradigm (Oxford University Press) ma ciò che mi rende perplesso è che questo utile modello di Innovation Management in Italia si è magicamente trasformato nell’attività di coinvolgimento delle startup in fase generativa, per consentire alle aziende di portare a casa idee a basso costo, anche intellettuali, e occasione per organizzare nutrite cartelle stampa. Non conto più le iniziative pubblicizzate come Open Innovation, che in realtà sono delle CallforIdeas dedicate alle startup e che hanno come effetto quello di relegare a mere partecipazioni di capitale il rapporto tra aziende, startup e venture capital (non apro il capitolo dedicato al Corporate Venture Capital).
Non voglio applicarmi in un peana dell’Open Innovation ma vorrei ricordare che esistono altre fasi (ad esempio analisi del contesto, validazione, esecuzione, prototipazione e test) del processo di innovazione nelle quali poter ingaggiare non solo start up ma le differenti community dell’ecosistema (clienti, fornitori, altre aziende, competitor, cerchi di ricerca, innovation gatekeeper e altri soggetti) e con differenti strumenti che non siano le call for ideas.
La banalizzazione del digitale, #DigitalKotiomkin, è un pericolo che dobbiamo evitare per riuscire a concretizzare gli enormi vantaggi che le tecnologie digitali, perché non tutte le tecnologie sono digitali e ci prospettano nei differenti ambiti d’adozione. Rifuggiamo il pensiero generalista, le etichette e gli slogan, facciamo lo sforzo intellettuale e di critica che le nuove regole che accompagnano questa rivoluzione ci impongono. Iniziando a distinguere e separare quello che è Digital Transformation, la sostituzione dei vecchi paradigmi, dalla Digital Evolution, la costruzione di nuovi paradigmi, in un nuovo rapporto tra sostenibilità e innovazione, non solo economica ma in tutte le aree del nostro vivere sociale.
(Credits photo: www.camh.ca)