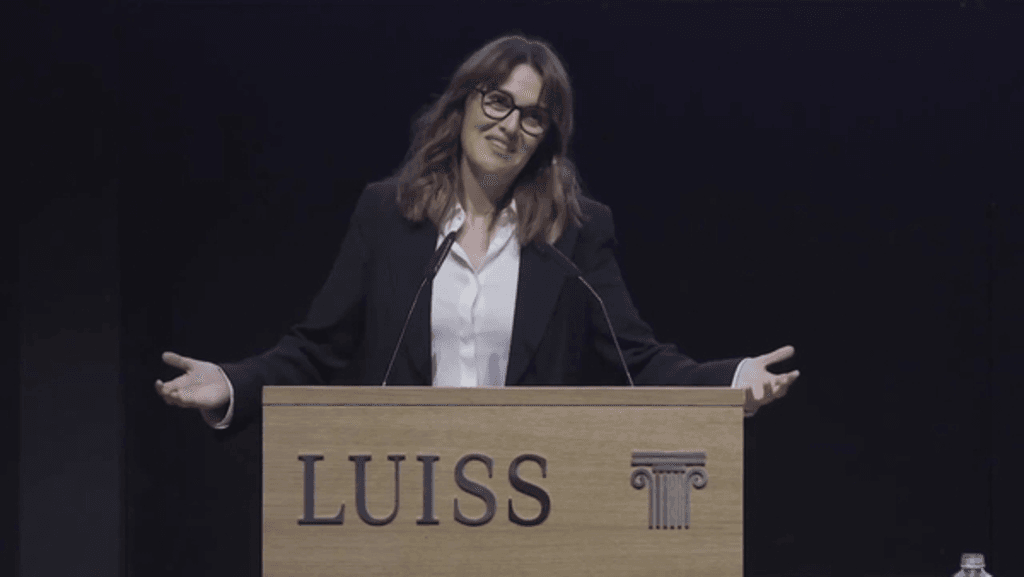
Il discorso di Paola Cortellesi alla LUISS ha suscitato parecchie critiche per la parte – minoritaria – dedicata alle fiabe. Ma il problema sta altrove, e ha le radici nella stessa decisione di parlare in una simile cornice
Durante la pandemia la cultura e i suoi rappresentanti sono ammutoliti, lasciando spazio a medici, scienziati e voci confuse. Ma, soprattutto, lasciandoci privi di modelli a cui ispirarci, mentre l’occasione che abbiamo perso diventa sempre più chiara.

Pandemia: tutta emergenza, niente cultura; senza punto interrogativo finale.
Il punto di domanda però c’era sul programma 2021 di Nobìlita, volutamente c’era, ed è partendo da lui che ho cercato risposte sul palco del festival dopo essermi chiesta per un anno e mezzo chi avesse rubato il pensiero in Italia o dove si fosse nascosto. O chi lo avesse fatto deragliare.
Mentre scrivo è già via libera ufficiale sulla capienza al 100% per cinema e teatri italiani, le discoteche al 50% se al chiuso e al 75% se all’aperto, gli stadi al 75% con l’auspicio di portarli a piena occupazione dei posti per il derby della Madunina. Dai microfoni di Radio Sportiva, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha proprio detto così, un paio di giorni fa: “San Siro esaurito per il derby di Milano del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile”.
Spererei che una figura istituzionale come la sua rassicurasse su altre priorità.
Lo scorso anno, passando per Perugia in piena zona rossa, mi fermai a mangiare un panino davanti a un centro commerciale. Ero a Collestrada, per l’esattezza. Dalla lavagna mi colpì il panino con le polpette al sugo di un bistrò su strada, entrai, ordinai, scambiai quattro chiacchiere col signore sulla sessantina che da dietro il banco mi tagliava il pane con cura, poi le polpette messe una dopo l’altra come si infilano perle su un girocollo. Rimasi lì dentro non più di cinque minuti, quanto bastò per farmi dire che il locale aperto da poco era intestato al figlio e che lui gli dava una mano perché al momento era senza lavoro. Quel padre che riempiva panini era nella gestione del Teatro Lirico di Perugia.
Domenico De Masi, sociologo del lavoro mai stanco di mettere in campo analisi che guardano oltre il presente, intervenuto alle prime due tappe di Nobìlita a Ivrea e Imola, non si è tirato indietro nel rimarcare quanto già dichiarò a febbraio 2020: “Oltre che un esperimento sociale, questa pandemia è stata un seminario. Dopo la Seconda guerra mondiale, questo è il primo grande cataclisma che investe tutto il pianeta. Un seminario in cui l’insegnante severo è stato il virus, che ha cercato di farci capire una serie di cose. Poi c’è chi lo ha capito e chi no, chi lo capirà col tempo e chi no, ma questo dipende dagli allievi. Intanto ha cercato di insegnarci un diverso rapporto tra spazio e tempo: prima della pandemia avevamo moltissimo spazio che coprivamo con viaggi, treni, aerei da una parte all’altra; e avevamo poco tempo per noi, anche perché ci muovevamo troppo. Di colpo ci siamo trovati ad abitare uno spazio ridottissimo e un tempo dilatato”.
“Poi il virus ci ha insegnato che il mondo è globalizzato e che i sovranismi sono davvero arcaici e velleitari; che dentro le crisi si accentuano le disuguaglianze, e li abbiamo visti tutti, e li continuiamo a vedere, quelli che sono stati colpiti dall’emergenza, cioè gli anziani, i singoli, i precari, i clandestini, i bambini, gli homeless; che sono importanti le competenze, ma che le scienze esatte non sono sempre esattissime; che è fondamentale il potere decisionale e che le comunicazioni sono delicatissime, e che devono essere né carenti né ridondanti. Ma soprattutto viviamo in questi mesi un nuovo tempo che definirei post-industriale e, per la prima volta nella storia, non abbiamo un modello di riferimento a cui ispirarci”.

Modelli di riferimento assenti, tanto quanto gli intellettuali dal 2020 in poi. Intellettuali suona male, sono d’accordo, ma ci siamo capiti. Credo di non essere l’unica a essersi sentita orfana nell’ultimo anno e mezzo: se è vero che ognuno di noi dovrebbe lavorare ogni giorno mosso da etica e senso di responsabilità, un tradimento da chi col pensiero si misura ogni giorno c’è senza dubbio stato. Pochi, rarissimi, sporadici i loro interventi pubblici; è toccato andarseli a cercare col lume della ragione. Stesso silenzio da loro profili social o siti personali: ma questo non era il tempo della democrazia diffusa grazie al web? Poveri noi.
Non si sono fatti volutamente sentire perché disorientati e umani come tutti noi: è la prima ipotesi, ne dubito ma lo considero. Propendo di più verso la chiusura nei loro confronti, e rinnego l’insopportabile ospedalizzazione mediatica imposta a ognuno di noi da febbraio dello scorso anno e della quale siamo ancora in ostaggio: non essere stati in grado di farci vivere correttamente il recinto della pandemia rispetto alla libertà del nostro pensiero è l’accusa più forte che rivolgo ai colleghi giornalisti, ai palinsesti che stimavo e che non seguo più, ai messaggi e ai dati forniti ogni giorno come un mantra al contrario con cui siamo stati trattati giorno dopo giorno, e non è ancora finita. L’emergenza è un’altra cosa, ha tempi e modalità differenti, è come una qualsiasi psicoterapia che aiuta a superare il blocco ma che non può durare per sempre; diversamente si chiama dipendenza ed è il rischio che stiamo correndo tutti.
Ma la responsabilità è al 50% e né noi, né le istituzioni, né i mezzi di informazione stavolta hanno il coltello dalla parte del manico: invece che convergere verso dibattiti e confronti funzionali ad allentare le paure individuali e collettive – o per lo meno provarci – ci siamo ridotti a fazioni e frazioni senza averci ragionato un po’ su, e non riusciamo più a tornare indietro perché i livelli di complessità in cui siamo immersi ci tolgono il fiato.
Alla metafora lineare di De Masi – il virus come insegnante, noi umani come allievi più o meno diligenti – risponde senza volerlo, tra le righe del suo Il virus che rende folli, Bernard-Henri Lévy, filosofo, giornalista e saggista francese, convinto che i virus non abbiano nulla da insegnare, né arrivino tra noi con la pretesa di farlo.
Preparando il materiale per questo articolo, mi è venuto incontro un video della Fondazione Luigi Einaudi in cui un amabile Michele Gerace legge e commenta alcuni passaggi del libro. Un paio di questi li ho riascoltati almeno due volte, avanti e indietro, avanti e indietro, perché finalmente la voce di un pensatore aveva gridato forte e veniva dalla Francia, non da casa nostra. Li riporto perché ci fanno bene.
“Non bisognava farsi intimidire, in fondo, dal falso dibattito sulla vita e sull’economia, ma soppesare il costo in vite umane dell’ondata virale da un lato, e dall’altro il costo della glaciazione indotta da quel coma autoinflitto sulla quasi totalità del pianeta, trasformatosi in laboratorio di un’esperienza politica radicale. E l’unico modo per farlo era quello di aprire un grande dibattito democratico ed entrare nel dettaglio non delle nostre simpatiche utopie per il mondo a venire, ma delle misure da attuare qui e ora e nel mondo di adesso. Gli Stati non l’hanno fatto: hanno deciso di prescrivere questa sincope ai loro Paesi e dichiarare una emergenza sanitaria globale? Proprio così. Ma questo non era un motivo per assecondare pedissequamente il processo. È stata la prima volta che abbiamo visto tutte le menti critiche della galassia di ultrasinistra applaudire a uno stato di emergenza, e un intellettuale, anche radicale, mi sembrava sarebbe rientrato più nel suo ruolo dicendo: ‘Voi governanti avete, nella paura e nella fretta, messo l’economia in sordina, e forse non c’era scelta in quel momento, ma questa decisione presenta, per le vite che si vogliono salvare, dei pericoli difficili da misurare, e vorremmo che i media risparmiassero anche solo una frazione del tempo speso in discussioni incerte tra vecchi bambini in camici inamidati che giocano a cose sconosciute, e questo tempo risparmiato vorremmo vederlo dedicato a dibattiti di economisti, demografi, geopolitici, o semplicemente di cittadini che esplorano questi pericoli, esaminando concretamente e precisamente nel dettaglio la complessità delle misure da adottare per coniugare l’emergenza sanitaria con la protezione sociale delle persone.’”
“I registi del grande spettacolo della guerra al virus, i nuovi Dottor Purgone che promettono non solo di contenerlo ma di sradicarlo dalla società, dovrebbero togliersi di torno. L’umanità è sempre vissuta e sempre vivrà con i suoi virus. A tutti loro, a chi vive della rendita dei drammi e della morte; a quei bio-ladri ventriloqui che hanno fatto parlare il COVID come fosse la Rai o Topo Gigio di un tempo; ai taumaturghi che celebrano il loro virus come Dante la sua Beatrice e il cui catechismo da bar a malapena nascondeva la poca importanza che davano agli uomini veri e al loro dolore; ai loquaci invadenti il cui bigottismo positivista ha finito certi giorni per coprire le parole del personale sanitario; a tutti loro bruciavo dal desiderio di dire ‘state zitti per favore, zitti’. L’epidemia prima o poi sarà messa sotto controllo. Spero che quel giorno avremo dimenticato lo stridio della loro voce.”
Dico grazie a Bernard-Henri Lévy.
Ma dico grazie anche a Piero Dorfles, che col suo monologo ispirazionale a Nobìlita 2021 non ha fatto sconti, come Levy del resto, denunciando l’occasione persa in Italia: “Malgrado ci sia stato in questo anno un minimo aumento dei lettori e delle quote di libri venduti in Italia, tutto sommato noi non abbiamo approfittato del lungo periodo in cui siamo stati a casa per fare qualcosa di utile allo sviluppo intellettuale di questo Paese, che è molto arretrato. Noi non soltanto leggiamo pochissimo, ma abbiamo anche scarse competenze di scrittura; abbiamo scuole che insegnano poco e in emergenza hanno insegnato anche meno; usiamo le parole ormai solo per messaggi brevi e sintetici e non riusciamo ad argomentare risposte. Io credo che lavorare affinché la collettività si impadronisse di qualche strumento culturale in più, anche minuscolo, andasse fatto. E nessuno, invece, lo ha voluto”.

Qui nessuno attacca la scienza o la medicina, che spesso hanno salvato la storia. Qui si tratta di dirsi una volta per tutte che non possiamo più delegare il pensiero fuori di noi solo perché ci deresponsabilizza o perché ci richiede un grande sforzo. La medicina fa il suo, la scienza fa il suo, il pensiero fa il suo: il danno è quando ognuno va per la sua strada e quando si vive con la verità in pugno.
Campione della disillusione, cronista del grottesco italiano, allergico alla banalizzazione del pensiero come denominatore comune, Ennio Flaiano – fosse ancora vivo in tempo di emergenza – avrebbe messo nero su bianco un graffio dei suoi. Sarebbe rimasto di lato a guardare la banalità del giornalismo e della politica, la confusione della scienza in bocca a troppa gente con o senza camice, la comunicazione contraddittoria e bulimica.
“Fra trent’anni l’Italia sarà non come l’avranno fatta i governi, ma come l’avrà fatta la televisione”.
Flaiano è morto nel 1972.
Al posto della televisione mettere pure ciò che preferite.
L’articolo prende spunto dal panel “Pandemia: tutta emergenza, niente cultura?”, che puoi seguire cliccando qui.
Photo by imgix.net
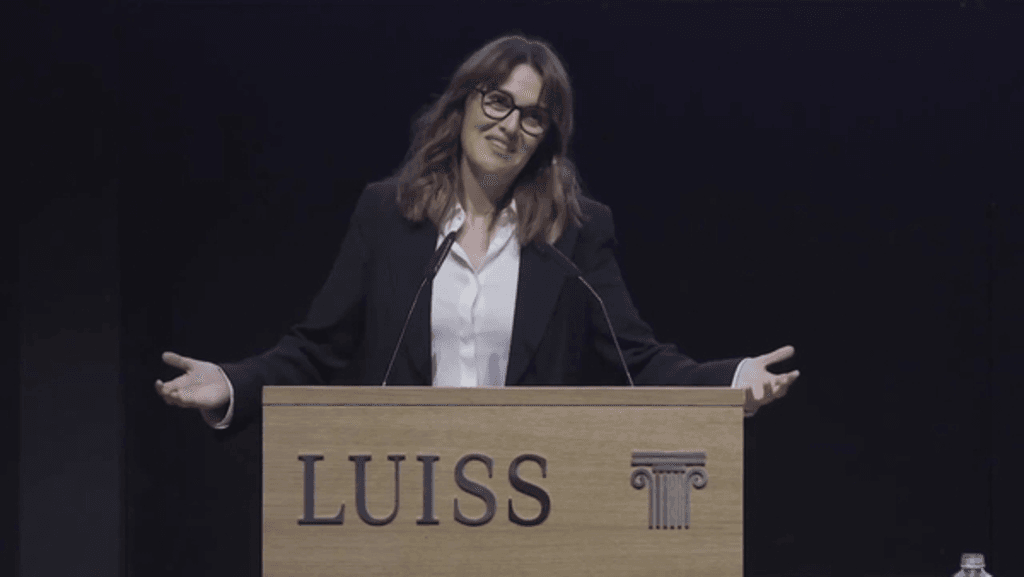
Il discorso di Paola Cortellesi alla LUISS ha suscitato parecchie critiche per la parte – minoritaria – dedicata alle fiabe. Ma il problema sta altrove, e ha le radici nella stessa decisione di parlare in una simile cornice

A guardare i canali YouTube di brand come Vodafone, Enel o Fiat ci sarebbe da credere che esistono luoghi del marketing che privilegiano alcuni e penalizzano altri. In realtà quello che ha fatto YouTube, e semplicemente la maggior parte degli utenti business non ha ancora recepito, è stato mettere nelle mani di tutti l’arte della […]

Paolo Malvaldi lavora da dieci anni nel reparto Marketing e Comunicazione di Sammontana, con sede a Empoli: un’azienda storica non solo a livello regionale ma nazionale, capace di concorrere con le grandi multinazionali del settore e di rappresentare il Made in Italy nel mondo. Ad oggi ricopre il ruolo di marketing manager; gestisce tutto il […]