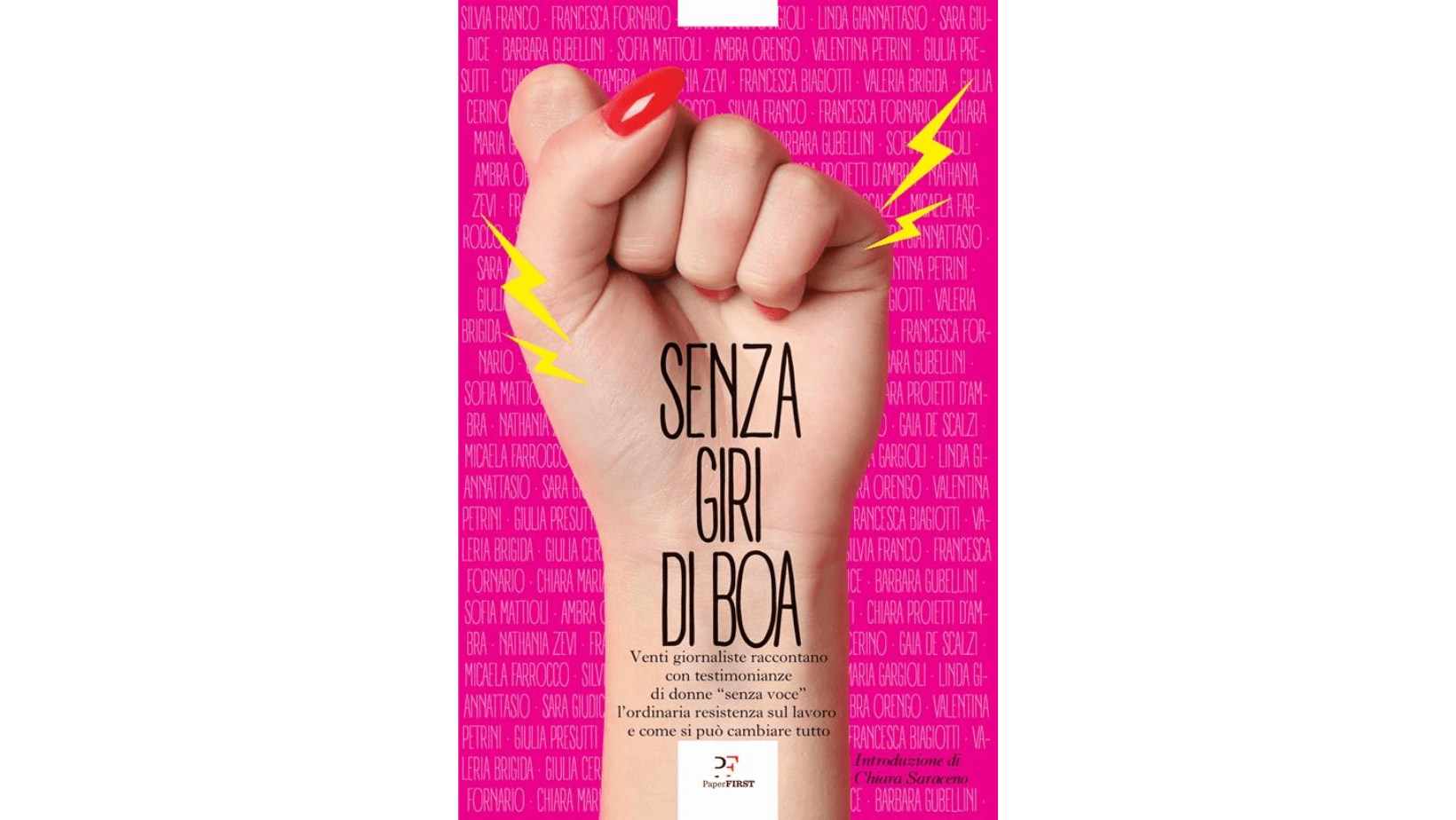“Noi tutti siamo di passaggio. Noi tutti stiamo transitando”. Sarebbe bello vi fosse una proporzione tra queste due esperienze.
Da un lato l’esperienza del prendere parte al divenire, alle sue incessanti metamorfosi. Di essere creature a tempo, che questo tempo lo possono attraversare con la dignità di esseri umani o con la presunzione di chi non accetta la propria contingenza. Esperienza che appartiene a tutti perché è di ciascuno: irriducibilmente singolare. Ogni creatura sperimenta il proprio passaggio, il proprio varco. Si chiama vita, la possiamo raccontare dentro una storia, ogni storia è diversa da tutte le altre, nonostante il nostro sforzo per ridurre i nostri passaggi a semplici ripetizioni.
D’altro lato l’esperienza collettiva di ciò che definiamo “un’epoca di transizione”. Si può vivere il proprio essere (di) passaggio dentro uno sfondo sociale ben assestato, consolidato. È l’esperienza dei nostri nonni, forse. A noi tocca dell’altro. La contingenza singolare s’incontra col disincanto sociale del sentirsi in un mondo le cui trasformazioni sono così complesse, incessanti e incompiute da lasciarci smarriti e da fare dello smarrimento una passione collettiva, non più semplicemente uno stato d’animo individuale.
La provvisorietà non si ferma più
Dunque possiamo correggere l’incipit di questa storia. Ora lo trascriverei così: “Io sono di passaggio, come tutti. Ma adesso noi tutti stiamo transitando”.
Di questa transizione, apparentemente così neutrale e disincarnata, ne sentiamo il peso da mesi, se non da anni. Forse è per questo che la definiamo come un’epoca, rischiando una contraddizione illuminante (che vedremo alla fine). La provvisorietà delle cose e delle leggi che le regolano è diventata qualcosa che sentiamo, non solo che conosciamo. Che non ci abbandona, non si interrompe. Una sensazione che ci accompagna nel risveglio di ogni mattina: questo è il mondo che ci attende fuori da noi. Un mondo non ben assestato, in transizione.
Come quando ci alziamo di scatto e la testa gira vorticosamente: dov’è il mondo? Dove sta andando? Dove posso puntare i piedi per sentirmi saldo? Ogni transizione ha un ritmo, può accelerare e può rallentare, quando accade. Questa transizione che ci riguarda ha un ritmo indecifrabile. Noi riconosciamo un’accelerazione, ma non sappiamo se grazie ad essa stiamo approssimandoci al termine del viaggio o se ce ne stiamo allontanando. Se siamo di corsa sul sentiero giusto o se di corsa ce ne stiamo allontanando. Non sappiamo neppure dove stiamo andando, in verità. Uno dei caratteri di quest’esperienza che condividiamo è dunque una forma di opacità. E ci insegna subito qualcosa di politicamente rilevante: che transitare è certamente un modo di stare insieme in un mondo, ma vi è una luminosità che permette di riconoscerci nelle transizioni oppure un’opacità che ce le fa subire. Che segnala come questa nostra transizione non incrementi la nostra potenza, ci renda frustrati, impotenti. L’opacità induce a definire il nostro stato di transizione come una forma sociale di disorientamento.
Se la transizione è più una paura collettiva
Anche il tempo che serve per realizzare un desiderio comporta una specie di transito. Ma il nostro transitare somiglia molto più a una paura collettiva: un tempo sospeso in cui cerchiamo di non sprofondare nei cunicoli che temiamo, di scongiurare il peggio molto più che cercare il meglio. Recitiamo dentro la trama paranoica di un film di Cronenberg, non dentro la finzione piena di grazia di un film di Anderson. Ecco, una transizione senza alcuna speranza di grazia mi pare un’ottima definizione del tempo che viviamo.
L’altro giorno sentivo un argomento politico – concerneva qualcosa di presentissimo nel dibattito pubblico e dunque di poco importante, probabilmente – che suonava così: “non si cambia il nocchiero di una nave durante la tempesta”. Mi è venuto da sorridere. I nostri nocchieri non mi appaiono affatto più lucidi di noi che siamo intruppati nel disorientamento della tempesta in atto. Chissà se loro lo sanno, dove stiamo andando e dove ci stanno portando. Se questa transizione ha uno scopo, avrà una fine. O se anche a loro tocca stare in mezzo alla tempesta e affidarsi alla deriva di un mondo pieno di cose prodotte da noi ma che non controlliamo più. Un transitare dentro un mondo in cui la tempesta non ha il ritmo della natura, ma quello della tecnica. La chiamiamo transizione ecologica, appunto. Un rovescio delle cose: quello in cui è la nave che porta tempesta ed è il mare che è costretto a temerla. Se la transizione ci è sfuggita di mano non è solo perché non possiamo più affidarci al ritmo della natura per attendere la sua fine – nessuna danza della pioggia può funzionare ormai e a volte persino la scienza appare consunta (specie quando i suoi scienziati la presentano come una nuova forma del pensiero magico e ci tengono a sembrare apprendisti stregoni). Ma è anche perché essa appare come complessa e plurale. Non c’è una sfera di questo mondo comune che abitiamo che non abbia in comune l’essere in transizione.
Il virus ha solo smascherato le transizioni già in atto
Il vecchio è passato in politica, nelle forme della società, nell’organizzazione del capitalismo, nell’impatto del lavoro sulle nostre vite, nella disarticolazione dei legami sociali, nella mancanza di pietà a cui abbiamo consegnato la maggior parte delle nostre parole, nell’aridità a cui abbiamo ridotto l’ideale democratico. Il virus ha smascherato questa pluralità delle transizioni in atto. Dove finisce una decisione scientifica e comincia una decisione politica? Fino a che punto la necessità di far girare l’economia può compromettere la priorità della salute? Mentre tutti si affannano a rispondere con veemenza e pieni di certezze, io mi azzittisco. Mi pare tutto troppo complesso, tutto troppo dismisurato per poter orientarci, capire dove stiamo andando. Così mentre anche l’ultimo dei rematori sente di poter urlare sui social che lui lo sa dove stiamo andando, a me pare evidente che anche i nocchieri si siano smarriti dentro questa tempesta. Che la chiarezza è solo un modo per nascondere la paura del tempo opaco che ci è toccato. E che il pensiero – anche la filosofia se posso permettermi – dovrebbe servire a concepire la transizione, non a risolverla. A capirne il senso, ad entrare dentro la profondità del labirinto che attraversiamo.
Concepire: accogliere dentro di sé. Il seme del nuovo o soltanto – per ora, ma fino in fondo – la fine del vecchio? Accogliere dentro di sé ciò che non c’è più prima ancora di accogliere ciò che non c’è ancora. Il vecchio è passato dovunque, non c’è più. Al limite resta nella forma di ciò che non possiamo più avere e che rimpiangiamo. Come il disorientamento, così anche la nostalgia finisce per diventare uno stato d’animo politico, di questi tempi.
È tempo di pensare, non di risolvere
Ecco, quello che ho appena scritto è molto più importante di quel che sembra. Se c’è un compito che possiamo concederci – gli esseri umani che ancora sentono di poter esercitare una responsabilità del pensiero – è proprio quello di opporre alla disumanità di queste oscure transizioni – che segnano un tempo che è il nostro – il lavoro del concepimento. Concepire, non risolvere. Sperimentare la fatica del concetto nel deserto dismisurato del disorientamento. Qualcuno di voi ricorderà quel pezzo sublime di Arvo Part intitolato Sarah was Ninety Years Old. Il compositore mette in musica una transizione senza speranza, senza grazia. Sara, la moglie di Abramo, che gli darà un figlio ben oltre il tempo del possibile. Certo, la grazia arriverà. Ma prima ci sono soltanto i rari fuochi delle percussioni, la povertà del silenzio e di un passaggio nel disorientamento delle cose. Siamo come Sara, adesso. Dentro questo attraversamento verso ciò che non può più accadere, forse. Ma non c’è una via della speranza se non prendendo sul serio la disperazione, così come ogni consolazione ha come proprio punto d’origine una desolazione. Siamo in transito e siamo desolati, adesso. La musica di Arvo Part è la prova che c’è della bellezza anche nel transitare, a condizione di continuare a concepire. Di non fermarsi, di continuare a lottare perché un piccolo fuoco resti acceso. Questo piccolo compito ci è dato, di questi tempi. Non fare della transizione un’epoca, ma un passaggio tra epoche. Preparare il nuovo, con la forza e la quiete degli uomini invisibili che non fanno la storia. Concepire: fare della transizione un passaggio, farla passare. Inventare un senso, una direzione. Addomesticare la dismisura, addolcirla. Darle parole, costruire delle parole come si costruiscono i rifugi di fortuna. E dalle parole ricostruire città e forme di vita e senso di giustizia. Nulla suona più utopico ormai del credere che le parole possano concepire un mondo. Ma non stiamo morendo di utopie, ci stiamo essiccando per troppo realismo. La grazia mancante non verrà dall’alto, verrà da dentro.