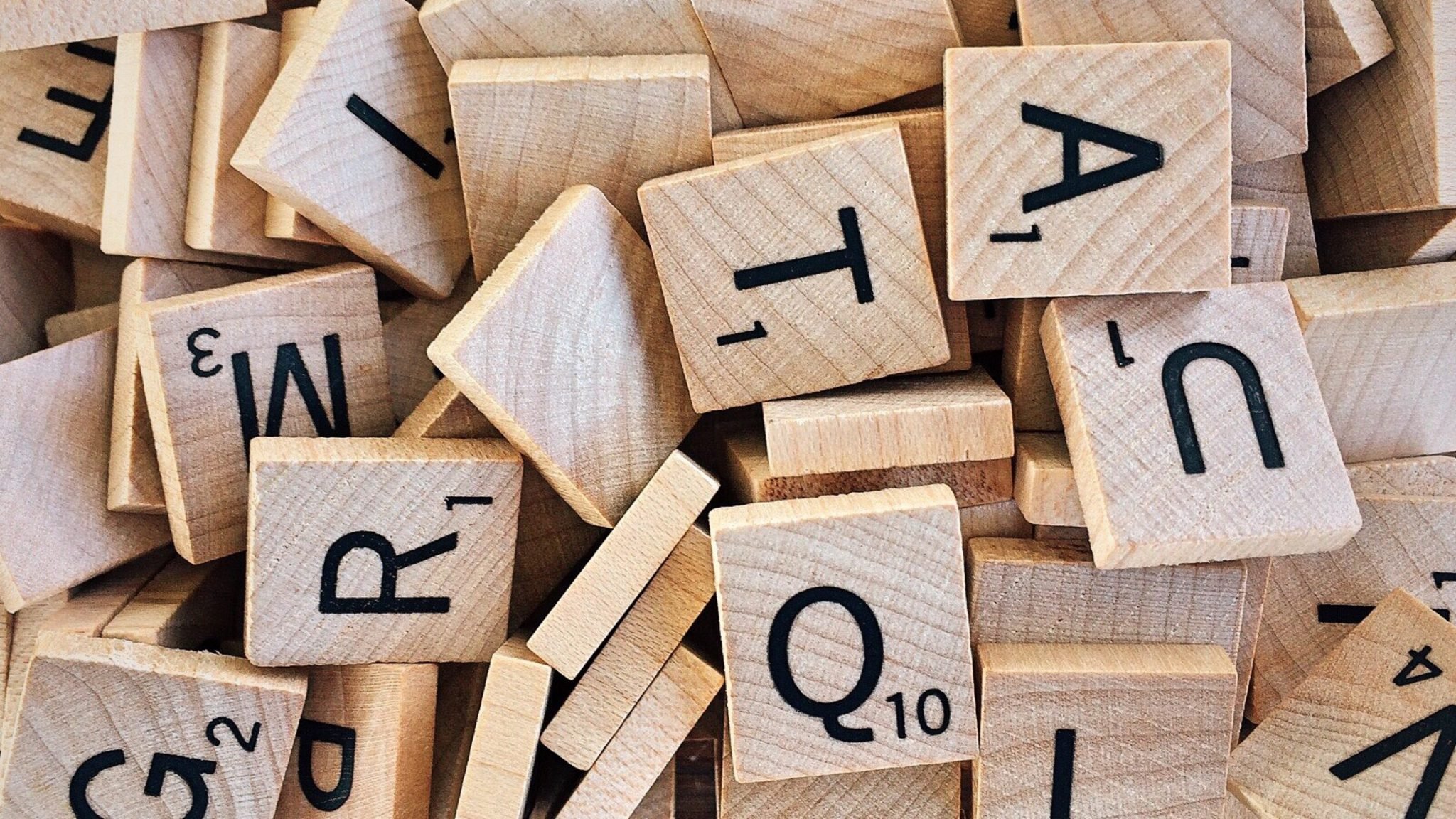Oggi più che mai uno degli aspetti più carenti nella nostra esistenza è la consapevolezza, o meglio ancora l’autoconsapevolezza. Secondo una ricerca condotta dalla psicologa Tasha Eurich pare che il 95% delle persone pensi di essere consapevole di sé, ma in realtà solo il 10/15% lo è veramente.
Questo in buona parte pare che dipenda dalle molteplici distrazioni in cui siamo costantemente immersi, i moderni strumenti di comunicazione e informazione sempre attivi e operativi, gli smartphone, i tablet, i social media, i social network, i sistemi di messaggistica istantanea: tutte cose che richiamano continuamente la nostra attenzione e ci allontanano sempre di più da noi stessi. Inoltre, nella quotidianità, il nostro cervello e le nostre azioni proseguono in ampia parte in modo automatico, oltre che distorto da convinzioni e pregiudizi che abbiamo ereditato dal contesto familiare, educativo, culturale, sociale, professionale; cose che solo incidentalmente siamo propensi a notare e ancora meno a mettere in discussione.
Che cos’è la consapevolezza?
La consapevolezza consiste nell’essere consci dei propri pensieri, emozioni e percezioni. Noi non siamo quello che facciamo, pensiamo o proviamo. Ciò che sperimentiamo può contribuire alla nostra esperienza, ma non è in grado di definire la nostra natura.
Per essere consapevoli è fondamentale essere attenti e presenti a noi stessi, a quello che nel momento presente accade dentro e fuori di noi. Affinché si instauri questa condizione si deve creare al nostro interno uno spazio vuoto, silenzioso e accogliente, in cui sia possibile osservare tutto quello che si verifica senza giudicarlo. Per esemplificare con una metafora: è come stare all’interno di una tempesta, senza identificarsi né farsi travolgere dalla tempesta stessa. È una forma di osservazione da testimone.
Tale modalità di osservazione sembra semplice da attuare e di fatto lo è, ma nella concretezza risulta più difficile di quanto si possa immaginare. In genere tutti noi siamo in grado di identificare un pensiero, un’emozione, una percezione in quanto tali. Quando ad esempio affiora un pensiero dentro di noi, questo non lo rende reale, tangibile, consistente; qualcosa su cui agire o a cui necessariamente credere. Esso non corrisponde alla nostra natura, a ciò che siamo. Se si affaccia un pensiero che definiamo cattivo non necessariamente siamo delle persone cattive.
In genere, però, quando compare una percezione, un’emozione o un pensiero, tendiamo immediatamente a giudicarli. Ci sentiamo subito responsabili di quanto è affiorato nella nostra mente. Se è vero che siamo responsabili di cosa fare di ciò che appare nella nostra mente – cioè ad esempio lasciarlo andare, farsi una risata, o andare da uno psicologo per farci aiutare – può essere altrettanto vera l’assunzione che la mente produce percezioni, emozioni e pensieri; è frutto della sua stessa natura, rispetto alla quale la nostra responsabilità in ampia parte decade.
Se ci identifichiamo eccessivamente con quello che accade nella nostra mente, la vita può diventare molto pesante e faticosa. Se crediamo a tutto quello che la mente racconta, se ci identifichiamo con essa, paradossalmente perdiamo lucidità e consapevolezza.
Questo fenomeno si nota chiaramente e in modo preponderante nelle discussioni, spesso molto accese e faziose, che negli ultimi tempi si verificano sui social network. Si difende la propria visione del mondo, che in quanto tale è soggettiva, come se in gioco ci fosse proprio la nostra stessa persona, la nostra stessa esistenza. La consapevolezza di sé e del mondo può essere la chiave di volta che permette di uscire da questo circolo vizioso, che conduce inesorabilmente ad allontanarsi da se stessi e dagli altri.
Come si manifesta la consapevolezza?
La consapevolezza è prima di tutto un processo. Non esiste, né probabilmente mai esisterà, un essere umano che sia totalmente consapevole di se stesso e del mondo. La consapevolezza è come un viaggio, una meta ideale a cui tendere progressivamente.
Secondo gli psicologi Shelley Duval e Robert Wicklund l’autoconsapevolezza è legata ad una forma di valutazione di noi stessi, secondo i nostri principi e valori. Essa a sua volta è connessa all’autocontrollo. Sullo stesso filone si posiziona Daniel Goleman, che sostiene che l’autoconsapevolezza è strettamente imparentata con l’intelligenza emotiva, cioè la capacità di monitorare, conoscere, controllare le nostre emozioni e gli stati interiori quando sorgono.
L’autoconsapevolezza, in verità, non ha a che fare solo con ciò che notiamo di noi stessi, ma anche con il modo in cui lo osserviamo. Affinché l’autoconsapevolezza sia autentica e profonda è necessario che vi sia una forma di non giudizio e accettazione di tutto ciò che si manifesta. Questa disposizione d’animo è descritta e attuata molto bene nelle diverse pratiche della meditazione che insegnano una forma di attenzione, presenza nel qui ed ora, senza giudizio, con accettazione e libero fluire di quello che c’è.
L’autoconsapevolezza non è un semplice accumulo di conoscenze circa la nostra natura, anzi: è un cominciare ogni giorno da capo tale indagine, come se fosse sempre la prima volta. Implica mantenere apertura, curiosità e meraviglia in ogni istante.
Se accumuliamo conoscenze, se ci basiamo eccessivamente sulle nostre esperienze passate, il rischio è quello di cadere vittime dei pregiudizi, schemi mentali che noi stessi ci siamo creati, che magari hanno funzionato in passato, ma che non sempre nel futuro si riconfermano validi.
Perché la consapevolezza è importante?
L’autoconsapevolezza è uno degli elementi basilari della intelligenza emotiva. Essa, inoltre:
- consente di agire attivamente anziché limitarsi a reagire oppure restare passivi;
- permette di conseguire un buon equilibrio psicofisico;
- aiuta a sviluppare pazienza, tolleranza, compassione, verso se stessi e gli altri;
- stimola la capacità di essere degli ottimi leader;
- favorisce l’inclinazione ad avere successo al lavoro e negli affari.
A questo proposito, una ricerca condotta da Green Peak Partners e dalla Cornell University ha messo in luce che una consapevolezza elevata è il fattore principale in grado di predire il successo.
Perché non è facile essere sempre consapevoli?
La consapevolezza è un processo in costante evoluzione. È qualcosa che si rinnova istante dopo istante. Non si può affermare di avere raggiunto la consapevolezza una volta per tutte. È un lavorio interiore a cui occorre prestare attenzione, tempo ed energia, momento per momento. Nella vita quotidiana trascorriamo la maggior parte del nostro tempo altrove, non siamo sufficientemente attenti a quello che sta accadendo dentro e fuori di noi; siamo costantemente distratti e assorbiti da altro.
Secondo lo psicologo Matthew Killingsworth è come se vivessimo con il pilota automatico inserito, con una forma più o meno marcata di inconsapevolezza di quanto stiamo pensando, provando, vivendo o facendo. La nostra mente è totalmente assorbita da un vagare dei pensieri di cui non ci rendiamo conto.
Questa distrazione di fondo, unitamente alle distorsioni cognitive che più o meno tutti abbiamo, influisce sui nostri punti di vista, sulle decisioni che prendiamo, sulle sensazioni e le emozioni che proviamo. Ad esempio, se siamo condizionati, senza che ce ne rendiamo conto, dalla distorsione della conferma, saremo inclini a cercare tutte le informazioni che supportano una tesi che abbiamo nella testa al fine di sostenere ciò in cui crediamo, anche se non necessariamente corrisponde ai dati di realtà.
Questo atteggiamento si ripercuote su tutte le sfere e le attività della nostra vita, oltre che su noi stessi, sulla nostra persona e sui rapporti interpersonali, sia privati sia professionali. Non è un caso che in situazioni come queste a volte i nostri rapporti falliscono senza che siamo in grado di comprenderne fino in fondo le motivazioni e senza essere stati in grado di coglierne i primi segnali di incrinatura, che se fossero stati rilevati in tempo probabilmente avrebbero potuto evitarne la rottura.
La mancanza di autoconsapevolezza e l’erronea convinzione di averla conseguita può condurre a un altro grande errore di fondo. Come rileva Daniel Kahneman, esiste un’ampia differenza tra il sé sperimentato e il sé ricordato. Tale divario può influenzare abbondantemente il modo in cui prendiamo le nostre decisioni. Il modo in cui ci sentiamo mentre stiamo vivendo una situazione e il modo in cui poi la ricordiamo possono divergere fino anche al 50%. Questo iato impatta significativamente sulla storia che ci raccontiamo, su come ci relazioniamo con noi stessi e con gli altri, sulle decisioni che prendiamo e le azioni che compiamo.
Autoconsapevolezza: ecco come si coltiva
Anche se non esistono soluzioni magiche per diventare consapevoli una volta per tutte, anche se non esistono pratiche valide sempre e comunque, è possibile applicare cinque strategie che possono favorire tale processo:
- Creare dello spazio per se stessi: concedersi del tempo completamente libero da impegni e doveri; destrutturato, non programmato, meglio ancora se nel silenzio. Può stimolare a entrare in connessione e ascoltare se stessi. Leggere, scrivere e praticare la meditazione possono rappresentare dei modi in grado di stimolare questa dimensione interiore.
- Praticare la meditazione: la meditazione consiste nell’attenzione al momento presente, senza alcun giudizio, azione, reazione. Si focalizza sull’essere. In questa condizione la mente si placa, si stabilizza, osserva le cose con chiarezza. Così è possibile osservare se stessi e ciò che ci circonda, istante dopo istante. Questa dimensione interiore di attenzione, presenza e non giudizio si può vivere in qualsiasi situazione di vita: quando si mangia, si cammina e si svolge un lavoro al computer; non solo quando si sta seduti a gambe incrociate a casa, sotto un albero o in un eremo. Questo atteggiamento, praticato con costanza e dedizione, e al tempo stesso senza sforzo, può essere uno strumento magistrale per coltivare la propria consapevolezza.
- Tenere un diario: scrivere può aiutarci a liberare spazio dentro noi stessi, può permetterci di fare chiarezza, di avere una visione chiara di noi e delle nostre esperienze; ci rasserena, permette di rappacificare la mente, il cuore e il corpo. Scrivere aiuta anche a sviluppare la compassione, l’accettazione, la gratitudine. È un appuntamento con se stessi, la propria interiorità, per fare il punto della propria vita.
- Allenarsi ad ascoltare: la maggior parte di noi è più dedita a parlare o a scrivere che non ad ascoltare o leggere. L’ascolto implica la necessità di essere pienamente presenti a se stessi nel momento presente. Che stiamo ascoltando noi stessi o gli altri, non si può ascoltare con pienezza e comprendere pienamente il messaggio – verbale e non – se una parte di noi è distratta, assorta in tutt’altro, carica di giudizi, pregiudizi, critiche o risposte che vorremmo subito esporre. Esercitarsi ad ascoltare noi stessi e gli altri può andare di pari passo, l’uno può favorire e rafforzare l’altro.
- Assumere diverse prospettive: molto spesso non ci rendiamo conto che la visione della realtà, e quindi anche di noi stessi, è soggettiva. Esercitarsi ad ascoltare gli altri e a prendere in considerazione il loro punto di vista, senza pretendere di trovarne uno valido in assoluto, può essere un ottimo modo per stimolare la propria consapevolezza. Chiedere dei riscontri circa la propria persona a più individui, accettare la loro visione di noi, ci permette di comprendere come possiamo apparire agli occhi altrui nelle diverse situazioni e circostanze.