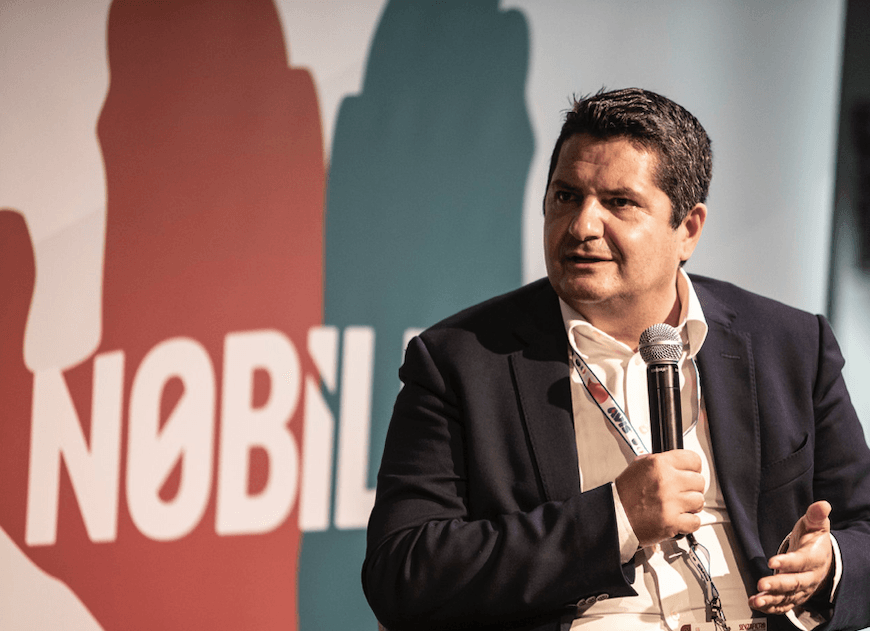
Il coordinatore nazionale di Base Italia, sulle lacune del Piano di Transizione 4.0: “È una mancanza culturale, aggravata dalle falle del sistema formativo. Ma l’innovazione ben fatta crea posti di lavoro di qualità”.
Quell’ammasso gelatinoso e grasso che portiamo dentro la scatola cranica sa essere piuttosto pigro, e tende talvolta a dare spiegazioni un po’ frettolose e raffazzonate ai quesiti con i quali più o meno consapevolmente lo stressiamo ogni giorno. Tutti sappiamo di aver superato da un pezzo la terza rivoluzione industriale, di vivere nella società dell’informazione […]

Quell’ammasso gelatinoso e grasso che portiamo dentro la scatola cranica sa essere piuttosto pigro, e tende talvolta a dare spiegazioni un po’ frettolose e raffazzonate ai quesiti con i quali più o meno consapevolmente lo stressiamo ogni giorno.
Tutti sappiamo di aver superato da un pezzo la terza rivoluzione industriale, di vivere nella società dell’informazione e della conoscenza. Ogni giorno gestiamo una mole impressionante di informazioni; eppure ancora oggi esistono aziende che non sembrano comprenderne la ricaduta all’interno delle loro organizzazioni.
È colpa dei nostri neuroni? Forse, specie se non abbiamo avuto la fortuna o la capacità di imparare a gestirli.
La storia, a dire il vero, comincerebbe piuttosto lontano, poiché quello che un imprenditore o un manager non fanno oggi è dovuto al modo in cui la loro materia grigia si è sviluppata. Tralasciando l’impatto dei geni e i problemi di attaccamento nei primissimi mesi di vita – per ragioni di spazio e di rilevanza, giacché sono aspetti immodificabili – sarà sufficiente concentrarsi sulla famiglia in cui sono vissuti, all’educazione che hanno (o non hanno) ricevuto, ai maestri e professori che hanno avuto, alle esperienze che hanno fatto – almeno fino ai 18 anni. Fino a questa età il cervello è infatti più aperto e disponibile all’apprendimento; certo la plasticità non si perde mai, ma sintetizzando dovremmo notare che esiste anche una gioventù dei neuroni. Quindi quello che si fa da giovane non lo si fa a cinquant’anni, o almeno non con la stessa facilità.
In sostanza si tratta di allenamento alla consapevolezza; altrimenti rischiamo di autoingannarci raccontandoci solo la storia più semplice e credibile che il nostro apparato neuronale riesce a inventarsi.
Questa è una delle storie che va per la maggiore. E in un certo senso non è che sia del tutto sbagliata: un’azienda che per 15-20 anni abbia fatto diversi corsi di formazione, pagato diversi formatori, sottratto alle loro mansioni i suoi lavoratori per portarli in aula, senza poi notare il cambiamento sperato, che cosa dovrebbe pensare?
Se il capo di questa azienda parla con un collega che ha avuto un’esperienza simile, è ovvio che la convinzione si rafforza e alla fine diviene una credenza: una di quelle cose potentissime in grado di orientare i nostri comportamenti. Quando un’opinione, un’idea, una convinzione raggiunge il livello di credenza, è fatta: al cervello non serve altro. Sulla base di quello a cui crediamo, prendiamo delle decisioni e agiamo di conseguenza: se credo che lo zenzero faccia bene alla salute (perché me lo ha detto un amico, l’ho letto su una rivista e poi su Facebook o Google), il gioco è fatto: sono pronto a diventare un accanito fan della radice gialla.
Certo, potrei invece chiedermi se c’è un’altra possibile spiegazione (trovare lettori, beccare qualche like, o addirittura fare storytelling a fini di marketing o pubblicità nascosta). Ma questo è appunto il “muscolo” che va allenato: la ricerca di una plausibile spiegazione alternativa, meno immediata, ma non meno fondata. Chi non lo fa passa la vita a costruirsi delle credenze che alla fine lo definiscono come persona, ma che tutto sommato non ha scelto, almeno non al 100%.
Se invece il collega avesse detto che la formazione per lui è stata utile? È difficile, direte. Forse; specie se ci interfacciamo con persone simili a noi, che hanno fatto esperienze simili alle nostre e che, come noi, non ne hanno fatte altre.
È più importante quello che sappiamo o quello che non sappiamo? Se il nostro cervello è stato allenato a credere di sapere quello che è importante, siamo finiti. Prima lo diceva Socrate, ora lo confermano le neuroscienze: dubitare è fondamentale. Se non usate i dubbi come schema mentale, dovreste imparare a farveli venire: vivrete peggio, con minor senso di sicurezza, ma con maggior consapevolezza e contatto con la realtà.
Eh sì, “abbiamo sempre fatto così, perché dovrei cambiare?” è una delle credenze più potenti. E castranti.
Vivere nell’incertezza destabilizza, mette ansia, richiede capacità di gestire le proprie emozioni; ergo è molto meglio vivere in una bolla di certezza apparente. Ovvio, tutto quello che nella bolla non ci può stare va escluso, e a fare questo lavoro sporco ci pensa sempre lui, il nostro bell’ammasso di sinapsi.
Se non lo alleniamo strategicamente e consapevolmente, il cervello si allena da solo, ma a caso. Così, allenamento, dopo allenamento, diventa sempre più forte e capace di gestire la fatica senza apparente sforzo. Quando infine raggiunge il livello di abitudine di pensiero, non necessita più di altro.
Pensiamo a un atto apparentemente semplice come guidare la macchina: oggi è un gioco da ragazzi, e ripensare alle difficoltà che avevamo a 18 anni per gestire contemporaneamente freno, frizione, cambio, acceleratore, indicatore di direzione, guardando nel contempo in ogni direzione, ci sembra quasi incredibile. Qualcuno dice che occorrono circa 10.000 ore di ripetizione per far diventare un movimento automatico: vale per gli sportivi che provano fino alla noia il gesto atletico per farlo diventare perfetto, o per i musicisti che si massacrano le dita sullo strumento e di certo non scomodano la corteccia cerebrale quando suonano una manciata di semibiscrome in un solo secondo (se lo dovessero fare, non ci riuscirebbero).
Qualcun altro, invece, allena il cervello con i pensieri che gli adulti gli hanno innestato quando era piccolo, e più il pensiero è ricorrente, più diventa forte e difficile da cambiare: se l’imprenditore ha visto il padre fare o non fare un qualcosa, e se anche suo nonno l’ha fatta o l’ha omessa, si convince che il mondo vada in un’unica direzione e che non ci sia nessuna necessità di cambiarla, perché ha la prova (l’esperienza diretta o indiretta) che fino a oggi quel modo di fare ha funzionato. Appunto: fino a oggi; ma che garanzie abbiamo che funzioni per domani, o dopodomani, o peggio ancora tra due, cinque o dieci anni?
Come ricorda Taleb, potremmo aver fatto centinaia, migliaia o milioni di esperienze positive, ma nessuna di queste potrà mai escluderne una negativa. Sta tutto ancora una volta nell’immaginare e ritenere plausibile un’altra spiegazione. Purtroppo chi non si allena a pensare in questo senso poi è quello che non sopravvive e non può andare in giro a raccontare di aver sbagliato. “Abbiamo sempre fatto così”, infatti, produce un bel numero di fallimenti, chiusure, liquidazioni, che però vengono attribuiti a un’altra causa. Ovviamente.
Anche questa storia non è del tutto errata, anzi. In Italia ci sono centinaia di migliaia di provvedimenti legislativi, e star dietro a tutto è virtualmente impossibile. Giusto: virtualmente.
La formazione obbligatoria va fatta perché appunto è obbligatoria, è tanta, e poi non è risolutiva (vedi sopra): ad esempio gli incidenti sul lavoro continuano a verificarsi, e dopo la legge 81/2008 non è che siano diminuiti.
C’è qualcosa che non va. La fregatura è che pure il cervello del legislatore è in realtà solo un ammasso di cervelli umani (e nemmeno sempre gli stessi), dunque non può che soffrire degli stessi problemi. Cambia solo il contenuto della credenza: crede che per risolvere i problemi basti fare una legge e mettere una sanzione.
E allora? La soluzione alternativa, non immediata ma plausibile, si chiama “priorità”: quali sono le nostre? Il guadagno, la commessa, l’ordine, la produzione, il cliente, il benessere, la sicurezza, l’impatto sull’ambiente circostante? Già ordinare seriamente questa scaletta può mettere in difficoltà.
Poi occorre capire la dimensione temporale. Certamente non si possono far acquisire tutte le competenze nello stesso momento, e chi ci prova diventa la prima ragione del fallimento, avendo posto un orizzonte irrealizzabile. Se non si possono fare, ad esempio, dieci corsi di formazione in un anno, li si potrebbe fare in tre anni (o in due, o in quattro). Stabilito questo, bisogna chiedersi con cosa iniziare, ossia il corso più importante – che a sua volta è una credenza. Credo che sia più importante il corso sulla sicurezza del lavoro perché ho paura che poi l’autorità mi farà chiudere se non lo faccio? O quello sul gestionale, o per i venditori? Di certo non quello sulla privacy, tanto mica siamo nella società dell’informazione. E poi cos’ho di così importante nei miei computer? Altra credenza: l’auto-indulgenza basata sulla più latina delle ignoranze, quella di non sapere come funziona davvero il rischio informatico e di quanto costa proteggersi.
Forse, alla fine, la cosa più importante sarebbe fare un bel corso sulle credenze: lo dovremmo fare noi, insieme a tutti i nostri collaboratori, e dopo averlo fatto elaborare un modo per portare quelle nuove conoscenze nella quotidianità della vita aziendale, fino a farle diventare delle nuove abitudini. Non è semplice, non è immediato, ma crea organizzazioni resilienti e anti-fragili.
Fate vobis. Altrimenti le vostre credenze continueranno ad agire al posto vostro.
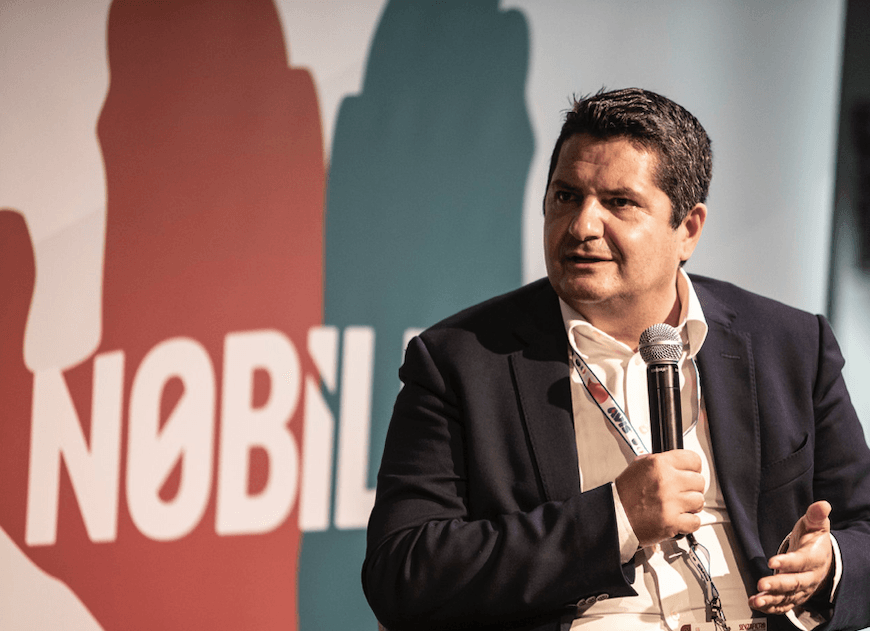
Il coordinatore nazionale di Base Italia, sulle lacune del Piano di Transizione 4.0: “È una mancanza culturale, aggravata dalle falle del sistema formativo. Ma l’innovazione ben fatta crea posti di lavoro di qualità”.

L’ascensore sociale è rotto da tempo: ecco quanto influiscono le condizioni di partenza sullo studio e la carriera dei giovani, con gli ultimi dati e l’interpretazione di Mikhail Maslennikov di Oxfam Italia.

Il tema è molto dibattuto in Italia e pone numerosi interrogativi – legittimi – sul perché, quando i giovani affermano di voler studiare Storia dell’Arte per lavorare nel settore culturale del nostro Paese, rimaniamo scettici. Partendo dalla famosa e infelice frase “con la cultura non si mangia” attribuita a Giulio Tremonti, il quale ha poi […]