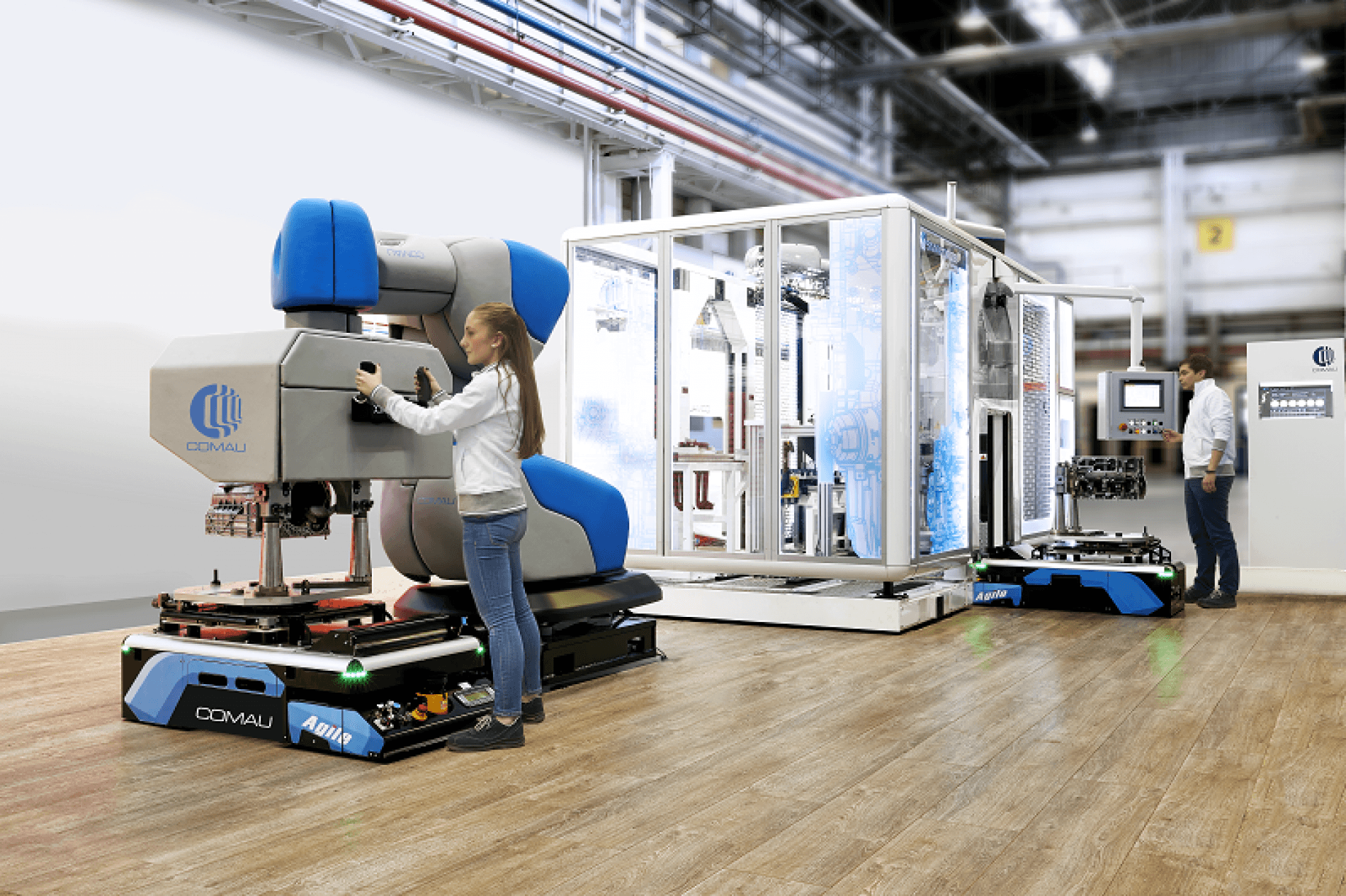Si è parlato di accelerazione digitale, eppure sarebbe più corretto dire che la parola “digitale” è solo una conseguenza di un unico grande processo, inevitabile, chiamato accelerazione. Molte aziende hanno dovuto imparare dall’oggi al domani che cosa vuol dire davvero disruptive innovation, e ripensare la relazione tra organizzazione, persone, processi e tecnologie; altre hanno dovuto reingegnerizzare completamente il proprio modello di business partendo dall’IT come fattore abilitante, pena la sopravvivenza. Abbiamo accelerato restando fermi, chiusi in casa per la precisione, mentre alcune campagne di comunicazione poco illuminate ci invitavano a ripartire, a non fermarci.
Con il senno di poi si trattava dello storytelling (stavolta sì, usato con l’accezione negativa) più antico e difficile del mondo: quello del muoversi in maniera forsennata per far sì che tutto resti fermo. Un po’ come il gattopardesco “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, anche se stavolta qualcosa è andato storto. O come la nave del Titanic: tutti dritti verso l’iceberg, ma sempre danzando e cantando, incapaci di immaginare scenari migliori o semplicemente diversi da quelli a cui ci eravamo abituati. Il lavoro come unica ragione di vita, il lavoro come realizzazione, il posto in cui si lavora come luogo dove trascorrere la vita. La tecnologia come surrogato delle relazioni, non come facilitatore delle connessioni. Il lavoro come privilegio, non come bene comune di tutto il Paese e non solo di una parte o, peggio ancora, esclusiva di un’unica città.
Milano e il circolo vizioso del lavoro
E a ben guardare anche tre mesi di accelerazione possono essere cancellati da un pregiudizio. Che sia stata detta in buona o in cattiva fede, la frase del sindaco di Milano Beppe Sala (“Bello l’esperimento dello smart working, ma adesso è ora di tornare a lavorare”) nasconde molti significati e una traduzione: “È ora di rifare le valigie, lasciare di nuovo il Sud e ritornare qui a far girare l’economia”. Sì, quella dei bar, dei ristoranti, dei mezzi di trasporto, fino ad arrivare agli affitti, agli asili privati, e via via a tutto il resto.
Anziché pensare a nuove soluzioni, più sostenibili a livello di mobilità, di economia e in termini di qualità della vita, si sta pensando a ripristinare il prima possibile il solito circolo vizioso: mi trasferisco a lavorare a Milano, affitto o compro casa a prezzi altissimi, esco la mattina presto, faccio colazione al bar, pausa pranzo di un’ora con un petto di pollo sintetico e una foglia di insalata a 15 euro, torno a lavoro, esco tardi, rimedio alla spesa che non riuscirò a fare con un apericena da 20 euro per evitare di cucinare perché sono stanco, vado a letto e ricomincio da capo. Per i locali, sicuramente un affare. Per i lavoratori, per il loro portafoglio e anche per il loro fegato sicuramente meno.
Senza contare che il business della pausa pranzo non è solo un’esclusiva di Milano, ma dovrebbe esserlo anche di altre città: Sala ha pensato a quante persone nel frattempo hanno iniziato a fare colazione e a pranzare a Pavia, Cremona, Bergamo, Brescia e Piacenza – sempre per restare al Nord – in qualità di smart worker? Probabilmente no, e questo è tipico di chi crede che l’economia giri solo intorno a una città. Sicuramente confortato dai dati, va detto anche questo, non solo da un delirio di onnipotenza.
Non si tratta assolutamente di Milano vs resto d’Italia – sebbene le giustificazioni non siano richieste, chi scrive ama Milano. Non è una gara e non c’è bisogno di demonizzare la città più produttiva ed evoluta d’Italia, anzi. Si tratta semplicemente di riconsiderare il mercato del lavoro e in generale la qualità della vita, ponendoci una domanda che si trasforma immediatamente nella sfida più importante che dovrà affrontare l’Italia – se finalmente per Italia inizieremo a considerare anche la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Campania, le Marche e via dicendo – nei prossimi anni:
“Potremo smettere di progettare la nostra vita sul (luogo di) lavoro?”
E se i meridionali rimanessero a lavorare al Sud?
Una domanda e una sfida ambiziosa, che certamente lascerà qualcuno scontento, ma che può simboleggiare la vera e più interessante rivoluzione dello smart working. Non più casa contro ufficio, e nemmeno grotta contro open space (a proposito, siamo ancora certi che l’open space sia la migliore soluzione per collaborare?), ma la scelta di lavorare in un posto che chiamiamo casa.
Vi ricordate i tempi in cui le aziende di Palermo, Bari o Salerno simulavano di avere, tra i numeri di telefono, uno 02 perché così potevano dire di avere una sede a Milano? Magari quei tempi sono alle spalle. Sceglieremo i nostri partner, i fornitori, le agenzie di comunicazione e tutti quei lavori liquidi unicamente in base alle capacità delle persone. Perché questa sarà l’unica discriminante. Il che vorrà dire che bisognerà essere sempre più formati, specializzati, abili a farsi scegliere e anche ad abbattere qualche pregiudizio. Come quello che al Sud ci si va solo per fare le vacanze. Provate a collegarvi in videochiamata da Monopoli, da Tropea o da Sciacca e nei primi dieci minuti vi toccherà giustificarvi e dire che siete a lavoro e non in vacanza. Come se collegarsi da un posto di mare o fare una passeggiata in campagna a pausa pranzo sia una colpa da dover scontare.
Ma che cosa succederebbe, davvero, se tutti i cervelli che sono tornati al Sud in questi mesi decidessero di restarci anziché rimandare a settembre – perché di questo si parla – il loro ritorno nella metropoli? Succederebbe che dovremmo ridisegnare una nuova economia, a partire dalla scelta dell’università, probabilmente. Tutto questo non può avvenire solo grazie al WiFi, è bene dirlo, altrimenti facciamo l’errore opposto. Ci vorranno idee, un cambio di cultura (anche piuttosto radicale), strutture e investimenti: sono le aziende infatti che devono dotare i propri dipendenti e collaboratori dei device giusti per lavorare da remoto. Non sarà una passeggiata, ma è una prospettiva possibile e tangibile, oggi, quella dei treni che non ritornano indietro.
Sud = vacanza, Nord = lavoro. Ma è davvero così?
Citando Giorgio Soffiato, fondatore di Marketing Arena: “Forse sullo Smart Working non stiamo cogliendo un punto: la gentrificazione da turismo è ben chiara, lo era meno quella da lavoro. Un tempo i quartieri residenziali alimentavano il commercio e le periferie il lavoro (fabbriche). L’economia dei servizi ha reso il centro il luogo del lavoro e la periferia il luogo dove dormire, con la particolarità che la bottega è divenuta un pied-à-terre chic dei knowledge worker. È questo che manda nei matti Beppe Sala: la fabbrica del capitale cognitivo sta in uno zaino, e si muove. Se viene meno il patto sociale per cui quel capitale va prodotto per pura convenzione in certi luoghi, viene meno il senso dei luoghi. E il relativo mercato immobiliare e commerciale. Per non sparire le grandi città devono lavorare per divenire insostituibili, la verità è che uno choc termico ha svelato che semplicemente non serviva essere così spesso sul posto, così in tanti. Bel casino”.
Si dirà che non tutti i lavori possono essere fatti in smart working, eppure la maggior parte dei professionisti delle grandi città sono lavoratori ad alto valore aggiunto e quindi in grado di lavorare da remoto. Molti manager, già da tempo, raggiungono Milano il lunedì mattina con i voli delle 7 e delle 8 e tornano a casa loro il giovedì pomeriggio per lavorare da Salerno, Taranto o Foggia da remoto l’ultimo giorno della settimana. Non è una rivoluzione, è una evoluzione del mercato del lavoro. Come spesso accade, è anche una questione di termini e di parole. Frasi che ognuno di noi avrà sentito diverse volte:
“So che sei in Puglia, ti disturbo solo dieci minuti.”
“Sì, ma guarda che sto lavorando, non preoccuparti.”
Oppure:
“Bella vita, in Sicilia! Quando torni a lavorare?”
“Il WiFi veramente funziona anche qui.”
E così via.
Non vi sembra che le parole di Sala siano la conseguenza di anni di convenzioni e di abitudini a frasi come queste? Parole che tendono a categorizzare il Sud esclusivamente come luogo turistico e il Nord, anzi una città della Lombardia, come luogo di lavoro.
Restare al Sud: non un ripiego, ma una scelta. Che va favorita
Ma il lavoro è anche altrove, e i tre mesi di lockdown ci dicono che al netto di problematiche oggettive sulle quali torneremo (spazi in casa non adeguati, nessuna agevolazione per chi ha figli, connettività limitata), con lo smart working si è più concentrati e produttivi, si risparmiano soldi, si è liberi di vivere dove si vuole e non per forza in piccoli appartamenti in città a prezzi esorbitanti; si guadagna tempo per sé e per il lavoro stesso, l’aria delle città diventa più respirabile.
L’intelligenza – come ha scritto Veronica Sambati su Linkedin – sta nel guardare oltre l’esperienza vissuta durante il periodo che ci siamo appena messi alle spalle. Aziende e dipendenti impreparati a questa modalità si sono sentiti disorientati, così come quei lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da casa mentre partner e figli erano impegnati a lavorare e studiare vedono solo aspetti negativi nel remote working. Ma tornare al punto in cui ci siamo lasciati a febbraio, come se nulla fosse successo, e fare dieci passi indietro, è davvero poco intelligente. Interrogarci ancora sull’efficacia di una sana alternanza tra ufficio, casa o altri luoghi dai quali è possibile lavorare e sminuirne il valore è sinonimo di arretratezza culturale.
In un Paese che già arranca sulla strada di una sana cultura del lavoro e dell’innovazione (che non è una parola da usare a caso nei comizi delle associazioni di categoria), l’ultima cosa che serve è la convinzione, alimentata da preconcetti e dalle istituzioni, che solo in un determinato posto si possa lavorare. Nel frattempo, però c’è una nuova generazione che potrebbe sovvertire questo paradigma obsoleto: i nuovi talenti. E università (prima) e aziende (dopo) faranno a gara per accaparrarseli. E non è detto che a questi ragazzi, cresciuti a pane e digitale, vada bene l’idea di doversi trasferire per lavoro. Una cosa per noi normalissima potrebbe non esserlo per ragazzi che si sono diplomati seguendo lezioni su Google Meet o si sono laureati con Zoom. Adesso che hanno compreso che tutto questo è fattibile, chi glielo spiega che dovranno seguire le orme dei loro genitori o dei loro nonni? Non è forse questo il significato di accelerazione?
Andrà riconsiderato completamente il concetto di squadra, e nasceranno nuove modalità di lavorare sul team building vedendosi magari di persona solo una volta al mese e online in altre maniere. Perché non si può pensare che un giovane professionista abbia bisogno anche di crescere, di “respirare un ambiente lavorativo” e di avere accanto (spesso anche fisicamente) un tutore di esperienza. Sono tutti spunti sui quali bisognerà lavorare, a meno che non pensiamo di diventare tutti freelance.
Le università del Sud hanno sùbito una grande occasione: quanti genitori avranno voglia di impegnare soldi per le caparre di appartamenti in città lontane, sapendo che in autunno potrebbe ripresentarsi il problema del virus? Come al solito non basta aspettare i problemi degli altri. Le regioni devono organizzarsi per offrire agli studenti servizi come posti letto, mense, mezzi di trasporto, che ad oggi non sono all’altezza e quindi nemmeno attrattive: restare a Sud non deve essere un ripiego, ma una scelta. Solo così si può invertire il senso delle convenzioni e anche quello dei treni: verso sud = vacanza, verso nord = lavoro. Non sarà solo una questione di lavoro, ma anche e soprattutto di geografia. Di spazio, di natura e di umanità.
Photo credits: www.meteoweb.eu