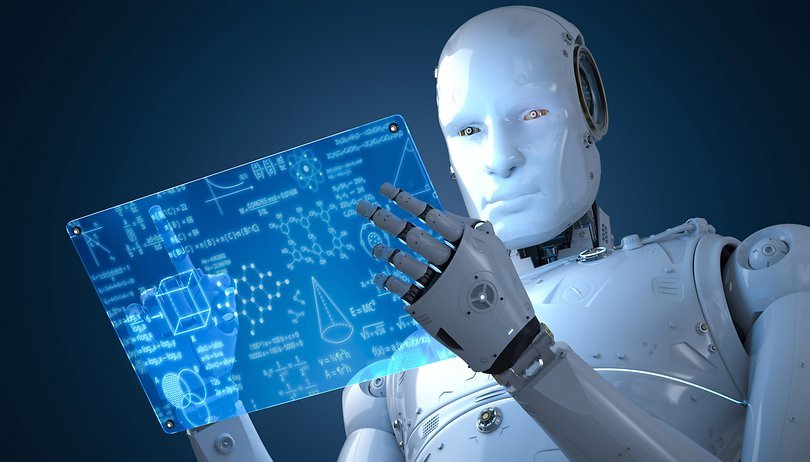Growth hacker, frontend developer, SEO specialist o community manager. Basterebbe aver scritto sul proprio bigliettino da visita una di queste qualifiche per rendere difficile spiegare qual è la propria occupazione a chi non è del settore. Eppure queste, come tante altre professioni, sono diventate la nervatura di quel sistema complesso che è la comunicazione online, o per meglio dire (e citare il filosofo Luciano Floridi), on-life.
Ma parole e concetti non sempre vanno di pari passo. Capita infatti che entrino nel gergo comune – soprattutto se professionale – dei neologismi per identificare con precisione chirurgica idee e pratiche che sono sempre esistite. Perché in un mondo sempre più ibrido e disintermediato, il basculare violento tra un inglesismo buttato a caso e una ricerca di competenze sempre più specializzate genera quel senso di disorientamento scatenato da tutto ciò che è nuovo, e quindi incerto.
Ho chiesto a Daniele Chieffi – fino a poche ore fa a capo della parte digitale dell’agenzia di stampa AGI e da oggi Responsabile della Comunicazione del neonato Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione – di giocare insieme, cercando di fare ordine tra parole vecchie e concetti nuovi per capire dove stia andando la comunicazione.
Ciao Daniele. Precisamente trent’anni fa crollava il muro di Berlino, sancendo il passaggio tra due periodi storici. Nel mondo della comunicazione pensi ci sia stato un avvenimento di rottura che possa essere equiparato al novembre ’89?
Senza dubbio sì, ed è accaduto nel 2007. Tutti pensano che la rivoluzione digitale sia partita negli anni Novanta, ma quello è stato solo l’inizio di un processo che è culminato con il lancio del primo iPhone e l’esplosione di Facebook. Il digitale, che è sempre stato una realtà veloce e pervasiva, era però vincolato al tempo e allo spazio. In sostanza dovevi usare un computer per accedere alla rete, e questo comportava una netta divisione con il mondo reale. Ti ricordi Second Life?
Sembrava un’alternativa digitale alla vita reale e poi è finito nell’oblio. Forse ha peccato di presunzione, accentuando una spaccatura che esiste solo a livello “accademico”.
Con l’avvento dello smartphone e dei social il digitale è diventato la nervatura della vita reale. Oggi viviamo immersi nell’infosfera, a me piace chiamarla così.
Ma c’è più democrazia?
Internet ha fallito perché non ha portato maggiore consapevolezza e maggiore conoscenza. Colpa dei comunicatori e di un errato utilizzo delle possibilità del digitale. Ancora oggi potrebbe essere il più potente strumento di democrazia e conoscenza, ma la nostra mancanza di consapevolezza ci porta a credere di dominare il sapere e in realtà sappiamo molto meno di prima; perché non approfondiamo, ma collezioniamo nozioni. È una dinamica che ci rende molto meno liberi e molto meno democratici. In questo momento il potere ce l’ha chi è in grado di gestire queste dinamiche, e in questo senso c’è meno democrazia.
E la comunicazione come è cambiata dopo “la rivoluzione”?
I processi comunicativi sono stati stravolti. Siamo passati da una comunicazione che si muoveva su piattaforme a una comunicazione che si muove su dinamiche psicologiche e di tipo percettivo. Un flusso che si snoda all’interno di una sfera sociale. Oggi, a differenza di qualche anno fa, la comunicazione non è più univoca, ma è un processo condiviso e partecipato.
Tu sei il responsabile della comunicazione digitale di Agi, una delle principali agenzie giornalistiche italiane. Sono realtà che immagino ne abbiano risentito fortemente.
Le agenzie sono state le prime vittime di questo cambiamento. Prima erano la fonte primaria di informazione in un mondo disintermediato. Ora si sono dovute reinventare come testate, anche se paradossalmente si sono trovate meglio dei giornali, perché essendo l’unico media a flusso anziché a ciclo hanno avuto più facilità ad adattarsi.
Anche le agenzie sono state invase dalla necessità di fare storytelling, un termine che a sua volta da qualche anno invade un po’ tutti noi. Ma è una parola nuova?
Storytelling non è una parola nuova; anzi, è probabilmente una delle parole più antiche nel campo della comunicazione. La comunicazione è sempre stato il raccontare storie. Se ci pensi le pitture rupestri sono la prima forma di storytelling, e anche se alcuni oggi sostengono che fare storytelling sia una nuova forma di comunicazione, io credo che consista nel fare esattamente quello che facevano i cantastorie medievali, solo con modalità e finalità diverse. Fare storytelling è uno strumento, un approccio che tutti oggi devono avere.
Anche le aziende: un’altra figura che si è affacciata nel mondo del lavoro è il brand teller. Perché il giornalista è il professionista più accreditato per ricoprire quella casella?
Il giornalista, per formazione e deformazione professionale, è l’unica figura che possiede la capacità di identificare la rilevanza di un fatto nei confronti di un pubblico di riferimento, e questo è il cuore della comunicazione perché oggi, trovandoci davanti un sistema di comunicazione disintermediato ed essendo le aziende costrette a misurarsi con fenomeni sociali (dialogo), in una conversazione si devono dire delle cose interessanti. Per farlo devi capire cosa interessa al tuo pubblico. Ascoltare viene dunque molto prima di rispondere.
E prima?
Prima non c’era questo bisogno. I professionisti della comunicazione avevano una posizione privilegiata, lavoravano in maniera intermediata. Erano, passami il termine, degli operatori B2B, e questo imponeva di conoscere delle tecniche professionali all’interno di un ambiente professionale. Oggi si devono selezionare i fatti (tra quelli prodotti) che possono essere interessanti, divertenti o utili per il pubblico di riferimento – che è ben diverso da un pubblico generale. Qualche anno fa “impacchettavamo” il pezzo non per i lettori, ma perché il caporedattore lo pubblicasse. Il rapporto era con dei colleghi, non con il pubblico. Quello che serviva era una spiccata sensibilità professionale; oggi bisogna essere interessanti, non annoiare anche con la comunicazione corporate.
Comunicazione corporate?
Sì, certo. Le aziende hanno cambiato la loro necessità in termini comunicativi. L’azienda, prima, governava la costruzione della realtà nei confronti del pubblico da una posizione di forza e grazie a una comunicazione unidirezionale. Il macroobiettivo era la notorietà di marca in modo da essere scelti dal consumatore. Oggi per la prima volta ci troviamo di fronte a una realtà in cui le aziende non hanno come obiettivo la notorietà, ma la reputazione, perché sono entrate nella stessa sfera sociale che prima motivavano, e questo impone loro di gestire le relazioni esattamente come andrebbero gestite nella vita “reale”. Lo scopo è quindi quello di essere interessanti, rilevanti, simpatici o utili.
Quindi possiamo misurare la qualità di una relazione dalla sua intensità. Ed ecco che mi viene in mente un nuovo termine: engagement. È una parola nuova, ma il concetto?
La parola è nuova ma il concetto c’è sempre stato, solo che prima veniva chiamata “mobilitazione delle masse”. Tutti i fenomeni storico/sociali sono fenomeni di engagement. La transizione nel mondo dell’infosfera ha fatto sì che la relazione diventasse un obiettivo della comunicazione aziendale. L’unico modo che abbiamo per misurare il successo di una conversazione è la partecipazione. È un fenomeno antico che si è trasformato.
Quindi è una metrica o un obiettivo?
È sia obiettivo che unità di misura. Perché non ha senso comunicare in un contesto in cui le persone non partecipano.
Molte interazioni donano anche rilevanza a un contenuto, e spesso assistiamo a fenomeni che suscitano molto rumore, il cosiddetto buzz. A livello terminologico, possiamo accostare il concetto di buzz a quello di engagement?
Solo parzialmente. Buzz è un concetto nuovo perché recupera il concetto del passaparola, ma in una dimensione diversa, perché partecipata e sociale. Non è più un fenomeno legato al tempo e allo spazio, ma è tridimensionale. Detto questo, va tenuto presente che tanto rumore non fa influenza, perché se da una parte il tanto rumore tende a essere un elemento in grado di influenzare, resta comunque un fenomeno sociale. Un’altra cosa è quando questo rumore diventa notizia.
Anche l’intensità o il rumore, che in una comunicazione “analogica” erano quasi impossibili da monitorare, sono diventati misurabili. Forse proprio i dati sono i veri figli della rivoluzione?
Anche i dati sono sempre esistiti, così come la necessità di avere informazioni. Per le grandi campagne militari del passato il generale si informava sulle forze del nemico, raccogliendo dati che venivano analizzati per prendere decisioni. La nostra vita interconnessa sta producendo una tale mole di dati che questa dimensione ha fatto un salto di qualità, diventando a tutti gli effetti la vera ricchezza. I dati, se ben elaborati, servono a prevedere, agire con consapevolezza, prevenire e risparmiare. È una dimensione che travalica quella della comunicazione.
All’interno di un’azienda chi se ne occupa?
I data analyst. Sono figure complesse che si stanno strutturando proprio in questi anni.
Chi possiede i dati detiene il potere. È giusto pensarla così?
La nuova élite è rappresentata da chi conosce le dinamiche del digitale, ne è consapevole e le sa usare. Il nuovo potere è oligopolico, ed è un aspetto terribilmente pericoloso. Se nel mondo analogico il potere è sempre stato in mano a pochi, ma era un potere reale, oggi sono entrati in gioco dei nuovi operatori invisibili che sono in grado di influenzare la visione della realtà delle persone. Se governi l’infosfera fai credere ciò che vuoi alle persone. Il politico ha bisogno di consenso, l’azienda ha bisogno di vendere. Chi governa i processi della percezione governa tutto.
Grandi numeri oggi sono mossi anche da persone singole. Per quanto i testimonial siano sempre esistiti, oggi l’influencer è a tutti gli effetti un lavoro. Un lavoro nuovo.
Sì, infatti anche il mondo degli influencer è spaccato. Ci sono quelli che si stanno avvicinando alla figura del testimonial, del personaggio (Chiara Ferragni o Selvaggia Lucarelli non si possono definire veri e propri influencer, sono testimonial), e poi soggetti più piccoli che sono all’interno di comunità molto specifiche e vengono riconosciuti, da quelle community, come opinion leader. Se possiamo inscrivere la prima categoria all’interno di un fenomeno sociale, per la seconda vale il discorso delle filter bubble: un fenomeno nativo proprio delle piattaforme digitali, che prevede la nascita di microinfluenze collegate a un ambito specifico. In sostanza, assistiamo contemporaneamente a un’atomizzazione e a una verticalizzazione dell’esercizio di influenza.
Possiamo includere il coinvolgimento degli influencer nel mare magnum delle sponsorizzazioni online. Per come sono architettate le piattaforme sembra che i contenuti non paid abbiano poco senso, soprattutto in ottica business. È così?
È difficile che un’azienda riesca a fare dei contenuti non sponsorizzati che raggiungano numeri significativi di utenti in target. Contenuti non paid ancora esistono, ma sono dei cigni neri all’interno di un processo che è diventato di routine, perché tutte le piattaforme costringono a pagare. Certo, sono più frequenti quando sono prodotti da persone; però, essendo le piattaforme delle tecnologie abilitanti alla conversazione, il contenuto non paid è la bella battuta che senti dire da una persona mentre ci stai conservando, non di più.
Puoi farmi qualche esempio di chi è riuscito a raggiungere un buon tasso di viralità “non indotta”?
La campagna Huwaei del 2018 “it’s in your hands” nacque come campagna istituzionale e televisiva. Venne anticipata sui social, ma il risultato organico fu talmente importante che scelsero di cancellare tutte le programmazioni in tv. Oppure la campagna brasiliana: essa Coca é Fanta. Coca Cola, intercettando un sentimento condiviso in Brasile e la rilevanza che un loro intervento avrebbe potuto suscitare, ha scelto di riutilizzare la frase usata per disprezzare il mondo omosessuale con il lancio di alcune lattine a tiratura limitata che, nonostante il packaging rosso tipico della coca cola, contenevano al proprio interno della fanta. L’operazione, scandita dall’hashtag #essaCocaéFanta e realizzata a costo zero (salvo l’inversione degli ugelli), è rapidamente diventata un fenomeno nazionale ed è arrivata a cambiare la tagcloud riferita a questo tema.
C’è un professionista specifico che si occupa di sponsorizzare i contenuti?
Chi si occupa di sponsorizzare non è ancora definito. È un’operazione ancora da direttore creativo o da CCO. O un’intuizione.
Il concetto di multimedialità invece come si è evoluto?
Multimedia è un termine che nasce con l’avvento del digitale, anche se il concetto oggi si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. Ha mantenuto il significato generale, ma ha inglobato tutta la realtà. Oggi “multimediale” o “cross-mediale” significa avere una visione della comunicazione spalmata tra analogico e digitale. Perché tutto riguarda l’infosfera. Un’azienda fa comunicazione ovunque: con il digital, con le persone, con i punti vendita e con gli eventi. Per questo i direttori della comunicazione e i CCO sono quelli che devono possedere una visione olistica della comunicazione, che più che competenza è una vera e propria skill.
A me piace pensare la comunicazione come un processo generativo; per questo ho lasciato come ultima parola la mia preferita, e credo anche la tua. Si tratta di “valore”.
Anche il concetto di “valore” esiste da sempre: l’annuncio in stazione è un contenuto di valore, ma nell’infosfera cambia. Il valore è un concetto ampio, perché è la capacità di mostrare di essere parte dello stesso gruppo dell’interlocutore, della stessa comunità; e, dall’altra parte, aggiungere del valore informativo, emozionale, divertente, interessante, per l’interlocutore. Se nella vita “analogica” entri in rapporto con un gruppo di persone che non ti conosce, la prima cosa che il gruppo fa guardandoti è inserire una serie di significati di cui sei portatore. Sulla base di quello ti colloca e decide se accettarti o meno. Nel momento in cui vieni identificato è tuo compito diventare simpatico. Una comunicazione efficace oggi è un processo in grado di adempiere a entrambe le fasi: produrre un apparato simbolico che induca all’accettazione e alla fiducia e aggiungere a questo dell’ulteriore valore.
Foto di copertina: Alessio Jacona