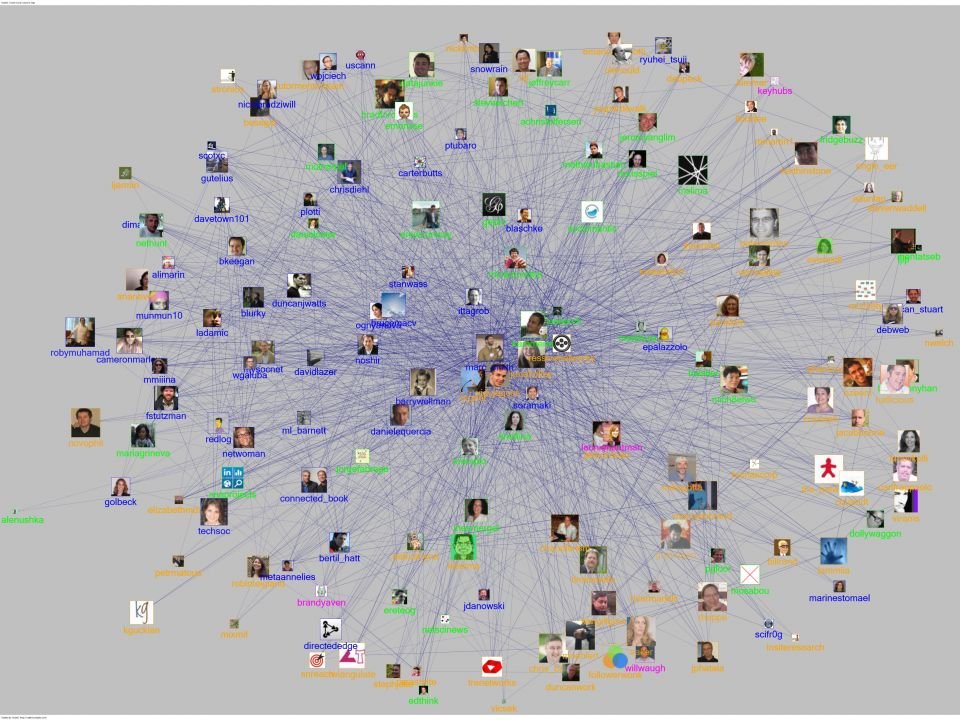L’ex ILVA, oggi Acciaierie d’Italia, un tempo parte del gruppo Italsider, uno dei simboli del boom economico italiano, potrebbe diventare una delle aziende nelle quali lo Stato ha la partecipazione più alta.
Dopo l’incontro con i soci di Arcelor Mittal, che non sono disposti a un aumento di capitale, il governo italiano ha deciso di investire 320 milioni di euro e di portare la propria partecipazione al 66%, dall’attuale 32. Più che una scelta strategica, però, sembra essere dettata dalla disperazione. Il rischio è che sulla storia contrastata dell’acciaieria di Taranto scorrano davvero i titoli di coda, perché i soci indiani non sentono ragioni e hanno detto con chiarezza che non intendono metterci più denaro. Se no il tavolo salta.
Come se non bastasse nei giorni scorsi vi sono andati anche i carabinieri per un’ispezione, legata a presunti reati ambientali. Perché l’ILVA guadagna sempre meno, ma non ha smesso di inquinare. Eppure quando nacque l’ILVA doveva essere un fiore all’occhiello della produzione italiana, all’interno dell’IRI. La privatizzazione è arrivata nel 1995, quando venne rilevata dalla famiglia Riva. Sono bastati sette anni in mano ai privati perché ci fosse il commissariamento. Dopo un tira e molla di sei anni, legato anche ai problemi di inquinamento ambientale che la popolazione segnala da anni, nel 2012 è arrivato un ulteriore commissariamento e nel 2018 l’azienda è passata ad Arcelor Mittal, che nel 2021 ha accolto l’ingresso di Invitalia (partecipata del ministero del Tesoro) con il 38%.
Il balletto degli ultimi dieci anni è andato in scena, secondo la versione da tutti condivisa, soprattutto per tutelare i posti di lavoro. Ma l’operazione non deve essere riuscita del tutto, perché si è passati dai 43.000 (tra dipendenti e indotto) del 1981 ai 10.000 di oggi (di cui 2.500 in cassa integrazione), ai quali si aggiungono 4.000 persone che fanno parte dell’indotto, che però diminuiranno ancora, visto che sono già partite le lettere di licenziamento.
A spiegare che cosa sia successo sono i dati impietosi, che sono stati forniti dallo stesso ministro del Made in Italy Adolfo Urso nel suo question time al Senato.
“Nel 2023 la produzione si è attestata a tre milioni di tonnellate, che è la stessa cifra del 2022. In programma c’era la produzione di quattro milioni di tonnellate, che nel 2025 sarebbero dovuti diventare cinque”, ha detto. “Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto. In questi anni la produzione si è ridotta. Persino negli anni in cui era profittevole in Europa la produzione è stata mantenuta bassa, lasciando campo libero agli stranieri”. Che ora se ne vanno, e minacciano pure di adire le vie legali, cosa che farebbe volentieri lo Stato italiano, se negli accordi collaterali firmati dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio non fosse stato garantito lo scudo penale. La paura è che si finisca di nuovo nel commissariamento.