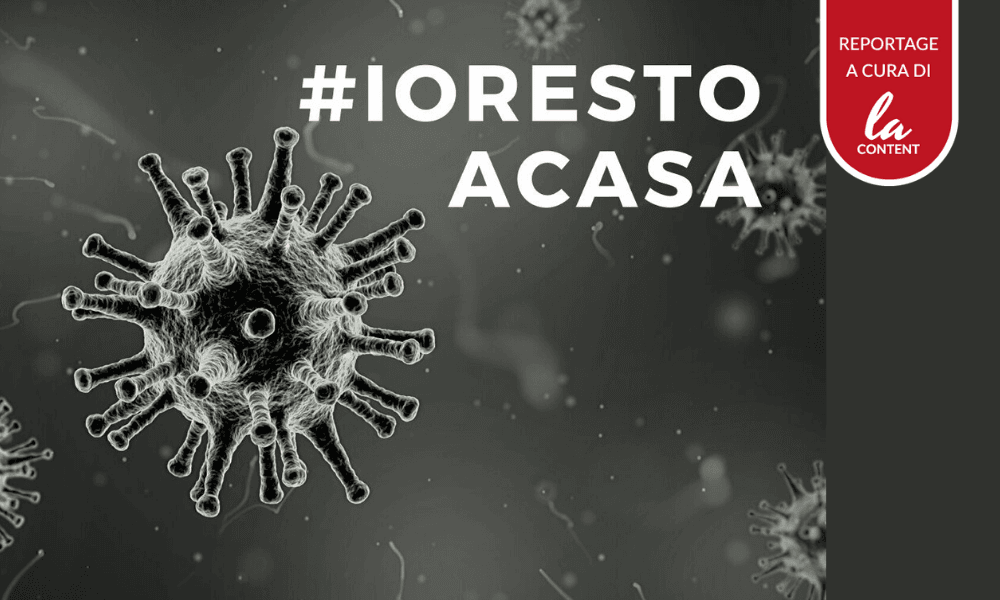Le relazioni sono alla base della nostra vita. Che si tratti di rapporti amicali, familiari o professionali, poco cambia: abbiamo tutti bisogno del prossimo, e il prossimo ha bisogno di noi.
Nonostante questa necessità intrinseca di relazionarci, malgrado la disponibilità sempre più ampia e ubiquitaria di occasioni, situazioni e strumenti per relazionarci, niente sembra tanto difficile oggi quanto costruire una relazione solida, serena, proficua, soddisfacente con altre persone.
Se poi si tratta di relazioni professionali, la faccenda si complica ulteriormente. Gli ambienti chiusi e affollati, le situazioni competitive e i ritmi frenetici, i ruoli da ricoprire e da rispettare, rendono le relazioni umane in ufficio costantemente a rischio. Liti, mancanze di rispetto, ostracismo, pettegolezzi: le modalità con cui ci relazioniamo in modo negativo ai nostri colleghi e superiori sono infinite.
Al tempo stesso, però, considerato che si trascorre circa un terzo della nostra giornata in ufficio, che per raggiungere obiettivi complessi spesso è fondamentale un lavoro di squadra, all’insegna della collaborazione e dell’armonia, se i rapporti non sono fluidi si rischia di compromettere la quantità e la qualità della produttività in azienda.
Quali sono i comportamenti che più infastidiscono le persone in azienda?
Pare che i dissapori in ufficio vertano su questioni relativamente di poco conto, che la convivenza forzata e prolungata negli stessi ambienti contribuisce a esacerbare.
Gli aspetti più insopportabili della convivenza in ufficio sembrano essere: la temperatura delle stanze, con le relative funzioni dei condizionatori e del riscaldamento, il rumore dei tacchi, l’eccesso di profumo o la scarsa igiene personale, il ritardo con cui ci si presenta agli appuntamenti o alle riunioni, l’eccesso di odore, rumore o sporcizia dei cibi che si mangiano seduti alla scrivania, il tono di voce troppo alto e altri rumori molesti, i pettegolezzi, l’eccesso di familiarità, gli sfoghi di rabbia.
Di recente si sono aggiunte anche reazioni di fastidio relative all’uso improprio delle nuove tecnologie, tra cui: uso di suonerie dello smartphone troppo alte, bizzarre, volgari; guardare il computer di un collega, anche se aziendale, che viene percepito come invasivo della propria privacy; imprimere ditate sullo schermo altrui; lasciare i dispositivi in disordine o scarichi dopo l’uso.
Come si può notare, basterebbe davvero poco per andare incontro alle esigenze dei colleghi e favorire un clima aziendale più sereno e collaborativo. Inoltre, è evidente che i comportamenti di cui ci si lamenta possono essere relativamente di poco conto, ma proprio il loro protrarsi nel tempo suscita esasperazione. Al tempo stesso, invece, quello che magari all’inizio può infastidire, col tempo può essere accettato come un’abitudine tutto sommato tollerabile.
Perché è così difficile andare d’accordo gli uni con gli altri?
La maggior parte di noi, specie se sotto pressione per il bisogno di raggiungere obiettivi importanti, accumula tensione e stress per via di un progressivo restringimento del focus su ciò che si sta facendo. In queste condizioni si tende automaticamente a escludere tutto quello che non è strettamente pertinente allo svolgimento del compito in questione.
Così come si perde in ampia parte la consapevolezza dell’ambiente e delle altre persone, lo stesso accade anche e soprattutto verso se stessi. È quella che si definisce “condizione di flusso”, in cui si è fortemente concentrati e non si percepiscono la stanchezza, la fame, e gli stimoli esterni: si è del tutto immersi nel raggiungimento dell’obiettivo.
Se le energie sono quasi esclusivamente dirette verso il compito, ne restano meno o ben poche per la cura delle relazioni, anche se in molti casi esse possono essere vitali per lo svolgimento ottimale dell’attività stessa. Al contempo l’attenzione, la consapevolezza, il rispetto di sé e dei propri tempi, diminuiscono vertiginosamente. E come si fa a rispettare chi ci sta intorno se non rispettiamo neppure noi stessi?
Il rispetto nasce da noi, verso di noi, e si estende di riflesso anche verso chi ci sta intorno, perché lo si considera degno di attenzione e di valore. Le filosofie orientali sostengono che il rispetto possa nascere solo dall’attenzione, dall’osservazione piena, profonda e non giudicante nel momento presente. È chiaro che se siamo proiettati nel futuro verso un obiettivo, se siamo in ansia per il suo raggiungimento o preoccupati per gli insuccessi passati, l’attenzione viene distratta da altro.
La buona notizia è che il rispetto è una sorta di strada a due vie: lo si riceve nella misura in cui lo si dà. Se non lo offriamo difficilmente lo possiamo ricevere, ma si può infrangere questo eventuale circolo vizioso offrendo rispetto noi per primi.
Se facciamo un giro in libreria o navighiamo un po’ nel Web ci accorgiamo che ci sono decine e decine di pubblicazioni su come essere ben educati e rispettosi al lavoro. Il rischio di queste prescrizioni, però, è quello di creare atteggiamenti posticci, basati sull’apparenza, maschere che alla lunga finiscono con lo stringerci troppo e ingabbiarci. Crearsi una cultura sulle possibili regole più appropriate in diverse circostanze può essere molto utile per non sentirsi a disagio e non creare fastidio a chi ci circonda, ancora più se di età, sesso, cultura, nazione diversa dalla nostra. Tuttavia, a mio avviso, non basta.
Lavorare sulla consapevolezza nel momento presente, al contrario di regole che spesso rimangono astratte, può veicolare grande leggerezza, perché permette di creare una dimensione interiore priva di giudizio, ricca di accoglienza e disponibilità ad apprendere da chi è diverso da noi. Da questa disposizione interiore il rispetto può nascere spontaneo, senza alcuno sforzo.
Come cambiare linguaggio per coltivare il rispetto e le buone relazioni?
Il mondo ci appare esattamente come siamo noi. Se cambiamo atteggiamento mentale, modo di pensare e di parlare, anche il mondo ci può apparire in modo assai diverso.
Secondo Hollman e Yates esistono 11 categorie di parole capaci di alimentare il rispetto. Riformulare le frasi avvalendosi di parole positive può aiutare a creare una cultura basata sul riguardo reciproco. I ricercatori hanno applicato questo metodo in famiglia e a scuola, ma può essere efficacemente esteso anche negli ambienti di lavoro. Approfondiamo quindi il linguaggio del rispetto:
- Parole di incoraggiamento: anziché lamentarsi e criticare i colleghi, si possono formulare frasi di ammirazione in cui si sottolineano le risorse, le potenzialità, i comportamenti più edificanti. I dipendenti, se si perdono d’animo, rinunciano a mettersi in gioco e si dichiarano incapaci.
- Parole di grazia: invece di rimproverare un errore compiuto, una dimenticanza, una scortesia, offrire la possibilità di rimediare. La persona non coincide con il suo comportamento: non siamo quello che facciamo. È possibile concedere nuovamente fiducia, perdonare e dare la possibilità di fare meglio la prossima volta. Solo con la fiducia e l’incoraggiamento un dipendente può crescere e migliorare, umanamente e professionalmente.
- Parole di guida: non limitarsi a sperare che i colleghi o i dipendenti trovino da loro stessi la strada per svolgere un lavoro al meglio; incoraggiarli a porre domande, cercare di guidarli pur senza sostituirsi completamente a loro. Accogliere le loro domande, anche quelle all’apparenza più banali e scontate senza farli sentire sciocchi per questo, ma mettersi con sincerità a loro disposizione affinché possano dare il loro meglio al lavoro.
- Parole di rispetto: anziché limitarsi a riconoscere solo i successi e i risultati professionali, creare un clima più ampio di rispetto reciproco in azienda. Fare capire che ogni opinione, contributo e comportamento ha a suo modo un valore, così come ha un valore colui che lo offre. Fare in modo che ogni pensiero, sensazione e gesto venga concretamente rispettato.
- Parole di aspettativa elevata: anziché scoraggiarsi o criticare quando un dipendente o un collaboratore non dà il meglio di sé, incoraggiarlo a immaginare e perseguire obiettivi che lo appassionano profondamente. Fare in modo che ciascuno possa estrinsecare il proprio potenziale, qualunque sia il suo impegno. Lasciare il più possibile la libertà di scegliere i propri obiettivi, pur in sintonia con le necessità aziendali.
- Parole di speranza: anziché limitarsi a focalizzare la propria attenzione alle necessità, e ai compiti da eseguire nel presente, aiutare i dipendenti a immaginare un futuro migliore. Questo atteggiamento può contribuire a mobilitare le energie ottimali al servizio delle attività aziendali, e al tempo stesso a nutrire la soddisfazione interiore.
- Parole di amore: quando si parla ai dipendenti e ai collaboratori, non limitarsi a fare riferimento solo alla mente, ma mirare anche alle emozioni e ai sentimenti. Dimostrare nel concreto che i migliori successi si ottengono mobilitando tutte le proprie energie interiori e mettendole a servizio dei progetti aziendali.
- Parole di relazione: avvalersi di parole capaci di stimolare la collaborazione, la condivisione di esperienze, sentimenti, pensieri e idee, in un clima di confronto e scambio reciproco. È solo nell’integrazione della diversità che possono nascere i progetti più costruttivi e, verosimilmente, redditizi.
- Parole di comprensione: anziché partire dal presupposto di sapere cosa c’è nella mente degli altri, porre domande, ascoltare, con attenzione, empatia, assenza di giudizio. Dimostrare interesse autentico e sincero per quanto si ascolta e prenderlo in seria considerazione.
- Parole di unità: evitare di mettersi su un piedistallo e di dare ordini senza alcuna giustificazione, di considerare giusto solo il proprio punto di vista. Alimentare una cultura di collaborazione, condivisione, di spirito di squadra. Nessuno ha tutte le risposte, neppure un leader, ma tutti a loro modo possono contribuire a costruire la percezione della realtà, la definizione e il conseguimento degli obiettivi ultimi. Il parere di ciascuno in questo processo ha un valore fondamentale.
- Parole di responsabilità: coltivare il rispetto va di pari passo con il risveglio del senso di responsabilità a cui ciascun dipendente deve essere chiamato. Anziché sorvolare sulle manifestazioni di scarso rispetto o limitarsi a criticarle senza permettere di porre rimedio a quanto fatto, può essere più opportuno far notare quanto fatto e riflettere su come rimediare alla situazione, ponendo le basi per agire diversamente in futuro.
Lavorare sul linguaggio dovrebbe andare di pari passo con l’approfondimento della propria autoconsapevolezza, altrimenti rischia di diventare l’ennesima maschera o dovere a cui ci sottoponiamo; qualcosa che ci rende inautentici e artificiosi per chi ci si avvicina, oltre che l’ennesimo peso da sopportare per noi stessi. Solo questa autoconsapevolezza, di pari passo al meticoloso lavoro sul linguaggio, permette nel tempo di dimostrare appieno le parole che pronunciamo.
Photo by ANVRecife [CC BY-NC-ND 2.0] via Flickr