
Intervistiamo Barbara, vedova di un giovane uomo vittima di un incidente mortale in un cantiere nel 1998: “Un decennio per fare giustizia. E ora nostra figlia lavora nello stesso campo”
Burnout, disturbi del sonno e dell’alimentazione e un’ansia generalizzata. Questi e tanti altri sono i sintomi che possono scatenarsi sul lavoro. Ce ne parla Claudia Campisi, psicologa e career coach.

Salute mentale e lavoro: quanto sono collegati tra di loro? E come i luoghi di lavoro possono contribuire o meno all’equilibrio delle persone?
Che ci sia un maggiore bisogno di servizi psicologici in Italia è evidente dal boom di richieste per il bonus psicologo, così come dal fatto che sempre più Regioni, tra le ultime la Toscana, stanno istituendo la figura dello psicologo di base. Ma riflettiamo mai su qual è il ruolo del lavoro, dei suoi meccanismi, delle sue regole rispetto alla nostra salute mentale? E su quanto stiano pesando lo smart working, il lavoro ibrido, ma anche quel sovraccarico mentale da cui non riusciamo a liberarci?
Per capirlo ne abbiamo parlato con Claudia Campisi, psicologa del lavoro e career coach, che si confronta ogni giorno con varie realtà aziendali, dipendenti e liberi professionisti.
“In una società orientata alla performance, all’ottimizzazione del tempo, al fatto che non ci sia più un unico stile professionale, quello che si sta generando è una sorta di pressione, disequilibrio e affaticamento. Tutte cose che vanno a innestarsi dentro storie di vita molto diverse tra loro, che ognuno affronta con risorse differenti, e che possono portare allo sviluppo di fragilità. Noi pensiamo sempre al lavoro come un mondo ‘unico’, ma quella che entra in gioco è la dimensione individuale del soggetto con cui bisogna fare i conti.”
Dimensione individuale che può portare alle reazioni più disparate: c’è chi, mentre vive una situazione di disagio, presta attenzione ai cosiddetti “segnali” del corpo e si mette in ascolto, e c’è chi invece “rimanda e si concentra solo sul sintomo senza capire che cosa lo sta generando”, precisa la psicologa.
In tutto questo “è come se il contesto professionale fungesse da attivatore. Se infatti consideriamo il lavoro oggi per il valore che ha, ossia come fonte di riconoscimento della persona e della sua professionalità, quando diviene insoddisfacente e non è allineato ai bisogni dell’individuo, diventa una fonte di attacchi alla solidità personale. Viene meno l’autostima e non è più un’opportunità per rispecchiare le proprie competenze”.
Il lavoro va anche considerato nella dimensione più relazionale: “Dobbiamo immaginarci l’ufficio, il reparto, come una sorta di laboratorio sociale in cui ognuno ha la sua storia di vita, il suo ‘zainetto’ di esperienze, e lo utilizza in quel contesto”.
Il luogo di lavoro può essere quindi un attivatore in positivo se le persone sono libere di esprimere la loro creatività, si sentono riconosciute e accettate. “Ma non sempre è così”, sottolinea l’esperta: “Pensiamo a quelle aziende in cui le relazioni ‘tossiche’ compromettono l’equilibrio personale di un soggetto che, anche se è contento del lavoro che fa, preferisce andarsene perché non si trova più a suo agio. In casi come questo, un imprenditore, manager o HR dovrebbe intervenire, perché all’interno di una relazione c’è sempre la possibilità di recuperare un rapporto”.
Tutto questo succede anche quando si lavora in smart working o da remoto?
“Certo, si possono verificare le stesse condizioni, anche se in quei casi ciò che può venire meno è la dimensione dello sguardo. Ci sono molte persone che, nel loro disagio, temono proprio questo, il che si può tradurre nella difficoltà di attraversare uffici con pareti a vetro o muoversi all’interno di open space. Il lavoratore è sempre una persona che, se ha un cattivo rapporto con il suo corpo, se vuole esprimere la sua femminilità in un certo modo, ma teme il giudizio degli altri, si troverà a disagio. Bisogna poi ricordare che il lavoro come laboratorio sociale favorisce il bisogno di riconoscimento e di autorealizzazione che ognuno di noi ha”.
E nell’epoca del narcisismo che stiamo vivendo, è un aspetto non da poco. “Quello che la gente patisce non è solo il non essere ascoltata, ma il fatto di non essere vista. Ognuno di noi vuole sentirsi importante per la sua azienda, per i clienti, ma questo bisogno non c’entra con il lavoro, è personale”.
Ritmi stressanti, alti livelli di competitività, relazioni tossiche e mancato riconoscimento della propria professionalità possono portare quindi a dei disturbi mentali che “non sempre sono ‘colpa’ delle organizzazioni, ma spesso sono risposte che partono dalla storia personale e deviano in un’altra direzione”, precisa Campisi.
“Basti pensare che, secondo una ricerca sul benessere dei lavoratori condotta da BVA Doxa per Mindwork, l’80% degli intervistati e delle intervistate ha riferito di avere provato dei sintomi correlati al burnout”. Che si possono tradurre in sensazioni di sfinimento, calo di efficienza sul lavoro, perdita di contatto con la realtà, assenza di empatia, indisponenza.
“Tutti sintomi che vediamo oggi in ogni tipo di professione, mentre prima il burnout era legato solo alle professioni d’aiuto (medici, infermieri, gli stessi psicologi, solo per dirne alcuni, N.d.R.). E questo perché per molto tempo tutte le professioni sono state spogliate della loro dimensione relazionale. Ma basti pensare a chi fa customer care: è meno a rischio di burnout rispetto a un altro lavoratore a continuo contatto con il pubblico?”
“Tra i disturbi mentali legati allo stato di affaticamento ci sono quelli legati al sonno, così come i disturbi delle funzioni primarie, vale a dire mancanza di appetito, fame nervosa, mangiare continuamente in modo sregolato, che si stanno ampliando notevolmente. Per non parlare poi dell’ansia generalizzata o degli attacchi di panico. Legata al contesto professionale”, aggiunge la psicologa, “l’ansia si tramuta in ansia da prestazione, così come molto frequente è la sindrome dell’impostore (di chi cioè non si sente all’altezza del ruolo che ha e pensa di stare ingannando gli altri, N.d.R.), insieme alla paura di non riuscire a portare a termine un compito assegnato, timore del giudizio altrui e così via. Un lavoratore che si trova a disagio può avere anche difficoltà nel concentrarsi e tendenza a procrastinare: una forma d’ansia che si traduce in una fuga”.
Questo affaticamento mentale non riguarda solo la mente della persona, ma può avere, come dicevamo all’inizio, anche delle reazioni sul fisico. Inoltre, “una persona che non riesce a concentrarsi non è in grado di dare la priorità sul lavoro, di prendere decisioni, capire cosa è giusto e sbagliato. E non sempre è in grado di fare un’autolettura del suo disagio, che può portarla a capire che così non va avanti. È infatti estremamente difficile che da sola ammetta il suo malessere, e lo è ancora di più per chi ha un ruolo manageriale: in questo caso significa riconoscere di non sapere intervenire per risolvere le difficoltà del proprio team”.
La career coach fa poi riflettere su qualcosa che in azienda avviene sempre più spesso, ossia “l’incapacità di mantenere lo scambio relazionale sul compito da svolgere, sul processo per farlo, mentre si porta tutto sempre sul personale, il che comporta una perdita di lucidità. Confrontarsi su cosa non è stato fatto bene, sul non essere riusciti a cogliere la necessità del cliente, permette uno scambio efficace, mentre se si dice a una persona che non ha fatto nulla le si dà la colpa di tutto. Agire in questo modo non porta il lavoratore a confrontarsi sulla sua eventuale mancanza di organizzazione, o su altri problemi oggettivi che può avere”.
Senza dimenticare, poi, che la stessa persona potrebbe accusare il responsabile di non essere riuscito a organizzare il lavoro.
“Tutto questo può creare situazioni conflittuali e cortocircuiti che hanno bisogno di un supporto per evitare che la situazione degeneri.”
Le aziende cosa possono fare e cosa fanno per migliorare la situazione psicologica dei dipendenti?
“Sempre più imprese stanno inserendo tra i benefit la possibilità di accedere a un numero di sedute da uno psicologo”, spiega Campisi. “Le aziende lo chiamano coaching psicologico, o in alcuni casi solo coaching, il che la dice lunga sulla difficoltà che ancora persiste nell’affrontare certe tematiche. Così come ci sono aziende che scelgono dei partner esterni per offrire supporto psicologico. Ci sono poi quelle che non lo danno solo ai dipendenti, ma anche ai famigliari”.
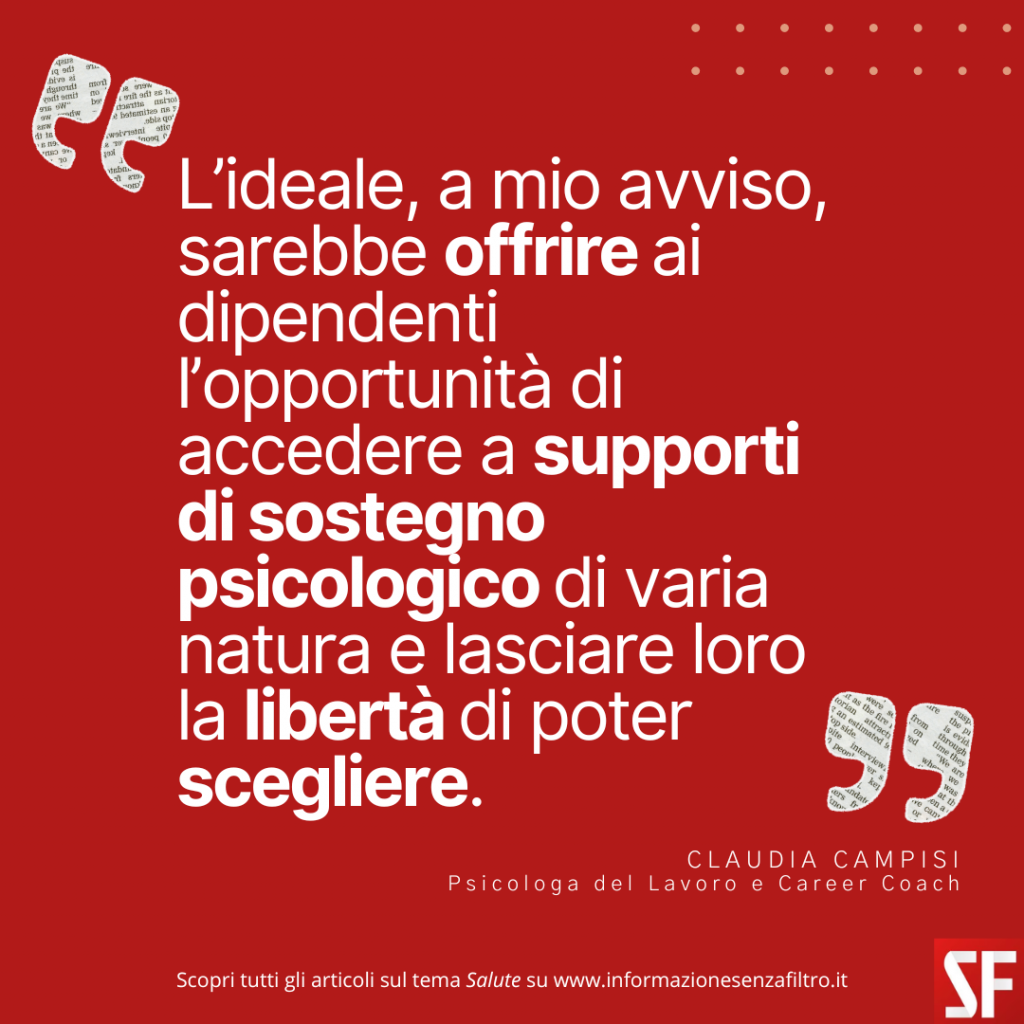
“L’ideale, a mio avviso, sarebbe offrire ai dipendenti l’opportunità di accedere a supporti di sostegno psicologico di varia natura e lasciare loro la libertà di scegliere.
Iniziative simili, infatti, non possono essere inserite come un’alternativa ai ticket per il pranzo o ai buoni benzina, ma ci vuole una vera e propria cultura sulla salute mentale, perché sennò non si lavora sullo stigma”.
Non si supera cioè quella sorta di condanna sociale, colpevolizzazione e senso di vergogna che riguarda chiunque soffra di un disturbo mentale, che non ha ancora la stessa dignità di un problema di salute fisico, né tantomeno si riesce ad affrontare tra colleghi o con i propri superiori: “Non basta solo il welfare, perché se nell’azienda non si parla del tema è come se si piantasse un germoglio nel deserto, e lo stesso servizio, offerto gratuitamente o in convenzione, non prende il via”, chiosa Campisi.
“Tra l’altro non dobbiamo dimenticare che spesso, per accedere a questi servizi, bisogna andare in un certo ufficio, e magari il lavoratore si può trovare di fronte a una persona poco empatica. Se si vuole parlare a tutti, bisogna costruire una cultura di benessere e salute psicologica che preveda più iniziative. Alcune che richiedono uno sforzo economico, come il sostegno psicologico, altre un po’ più soft come libri di self help per i dipendenti, promuovere dei film sul tema e regalare i biglietti per andarli a vedere, invitare un ospite che affronti certi aspetti. L’ideale, poi, sarebbe che ogni azienda avesse un suo psicologo che lavorasse in équipe: il contesto lavorativo è pieno di insidie e va analizzato in ogni suo aspetto”.
Leggi gli altri articoli a tema Salute.
Leggi il mensile 116, “Cavalli di battaglia“, e il reportage “Sua Sanità PNRR“.
L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.
Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.
In copertina foto di Jonathan da Pixabay

Intervistiamo Barbara, vedova di un giovane uomo vittima di un incidente mortale in un cantiere nel 1998: “Un decennio per fare giustizia. E ora nostra figlia lavora nello stesso campo”

Nelle ultime settimane, un articolo dell’agenzia di stampa Reuters ha attratto in maniera ossessiva l’attenzione di alcuni giornali, rimbalzando di testata in testata con articoli condivisi su tutti i social da parte di manager dell’Ottocento, molto compiaciuti. Facciamo un passo indietro.Google nel 2021 si calcola abbia risparmiato grazie allo smartworking circa 268 milioni di euro […]

Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare liberi: intervistiamo l’attivista politico e autore del libro “Il tempo non è denaro”, sostenitore della settimana lavorativa corta di 4 giorni e 32 ore.